Passaggi di stato – Emanuele Braga
Le trasformazioni non sono lineari, arrivano da dinamiche carsiche, da turbolenza nascoste. Poi all’improvviso, i concatenamenti interagiscono e tutto cambia. E non si può più tornare indietro
di: Emanuele Braga
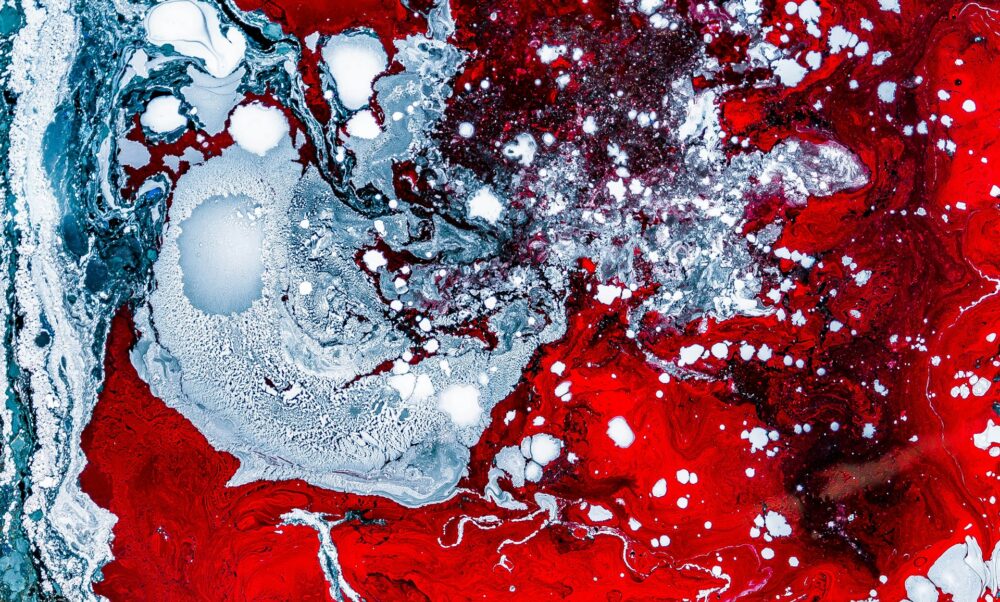
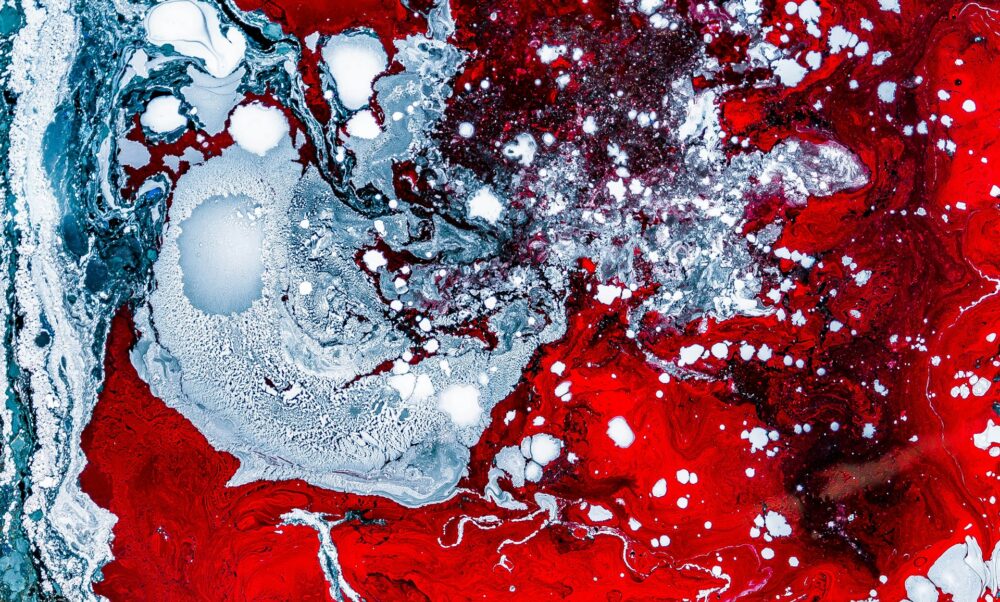
di: Emanuele Braga
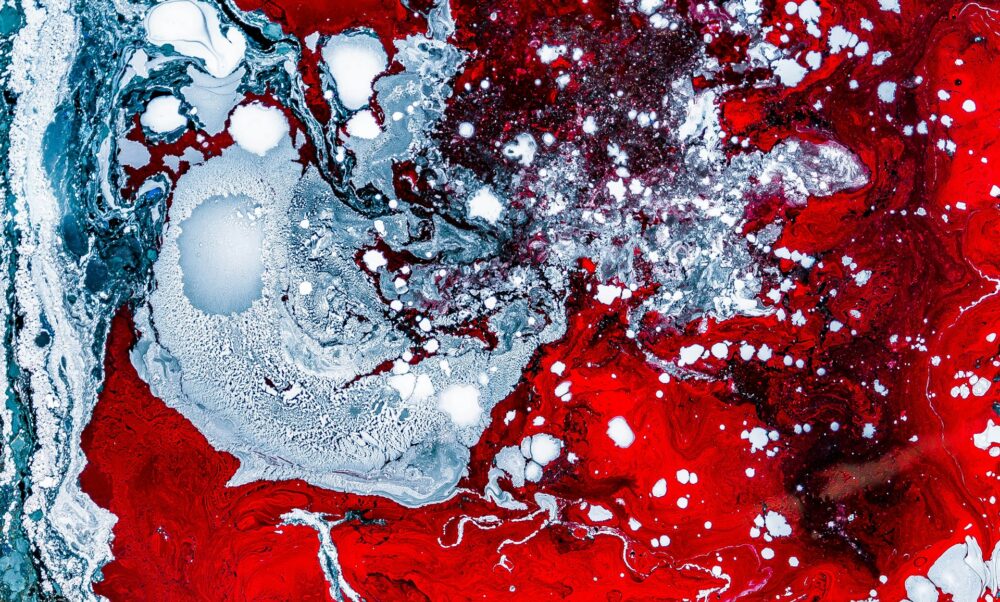
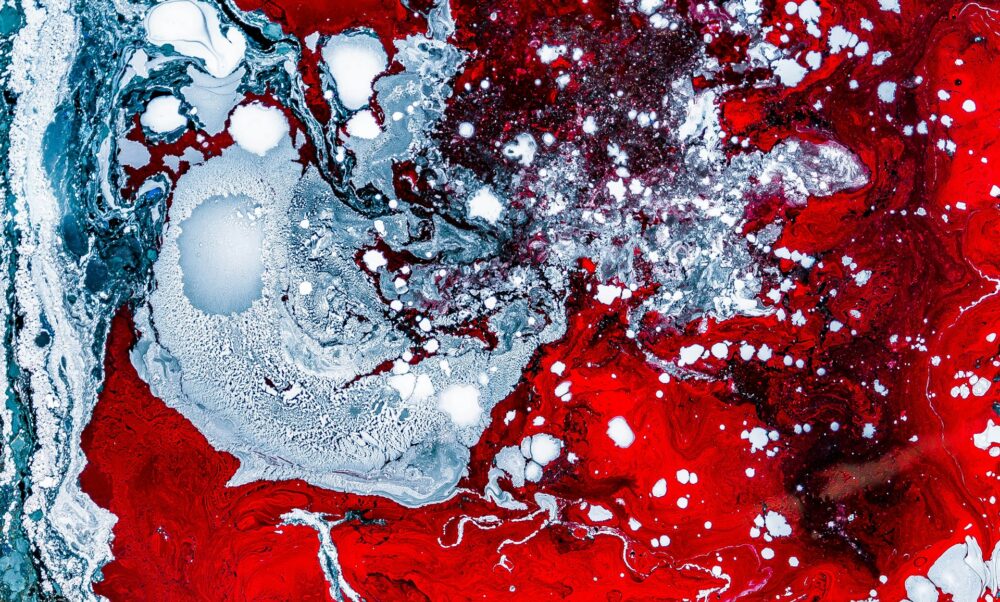
Dal lavoro di Donna Haraway è emerso con forza dirompente e con grandissima capacità mitopoietica il concetto di fare compost. Il luogo della decomposizione organica è lo stesso campo politico del nuovo cominciamento. I cicli vitali sono concatenati e le alleanze si ricreano metabolizzando le potenzialità presenti. L’azione di mondeggiare, fare mondi, a partire dal terreno in cui nello spazio del fallimento si creano le alleanze generatrici, è un’immagine mitologica che ha guadagnato spazio nella lettura del contemporaneo.
Associata al concetto di fare compost c’è anche l’esortazione a stare nel problema. Utilizzare la comprensione, la digestione delle relazioni in essere per comprendere gli spazi di lotta, di cooperazione, di ricomposizione del tessuto politico e sociale nel continuum umano e non umano. Lynn Margulis ha scritto pagine bellissime in cui descrive come l’origine della vita sia avvenuta nello stesso modo.[1] Sul pianeta Terra, milioni di anni fa, inizialmente si crearono i primi cicli retroattivi di organizzazione molecolare, per poi generare i grandi protagonisti indiscussi della vita di tutti i tempi: i batteri.
I batteri diventarono biomassa nei mari e poi ricoprirono le terre emerse. Dopo i primi milioni di anni nei quali generarono la prima forma di Gaia, arrivarono a provocare la prima catastrofe climatica planetaria, saturando l’atmosfera del loro gas di scarico: l’ossigeno.[2] Ebbene sì! La prima forma di vita che «dominò» il pianeta arrivò a saturare l’aria di un gas per lei tossico, che ora noi consideriamo invece di grande importanza. I batteri reagirono a questa catastrofe che stava per annientare la loro specie nascondendosi sotto i loro stessi cadaveri per una spessa coltre, per non venire distrutti da un’atmosfera divenuta per loro invivibile e non essere dissolti dai raggi ultravioletti. Pensate quanto è stato violento e tragico il primo boom demografico sulla Terra, e quanto sarebbe stata turbolenta e critica l’idea di fare compost in quell’epoca.
Dalla strenua resistenza a questo punto limite di collasso tossico nacque fra i batteri un’innovazione: dalla sintesi clorofilliana alla respirazione mitocondriale. Un ciclo biotico fino a quel momento inesistente che trasformò l’ossigeno e gli zuccheri in energia e anidride carbonica. Vorrei allora applicare alla storia le categorie del fare compost e del riciclo. Ebbene sì, in un mondo post-moderno e non moderno, o mai stato davvero moderno, per dirla con Latour, per prima cosa dobbiamo pensare che la storia – e così la storia delle lotte – si sviluppa in cicli nei quali, come abbiamo già avuto modo di vedere, le lotte prendono forma, creano delle innovazioni e poi si riconfigurano nell’ambiente in cui agiscono. Un ambiente contraddittorio, pieno di tensioni e membrane, un ambiente mai pacificato del tutto.
In secondo luogo dobbiamo considerare che il tempo non è lineare, non è sovradeterminato da una unica linea di progresso che, più o meno accelerato, porta a un’unica visione del mondo in cui possiamo decretare la fine della storia. L’intenzione di questo libro è di far risuonare questo approccio e questi concetti con la storia della lotta politica nei movimenti e in particolar modo con i concetti elaborati nel contesto che io più ho vissuto del post-operaismo e dell’autonomia italiana. Seguendo Negri (2017), il rapporto fra composizione tecnica del capitale e forza della cooperazione disegna una sorta di spirale, di cicli e ricicli della storia.
Si è parlato di cicli delle lotte, di fordismo, post-fordismo, di lotta dentro e contro il capitale… ma qual è l’analisi delle forme in cui il soggetto politico della moltitudine può ora organizzare se stesso? Per Negri è utile distinguere tre forme di organizzazione sociale della lotta: uno stadio di esodo o prefigurazione, uno stadio di riformismo radicale, e uno stadio di contro-egemonia.
Lo stadio della prefigurazione e dell’esodo è quello in cui attraverso la resistenza alla forma dell’oppressione si rompono le catene e si produce un’innovazione, una nuova forma di organizzazione della cooperazione. Per dirla nel linguaggio della biologia, è il momento in cui si produce la mutazione. Lo stadio del riformismo radicale è quello in cui queste forme di organizzazione altra si istituiscono, diventano nuove istituzioni, nuove forme stabili di organizzazione e assemblaggio. Diventando nuove istituzioni, devono garantire la loro capacità di autonomia e antagonismo, devono dimostrare di non essere riassorbite dal sistema oppressivo da cui emergono. Lo stadio contro-egemonico è quello in cui le nuove istituzioni antagoniste hanno la forza di ridefinire l’intero ecosistema.
È interessante come Negri (non so se intenzionalmente) dichiari che la prima caratteristica del ciclo delle lotte è il loro movimento carsico, il loro comparire e scomparire in un progresso non lineare. L’evolversi delle forme di organizzazione sociale non è meccanica, come vorrebbe il riformismo progressista, secondo il quale attraverso una presunta razionalità possiamo governare il sociale in modo computazionale e scalabile. A ben vedere, questa è la prima strategia che il capitale adotta nei confronti dell’innovazione che nasce dalle lotte: cerca immediatamente di integrarla come update del sistema dato. Per questo gli chiede di essere scalabile e di essere formattabile a seconda delle interfacce e dei protocolli esistenti.
In fisica i passaggi di stato si chiamano rivoluzioni. Dal solido al liquido al gassoso. Dal ghiaccio all’acqua al vapore. Dal fumo alla lava alla roccia. Quello che succede, in effetti, è che per un lungo lasso di tempo non cambia nulla e poi a un certo punto – che Prigogine chiamerebbe «punto di biforcazione» – cambia tutto. Le rivoluzioni non sono lineari, arrivano da dinamiche carsiche, la turbolenza aumenta ma per tanto tempo non dà alcun frutto. Poi all’improvviso, in modo esponenziale, non lineare, i concatenamenti si allineano e ci si ritrova in un paesaggio del tutto cambiato. E non si può più tornare indietro. E nulla sarà più come prima.
Negri parla spesso dei cicli delle lotte. La resistenza e la lotta al capitale rispondono allo stesso principio di innovazione. Il capitalismo funziona come una macchina astratta che trasforma la resistenza in nuovo contenuto (quale che sia il contenuto). Il capitalismo considera ciò che si mette di traverso, l’eccedenza al programma corrente, l’alterità che nasce dal conflitto, come il suo bene più prezioso. Perché è su questa eccedenza che basa la sua stessa riproduzione. È su questo conflitto che basa il concetto di innovazione. Quanti discorsi fatti con attivistз italianз sul concetto di sussunzione! Tutto quello che abbiamo potuto inventare per sfuggire allo sfruttamento neoliberale lo abbiamo visto rientrare dalla finestra come il nuovo prodotto e motore del capitalismo.
Se l’idea di progresso lineare della storia coesiste con il processo di sussunzione, la linea della storia procede in una sorta di spirale in cui i movimenti di lotta producono l’innovazione che riconfigura la forma di oppressione. È una linea tragica dal punto di vista delle lotte, e stabile dal punto di vista del riformismo progressista neoliberale. Tutti i NO che abbiamo detto sono stati rivenduti nei programmi neoliberali, ma depotenziati della carica conflittuale, mercificati, e via via svuotati di carica erotica.
La critica alla scalabilità (Tsing 2019) è un altro tassello utile da tenere in considerazione per comprendere come l’analisi politica del presente metta in crisi il modello modernista. La scalabilità è un concetto usato dalle politiche progressiste neoliberali perché inserisce il concetto di storia nell’epoca della globalizzazione, in una sorta di spazio e tempo omogenei sul modello della res extensa. Le innovazioni, prodotte in modo situato in un contesto e figlie di determinate lotte, devono poter essere messe a sistema ed essere valide per tuttз, per qualsiasi spazio e per l’eternità. Questo stesso processo di astrazione fa parte del processo di sussunzione. Anche la forma del tempo della scalabilità deve essere omogenea e lineare. Bisogna dare a tuttз il tempo di essere normalizzatз secondo il nuovo protocollo.
In Questo Pianeta, Laura Conti racconta di come si è evoluta la dimensione della cellula. Cerca cioè di spiegare il motivo per cui noi umani, organismo pluricellulare complesso, non siamo un’unica grossa cellula di 70 kg bensì un insieme di miliardi di piccole cellule interconnesse. Laura Conti dice che la comunità scientifica di microbiologз pensa che ciò sia dovuto al fatto che il volume e la superficie di una sfera non crescono in modo proporzionale. La cellula ha evoluto la propria grandezza in funzione dei rapporti di traspirazione. Occorreva cioè avere un determinato rapporto fra volume e circonferenza per permettere che gli scambi fra molecole portatrici di ossigeno dall’esterno fossero in grado di non far fermentare i processi metabolici interni. E per questo motivo c’è una dimensione ottimale della cellula superata la quale c’è troppa poca superficie rispetto al volume interno in relazione al bisogno traspirante.
Insomma la membrana cellulare di una sfera di 70 kg non assicura lo stesso ossigeno e la stessa traspirazione di attività metabolica a tutto ciò che avviene nel suo contenuto. La soluzione è stata quindi decentralizzare il rapporto traspirante in tantissime piccole cellule che si interconnettono tra di loro. In questo ultimo caso c’è molta più membrana traspirante in rapporto allo stesso volume complessivo. Non tutti i processi sono scalabili, e per questo è necessario decentralizzare e diversificare la divisione del lavoro. Questa dinamica mi sorprese anche nell’organizzazione di movimenti sociali e nell’autogestione di comunità dal basso.
Quando nell’attivismo politico si passa dall’insurrezione all’organizzazione, e dall’organizzazione alla piazza, e dalla piazza all’autogestione di servizi di mutuo aiuto e alle cooperative sociali, ben presto ci si rende conto che avere una unica forma organizzativa a volte è impossibile. Dico a volte, perché in alcuni casi si generano le condizioni di possibilità per organizzazioni a vastissima scala, in altri casi è del tutto fuori luogo pensare che ciò sia applicabile.
Quando, ad esempio, nel 2012 in Italia passammo dalla forma organizzativa delle assemblee di artistз e lavoratorз, che discutevano di precarietà e crisi del sistema pubblico, alla forma dell’occupazione e della piazza, ci accorgemmo che era avvenuto un passaggio di scala. Da assemblee settimanali di poche decine di persone in ascolto reciproco, che si conoscevano relativamente, si passò a masse di migliaia di persone che necessariamente non potevano conoscersi tutte. Quando poi occupammo il grattacielo di Torre Galfa per trasformarlo in un museo autogestito, cioè in una nuova istituzione artistica anticapitalista, ci accorgemmo che le persone si autogestivano in tavoli di lavoro, ognuno con una diversa agenda, cercando di comunicare fra di loro, per poi individuare alcuni organi di coordinamento e infine confluire periodicamente in un’assemblea generale. Ci accorgemmo che anche nell’auto-organizzazione non si può ricorrere a un unico modello scalabile.
Certi tipi di auto-organizzazione possono funzionare solo fra gruppi di persone che si conoscono, che sanno instaurare processi di cura e convivialità basati su rapporti di fiducia e un circuito affettivo che sarebbero impossibili da instaurare sulla scala di centinaia, migliaia o milioni di persone, senza scadere nel populismo e in un fideismo superficiale. Altre chiamate tattiche o alcune parole d’ordine hanno invece bisogno di uscire dai localismi e dalle dinamiche comunitarie o identitarie, per avere la forza di coordinare movimenti di massa, come è il caso della costruzione di consenso allargato attorno all’emergenza climatica. In questi casi è necessario un certo grado di genericità, come diceva Aristotele nella Retorica, la potenza del per tuttɜ e per lo più. La costruzione del senso comune passa anche attraverso questo grado di approssimazione generale, di facile accessibilità, di capacità di porre una questione in modo assertivo «senza entrare troppo nei dettagli».
Avere un approccio critico alla scalabilità significa avere coscienza e rispetto di questa turbolenza di diversi piani di consistenza, che sono sempre cooperanti, sono sempre interdipendenti e in compresenza. Significa anche non avere un approccio dogmatico, ideologico o forzatamente solo leninista, nell’organizzazione politica antagonista. Per questo motivo in molte discussioni fra attivistз si discute di un modello federativo delle lotte e delle singole istanze, guardando con scetticismo un’eccessiva centralizzazione della governance, anche nei rari casi in cui gli obiettivi sono condivisibili.
Tornando al tema principale di questo libro, la fisica contemporanea non ci insegna un concetto di tempo lineare e scalabile in un unico spazio omogeneo. Credo infatti che anch’essa si muova con lo stesso metodo, cioè tenendo in considerazione che il sistema nel suo complesso contiene una biodiversità di dinamiche infinitamente diversificate e che vive di velocità e accelerazioni multiple. Prigogine e Stengers, infatti, parlano di non linearità dei processi nell’analisi dei sistemi di dissipazione, e cioè nella teoria fisica termodinamica che interpreta come si creano forme di organizzazione e stabilità a partire da dinamiche complesse di sistemi in grande turbolenza.
Prigogine introduce il concetto di punto di biforcazione, per cui in un sistema turbolento, nel quale nulla sta prendendo forma, in un dato momento si auto-organizza una forma stabile. Nel contesto sociale avviene qualcosa di simile: improvvisamente tutto il potenziale che fino a quel momento sembrava assente comincia a concatenarsi in una nuova forma. Un’invenzione politica, auto-organizzata, contenuta nei rapporti di forza del sistema stesso. Il modo in cui si concretizza e si realizza non segue mai una temporalità lineare, ma è improvviso, ha la forma dell’evento, e accelera la propria formazione a velocità esponenziali. Il concetto di biforcazione emerge in tanti momenti anche in Negri, che forse lo deve più di tutti a Félix Guattari, in quell’intreccio che lega le loro vite sia per la loro storia di dissidenti politici sia per la loro complicità nel cospirare dal punto di vista teorico.
Forse il concetto di biforcazione e quello di passaggio di stato potrebbero ispirare la differenza che percepiamo osservando, da una parte, il processo con cui il capitale metabolizza le forme di lotta e resistenza attraverso la dinamica della sussunzione e, dall’altra, la soglia oltre la quale i processi di istituenza riescono a imporre un passaggio di stato rivoluzionario, e quindi sistemi non più capitalisti. In questo senso dovremmo imparare a distinguere le rivoluzioni mercificate da quelle sostanziali. Proprio perché il capitale sussume, reintegra qualsiasi innovazione in mercificazione, è diventato ormai difficile percepire la differenza tra qualcosa che è venduto e promosso come rivoluzionario e la rivoluzione vera.
Marco Baravalle ha sistematizzato questa idea riflettendo sul concetto di istituenza nell’ambito dell’arte contemporanea, mostrando come dall’attivismo nascano nuove istituzioni autonome e antagoniste, mentre il sistema dell’arte tende a tradurre e aggiornare i programmi e le modalità produttive attraverso le nuove istituzioni governamentali politicamente impegnate. Ma a fianco di questo movimento virtuoso del divenire istituzione della produzione artistica, c’è un processo ancor più egemone di mercificazione dell’arte come qualcosa di continuamente eccezionale.
Lo vediamo, per esempio, nel rapporto fra arte e tecnologia. Il fatto che la costruzione di un evento di arte contemporanea stia col tempo diventando un’occasione per acquistare visibilità e acquisire contatti nella sempre maggiore evaporazione della produzione dei contenuti, ha determinato che oggigiorno le gallerie non abbiano più bisogno di uno spazio fisico, e che sia del tutto naturale lanciare una mostra su Instagram, che lз giovani artistз percepiscono con quella sensazione effervescente di novità tipico della rivoluzione. Il sottotesto del capitale sembra sempre essere: adesso cambierà tutto! Mentre invece non c’è proprio niente di nuovo. In ciò non vedo nulla di strano: era ormai evidente che l’opera d’arte in sé, il territorio, il paesaggio, la comunità in cui si inserisce e la soggettività che la esprime stessero diventando del tutto marginali e inconsistenti per il circuito mercificato del sistema dell’arte.
L’opera d’arte è diventata da tempo un feticcio, un inutile pretesto per aumentare la valorizzazione reputazionale dell’autorə e dellз curatorз, e la speculazione del collezionismo. Quindi, cosa meglio delle piattaforme social digitali può essere lo spazio giusto per una mostra. In effetti, se è così non c’è bisogno di altro. Ma lз giovani curatorз e artistз pensano di essere innovativз se partecipano a una mostra su Instagram. Pensano di aver rivoluzionato il mercato dell’arte se associano a una loro opera (per lo più dal contenuto inesistente) un NFT. Perché questo tipo di involuzione è percepita continuamente come rivoluzione?
Gli schermi scintillano sui dispositivi mobili, la superficie luccica. Luccica come l’oro. Anche Panzieri, attivista e teorico dell’operaismo italiano parlava del nodo contraddittorio delle catene d’oro. Del problema di quando i rapporti di schiavitù e sfruttamento sono mediati dalla promessa del privilegio. Quando le catene che legano e costringono lə schiavə sono d’oro. Quando la mercificazione di oggetti dall’alto valore feticistico tende a coprire e invisibilizzare i bisogni disattesi e a mortificare la macchina desiderante. Catene d’oro. Come nel Seicento, il periodo di maggior sviluppo del colonialismo europeo, quando l’arte barocca ostentava una sovrabbondanza di oro, l’oro che si ripiegava in mille drappi per nascondere i rapporti di forza coloniali.
Ma perché questa involuzione, o sviluppo logico del processo di sfruttamento, viene percepita come innovazione e ricchezza? Il punto quindi sembra essere che l’idea di storia propria del capitale sia lineare, globale e progressista, e che cerchi di trasformare qualsiasi resistenza e lotta in innovazione da mettere a sistema in un processo scalabile a suo vantaggio. In quest’epoca, le politiche culturali neoliberali rendono sempre desiderabili le rivoluzioni, ma in forma feticistica e mercificabile. Il capitalismo cattura il fantasma della rivoluzione per poterlo mercificare. Se questo è il modo in cui il capitalocene[3] neutralizza le rivoluzioni e allontana il punto di biforcazione sostanziale, come si può spezzare questa spirale?
C’è addirittura chi, di fronte a questa distorsione percettiva, dice: acceleriamo! L’unico modo per cambiare questa tendenza è mandare il mondo al punto di rottura. Finiamo tutto il petrolio il prima possibile! Mandiamo le temperature alle stelle! Speriamo che la catastrofe arrivi prima che io muoia! Arriviamo il prima possibile al punto di collasso, almeno sarà evidente la rottura, e ci sarà una svolta. Negli ultimi anni c’è chi ha coltivato questa sorta di desiderio di accelerare l’apocalisse. Se i processi che non fanno che peggiorare i rapporti sociali produttivi e riproduttivi sono continuamente venduti e percepiti come nuovi, emozionanti e inaspettati, non ci rimane che aspettare la fine. È questa la posizione di un accelerazionismo apocalittico post-moderno: non c’è soluzione, non c’è possibile reazione o rivoluzione di fronte alla pervasività delle dinamiche di soggettivazione capitalista. Anzi, l’unica soluzione è accelerare, stare al gioco, buttare benzina sullo stesso fuoco, per anticipare il suo collasso.
Ma se questo controllo soma-semiocapitalista delle nostre soggettività e del nostro desiderio si sta esprimendo sempre più attraverso la mediazione digitale, tutto ciò dove ci porta? Dove ci porta accelerare lo stato di turbolenza che provoca questo tipo di dinamica?
Da un punto di vista estetico, negli ultimi trent’anni di storia dell’arte contemporanea abbiamo visto lo stesso campo di battaglia. Quando le grandi ideologie si sono dissolte prendendo a martellate il muro di Berlino, quando le catene di montaggio delle fabbriche hanno lasciato il posto alla digitalizzazione del vivente e alla classe creativa, fra noi artistз tutto sembrava essersi liberato, e il processo artistico era divenuto una sorta di pratica della ricombinazione dei codici.
Dagli anni Novanta nascono le estetiche relazionali, la net art, la media e post-media art, l’arte partecipativa, l’arte situata, nasce la figura dellə curatorə come meta-cura del processo artistico, nasce l’artista manager, dalla critica istituzionale l’innovazione istituzionale, l’arte come processo di invenzione di governance e scultura sociale, l’arte come cura dei processi sociali… I codici esplodono e i territori propri dell’arte (visiva, sonora, della scultura, della scrittura) si mescolano e diventano funzionali ad altri campi estetici. Credo che questa vitalità nel generare nuovi assemblaggi sia positiva, ma che viva di un’ambiguità. Spesso è stata valorizzata, nello spirito post-moderno, come l’ennesimo nuovo stile da comprendere e mettere a valore all’interno del sistema neoliberale.
Abbiamo fatto l’errore di voler politicizzare il post-moderno, portarlo al suo estremo, e abbiamo ottenuto solo l’estetizzazione della lotta come nuovo prodotto mercificabile da mettere in vetrina. Perciò dovremmo rifuggire qualsiasi tentativo che tende a trovare un valore politico nel post-moderno. Il rapporto fra arte e attivismo è radicale e non mercificabile, e si fonda sul rifiuto dell’idea che tutto sia un interessante gioco combinatorio che esprime possibili scenari virtuali, stando solo all’interno di un gioco linguistico e simbolico. Non ci interessa giocare coi codici, ci interessa lottare per un mondo diverso. I codici alternativi nascono solo attraverso questo processo di lotta. Se vale la pena inventare codici e generare linguaggi è solo perché vale la pena agire le lotte e i rapporti di forza materiali che esprimono.
Bert Theis, sub-curatore di Isola Art Center – un progetto di arte e attivismo contro il piano di gentrificazione di Milano nei primi anni Dieci di questo millennio, caro a moltз intellettuali, artistз e attivistз europeз contemporaneз – ci fece una domanda nell’ultimo seminario che tenne in Sud Italia, dal titolo Isola Utopia: cosa ne pensate del concetto di balzo di tigre così come è espresso da Walter Benjamin in Sul concetto di storia? Il giorno dopo che ci fu posta quella domanda, me ne dovetti andare perché stavano sgomberando il Teatro Valle Occupato a Roma, uno dei progetti a noi più caro in quegli anni, e non ebbi mai più modo di rispondere a Bert, che morì pochi anni dopo. Perciò ci provo adesso.
Nella sua XII tesi, Benjamin dice una cosa: solo l’oppresso può avere la coscienza della storia. C’è una storia normalizzata dai vincitori che tende a replicare un perenne stato di eccezione, ma che ferma il racconto della storia in una sorta di costellazione che mantiene in essere la classe dominante. È bella questa immagine in cui la storia si riproduce attraverso forme cristallizzate, attraverso costellazioni, in modo geometrico. Non può che essere la semplificazione di un continuum che non potremmo mai esaurire o spiegare. Il passato balza nel presente come balza la tigre, e lo fa in forma di costellazione. Ma mentre le mode ripresentano il passato nel presente continuando a confermare la classe dirigente, quando è l’oppresso a balzare nell’attuale, lo fa sotto forma di rivoluzione. Questa è una possibile risposta all’impasse che dipingevamo in questo capitolo. Il vincitore cerca di normalizzare la storia attraverso continui stati d’eccezione (il feticcio della rivoluzione di cui parlavamo) ma la vera rivoluzione può balzare nel presente solo se è la storia dell’oppresso. Solo l’oppresso può sbloccare la storia. Abbiamo ricordo del passato solo e sempre come immagini improvvise, schegge, e di solito sono schegge di pericolo, momenti di oppressione. Col balzo di tigre di Benjamin, il passato balza sul presente rompendo il continuum del progresso tecnico. Il passato si concretizza in forma di costellazione. L’origine dà l’imprinting alla meta. Prefigura. La prefigurazione è quel momento in cui il passato prende forma spezzando il continuum nel presente.
Ma non tutte le rotture sono positive. Anche i nazionalisti di inizio secolo hanno rotto con la tradizione riconfigurando il presente. Lo diceva anche Félix Guattari in Rivoluzione molecolare, in particolar modo commentando la fase storica contemporanea, caratterizzata dall’aver sostituito i grandi totalitarismi dello Stalinismo e del Nazismo con socialdemocrazie sempre più neoliberali, incanalando così il controllo disciplinare attraverso la divisione, la frammentazione, l’individuazione dei soggetti. Siamo in una fase in cui il controllo del desiderio di soggettività ci viene spacciato per libertà. La risposta a questo piano di consistenza è un processo di deterritorializzazione fascista, un movimento molecolare che cerca di destrutturare il monopolio socialdemocratico neoliberale, progressista e universalista attraverso desideri di sovversione che si richiamano alle identity politics e ai miti reazionari e fascisti.

[1] «we are symbionts on a symbiotic planet, and if we care to, we can find symbiosis everywhere. Physical contact is a nonnegotiable requisite for many different kinds of life», Lynn Margulis, Symbiotic Planet. A New Look at Evolution (1998). Il fenomeno della simbiosi fu portato da Lynn Margulis al centro della ricerca biologica negli anni Sessanta, con la sua teoria della simbiogenesi, un paradigma dirompente perché confuta una diffusa assuefazione di stampo neodarwinista al concetto di competizione e selezione correlato al modo in cui i geni diventano predominanti nel processo evolutivo. Lynn Margulis invece dice: è la simbiosi, non la competizione, che fa evolvere le specie viventi. Un’idea rivoluzionaria, che tradotta in senso comune significa: la scienza ci insegna che vince chi meglio collabora, non chi è più competitivo. Mentre la scienza sembrava affermare che il mondo gira attorno alla legge del più forte, le ricerche di Margulis dimostrarono che No: la scienza dice che vince chi sa meglio adattarsi stabilendo relazioni di interdipendenza innovative con l’ambiente. Gran parte della vita – e forse anche la prima forma di vita complessa – evolve dalla cooperazione, non dalla competizione. «Symbiogenesis, an evolutionary term, refers to the origin of new tissues, organs, organisms – even species – by establishment of long term or permanent symbiosis.» Margulis ribalta del tutto il punto di vista della teoria dell’evoluzione. Se l’evoluzione si basa sull’essere simbionti, noi (esseri umani pluricellulari) siamo il risultato di un lignaggio durato milioni di anni, una raffinatissima opera architettonica di batteri. I nostri corpi sono enormi cattedrali e palazzi disegnati per far cooperare e meglio gestire processi metabolici di microorganismi che preesistevano alla nascita dei nostri regni e delle nostre specie. Siamo esseri umani, siamo opera complessa di ingegneria genetica da parte di germi che volevano abitare e hanno disegnato i nostri corpi per meglio cooperare fra loro. In Symbiotic Planet, Margulis racconta anche del rifiuto di queste teorie da parte della comunità scientifica del tempo. Le rispondevano «When you have germs, you have a disease, not a new species». Invece aveva ragione lei, le nostre cellule si sono generate da un rapporto simbiotico con batteri come i mitocondri (che tuttora abitano il cuore metabolico di tutte le nostre cellule), per ottimizzare rapporti traspiranti nel circuito proteico. Con la simbiogenesi Margulis rievoca una inattesa prospettiva lamarckiana sull’evoluzione che supera e include le scoperte di Darwin ma riorientando il paradigma e la chiave di lettura.
[2] In un altro libro, Microcosmos. Four Billion Years of Microbial Evolution, Lynn Margulis e il figlio Dorion Sagan dedicano un capitolo a questa storia dal titolo The Oxygen Holocaust: «the oxygen holocaust was a worldwide pollution crisis that occurred 2000 millions years ago. Before this time there was almost no oxygen in the Earth’s atmosphere. The Earth’s original biosphere was as different from ours as that of an alien planet. But purple and green photosynthetic microbes, frantic for hydrogen, discovered the ultimate resource, water, and its use led to the ultimate toxic waste, oxygen. our precious oxygen was originally a gaseous poison dumped into the atmosphere. The appearance of oxygen-using photosynthesis and the resulting oxygen-rich environment tested the ingenuity of microbes, especially those producing oxygen and those nonmobile microorganisms unable to escape the newly abundant and reactive gas by means of motion. The microbes that stayed around responded by inventing various intracellular devices and scavengers to detoxify – and eventually exploit – the dangerous pollutant».
[3] Seguiamo il posizionamento dellз teorichз che negli anni scorsi hanno sviluppato il concetto di capitalocene in alternativa a quello di antropocene. Il concetto di capitalocene è stato sviluppato in modo indipendente da Andreas Malm, Donna Haraway e Jason W. Moore. Tra le altre proposte alternative al concetto di antropocene ci sono: anthropo-obscene (Parikka), wasteocene (Armiero), chthulucene (Haraway) growthocene (Chertkovskaya e Paulsson), manthropocene (Raworth), entropocene (Stiegler). Abbracciamo qui il termine capitalocene, che attribuisce al capitalismo la responsabilità principale del surriscaldamento globale e la conseguente capacità di definire la prossima era geologica. Il concetto di capitalocene critica quello di antropocene per il suo essere troppo generico e neutrale nel riferirsi all’umanità tutta. Non è l’umano in quanto specie che ha portato al surriscaldamento globale, ma l’ammasso intricato di fattori determinati dall’egemonia di una società capitalista a livello globale che ha innescato una grande accelerazione. Parliamo di accelerazione perché negli ultimi due secoli l’intreccio fra innovazione tecnologica, scelte industriali e finanziarie e consumi energetici delle società tardo-capitalistiche hanno creato quelle condizioni uniche per poter innescare un processo di non ritorno verso un cambiamento climatico catastrofico. Ovviamente il capitalismo si innesta sul neolitico, nel passaggio dalla caccia alla stanzialità, sulle grandi innovazioni legate all’agricoltura e all’allevamento, sui rapporti coloniali e sulla prima ondata di globalizzazione dell’estrattivismo delle risorse da parte dell’occidente bianco ai danni degli ecosistemi dei territori dominati. Il capitalismo si innesta su questa storia, ma ne rappresenta anche un specifica evoluzione e congiuntura che si è sviluppata solo negli ultimi secoli, e che individuiamo anche come la responsabile di un’accelerazione tale da poter determinare le sorti dell’intero pianeta in quanto biosfera. Ne consegue anche che se vogliamo impedire/arrestare/mitigare il cambiamento climatico non occorre prendersela con l’umanità in quanto tale, ma semplicemente cominciare a essere anticapitalisti.
Pubblicato il: 17.01.2024
Articoli, approfondimenti, notizie ed eventi di Accademia Unidee della Fondazione Pistoletto a cura di Marco Liberatore del Gruppo Ippolita