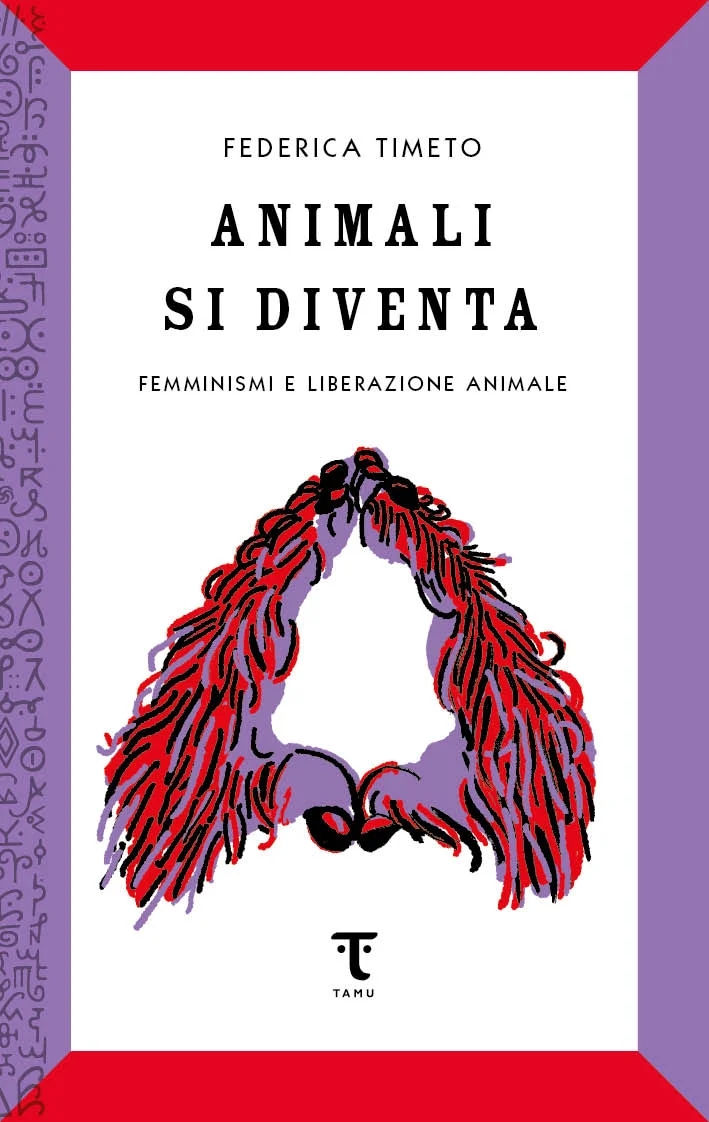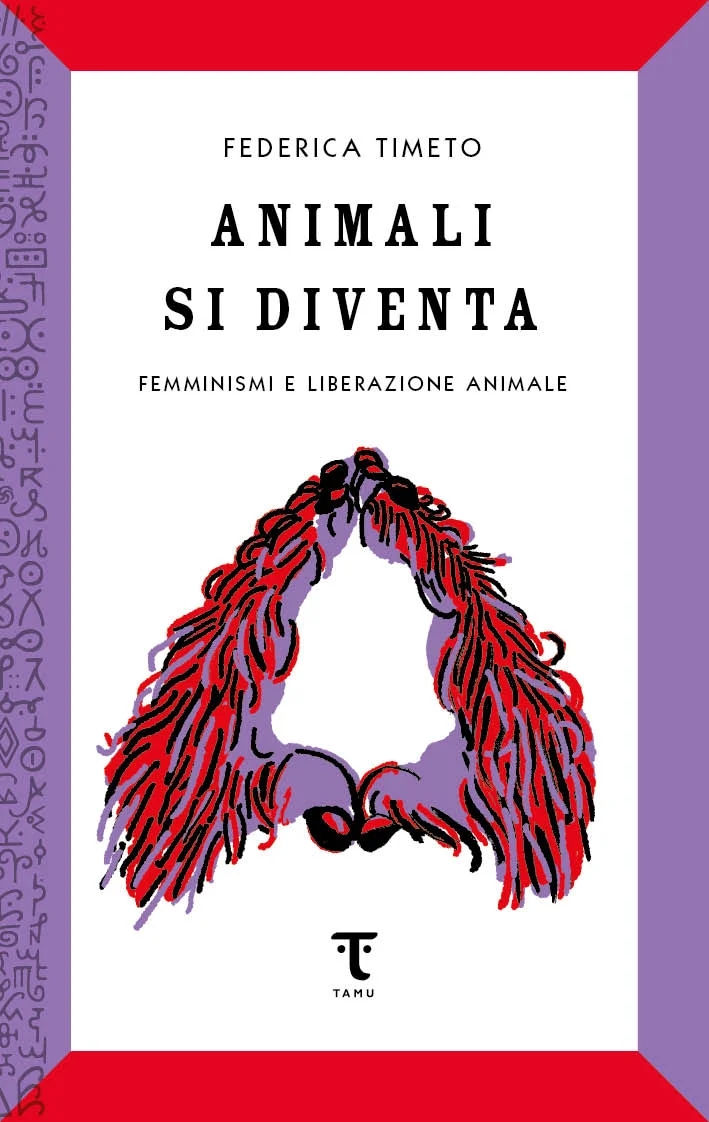Animali si diventa esplora le storie dell’incontro tra antispecismo e femminismo, in un percorso che si lascia alle spalle le idee universali di umano e animale per muovere in direzione della giustizia sociale multispecie. L’autrice, Federica Timeto, è docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia, e da tempo si occupa di studi culturali e studi della tecnoscienza da una prospettiva situata, ecotransfemminista e antispecista. Il volume è edito da Tamu che ringraziamo per la possibilità concessa.
Il sistema di valori su cui poggia la civiltà occidentale è fondato sulla contrapposizione tra l’umano e le altre specie, necessaria all’umano apparentemente non marcato – in genere maschio, bianco e proprietario – per esercitare la supremazia ideologica e materiale sull’alterità animale e su quella «animalizzata», ovvero sullə viventi degradatə alla condizione animale (ritenuta naturalmente inferiore) al fine di poterlə dominare, sfruttare ed eliminare.
Le popolazioni colonizzate sono in questo caso un esempio calzante di come l’ideologia specista abbia nutrito e supportato dispositivi e pratiche di sfruttamento sistemici e su vasta scala, e di come l’esercizio del dominio necessiti di antitesi nette che escludano la possibilità di attraversamenti fra categorie e prospettive non dualistiche; antitesi, come quella fra umanità e animalità, che però non hanno un significato univoco né sono mai impiegate e mobilitate allo stesso modo.
Ancora oggi in Occidente la definizione delle gerarchie animali e delle pratiche che coinvolgono animali eredita e spesso attualizza il retaggio coloniale: basti considerare come l’impiego degli animali nei combattimenti o nei wet market asiatici sia immediatamente etichettato come «bestiale» e incivile, mentre pratiche altrettanto crudeli non sono percepite come tali perché appartenenti alla quotidianità occidentale, e restano quindi invisibili e indiscusse. La categoria di «specie invasiva» è stata ed è ancora richiamata nel discorso pubblico ogni qualvolta si vogliono indicare gruppi umani indesiderati, da respingere o sterminare, creando delle associazioni ricorrenti fra un certo tipo di animali e un certo tipo di umani sulla base del funzionamento inscindibile di razzismo e specismo: il nazionalismo e il colonialismo diventano i pesticidi, e la guerra contro gli animali infestanti si trasforma in guerra chimica contro gli umani ribelli che, sterminati in massa, «cadono come mosche». D’altra parte, nei discorsi di resistenza e liberazione anticoloniali è comune imbattersi in prospettive che insistono sulla stessa opposizione umano/animale, ma capovolgendola di segno e mobilitandola per rivendicare uno status di umanità negato.
Il «marchio della bestia» che categorizza un essere vivente come animale per degradarlo è servito a giustificare le pratiche di sfruttamento e dominio coloniale convertendole nell’ideologia di una differenza naturale, non allineata nei tempi e negli spazi al progresso della civiltà occidentale e a questo sempre ricondotta per contrapposizione. Una differenza necessaria a garantire una riserva di corpi razzializzati-animalizzati come strumento di produzione e riproduzione. Lo stereotipo razziale e quello di specie hanno funzionato come feticci, da un lato rievocando un immaginario arcaico di identità comune, dall’altro esorcizzando e normalizzando la differenza che minacciava la divisione di questa identità.
Lə animali sono come noi, perché anche noi siamo (statə) animali, ma allo stesso tempo lə animali non devono essere come noi, perché come umani non possiamo più comportarci da animali. Quello che Fanon chiama schema «epidermico» (il bambino che lo addita alla madre per strada dicendo «guarda, un negro!») funziona anche quando lo sguardo umano specifica l’animale: distinguendo e omogenizzando in un’unica mossa. Piuttosto che falsificare, dice Fanon, lo stereotipo razziale rende fisso il gioco delle singolarità e delle differenze, ed è così che razza e specie vengono universalmente categorizzate.
L’animalizzazione delle donne nere
Intorno alla metà del ’600 Jacob de Bondt, medico e naturalista olandese che risiedeva nelle Indie Orientali, accompagnava la descrizione dell’Uomo Selvaggio, probabilmente un orango (a lui si deve la denominazione), contenuta nel suo Historiae naturalis et medicae Indiae orientalis, con l’illustrazione di una figura femminile interamente coperta da una pelliccia ferina. A metà ’800, Arthur de Gobineau nel suo Saggio sulla ineguaglianza delle razze umane avrebbe ordinato le specie in relazione alla maggiore o minore prossimità agli animali e al sesso femminile. I
l colore scuro della pelle era considerato una patologia in molte teorie del periodo: il monogenista Blumenbach nel ’700 considerava il colore nero una degenerazione del bianco originario, James Cowles Prichard a inizio ’800 invece sosteneva che la pelle si sbiancasse con l’avanzare della civilizzazione, mentre era diffusa l’idea che la causa del nero fosse una forma di lebbra congenita, che nella versione sessista diventava la sifilide portata dalle prostitute nere. I matrimoni interrazziali erano visti come un’aberrazione che metteva a serio rischio la razza bianca (gli ibridi sono infatti sterili). La categoria di «razza», d’altra parte, arrivava a puntellare quella di specie, già indebolita in ambito zootecnico, per distinguere i diversi incroci animali e pilotarne eugeneticamente i tratti. Comune era anche l’argomento che le persone nere avessero rapporti sessuali con i primati.
Sarebbe stata la primatologia occidentale, agendo come un «orientalismo delle scimmie», secondo un’espressione di Donna Haraway, a organizzare gerarchicamente le differenze della e dalla civiltà in base al genere, alla razza e alla specie. I primati, la specie più prossima all’homo sapiens, rappresentavano la minaccia della degenerazione e dell’arretramento nel mondo naturale ormai superato dall’uomo civilizzato, ma allo stesso tempo continuavano a essere percepiti come un anello di congiunzione con un passato «in comune» ormai perduto, e come tali osservati, studiati e comparati, o alternativamente esibiti, sempre con un misto di attrazione e repulsione, nostalgia e rimozione.
Paura e fascinazione caratterizzavano il gusto esotico che, a inizio del ’900, confluì nel primitivismo, motore del rinnovamento artistico, moda e forma di intrattenimento, in cui l’associazione tra corpi delle donne nere e animali divenne ulteriormente visibile e anche spettacolarizzata.
In occasione dell’Esposizione coloniale internazionale del 1931 a Parigi, Van Cleef & Arpels pubblicizzava un girocollo in oro e avorio esplicitamente ispirato a quello delle persone schiavizzate, mentre Cartier, qualche anno prima, aveva fatto della pantera il marchio della propria collezione di lusso, pubblicizzata dalla performer Josephine Baker che, accompagnata dal ghepardo Chiquita col suo collare di diamanti, incarnava in modo volutamente ambiguo sia la preda che la predatrice, in simbiosi metonimica con l’animale esotico e femminilizzato. Della storia del ghepardo, ovviamente, conosciamo poco, se non che fu regalato a Baker dal direttore del Casino de Paris, cui forse era stato venduto dal domatore e direttore di circo Carl Hagenbeck, l’ideatore degli zoo umani.
Questa istituzione, nata negli anni ’70 dell’800, serviva a una precisa funzione educativa al discorso della nazione, e ogni nazione si dotava di un suo preciso « inventario zoologico»: da spazi privati usati per esibire ricchezza e potere, gli zoo diventarono dispositivi per veicolare l’ideologia suprematista e colonialista esibendo corpi ingabbiati anche umani, razzializzati, sessualizzati e disabilitati, offerti allo sguardo delle famiglie bianche per rassicurarle della propria superiorità, morale e culturale, di fronte alla messa in scena dell’autenticità animale che però doveva restare sempre visibilmente separata e confinata.
Come il genere è stato razzializzato e animalizzato, così la razza è stata sessualizzata e animalizzata: l’uomo nero, la donna nera e anche la donna bianca sono (statə) inferiorizzatə rispetto all’uomo bianco; l’uomo nero anche rispetto alla donna bianca; la donna nera rispetto a chiunque altrə. Tra i corpi neri esposti e ispezionati come bestiame all’asta, le schiave più belle erano vendute sul fancy trade, un mercato sessuale dedicato dove erano valutate in base al loro aspetto, pur restando quella riproduttiva la loro funzione primaria. In alternativa all’appropriazione dei corpi neri più convenientemente schiavizzabili perché usati per il lavoro produttivo e riproduttivo, alle popolazioni dellə nativə toccò un’altra forma di domesticazione, il confinamento in riserve, dove la loro feralità potesse essere altrettanto subordinata e controllata (spesso anche con l’introduzione di animali importatə e a loro volta strumentalizzatə per soppiantare le ecologie ed economie locali).
Nel frattempo le donne bianche in Occidente, nel loro privilegio di non essere materialmente schiavizzate, erano assoggettate all’ortodossia medica che si poneva l’obiettivo di definire la biologia della femmina umana al fine di arginarne le manifestazioni non controllabili: in questa cornice la contraccezione, oltre a dare eccessivi margini di libertà al soggetto femminile nella gestione della propria sessualità, era spesso scongiurata come un potenziale «suicidio razziale» per la popolazione bianca.
Uno degli esempi più tristemente noti di animalizzazione della donna nera è quello di Saartjie Baartman (1789-1815), più conosciuta col nome di Venere Ottentotta (non l’unica esibita come tale, ma la più nota come «oggetto di studio» scientifico) per i suoi genitali allungati a formare il cosiddetto «grembiule ottentotto» e associati alla sessualità «deviante» delle prostitute secondo l’antropologia fisica. In olandese la parola hottentut rappresentava come balbettio la lingua della tribù cui la donna apparteneva.
Comprata e contrabbandata insieme alla pelle di una giraffa, Baartman fu dapprima esibita come un fenomeno da baraccone da un domatore di animali francese cui era stata venduta, poi esposta come esemplare da museo, mentre incisioni ricordo erano vendute al pubblico nei luoghi in cui si esibiva – sia fiere che salotti altolocati –, dove la sua fisicità appariva mostruosa perché fortemente in contrasto con l’estetica neoclassica ancora prevalente.
Le sue spoglie, custodite al Musée de l’Homme di Parigi e finalmente restituite nel 2002 ai griqua di etnia khoisan in Sudafrica, anche grazie all’intervento di Nelson Mandela, erano state dissezionate dopo la morte della donna dal naturalista Georges Cuvier. Baartman era servita da modello, inoltre, per le illustrazioni della Storia naturale dei mammiferi di Étienne Geoffroy Saint-Hilaire e Frédéric Cuvier, pubblicata nel 1829. Dieci anni dopo, il naturalista Samuel Morton descriveva Baartman come «ciò che più si approssimava agli animali inferiori», in linea con l’opinione del tempo, come abbiamo visto nel primo capitolo, riguardo alla distinzione tra uomini e donne.
Anche il presidente degli Stati Uniti Thomas Jefferson, che ebbe sei figli dalla schiava liberata e domestica della famiglia Sally Hemmings, riteneva che le donne africane preferissero gli oranghi agli uomini neri e che ciò fosse segno evidente della loro animalità.
Le persone schiavizzate erano ipersessualizzate per via di animalizzazione: per i neri di sesso maschile a prevalere era l’idea di un insaziabile appetito bestiale (idea molto ben descritta ancora una volta da Fanon in Pelle nera, maschere bianche), mentre alle donne nere si attribuiva una disponibilità costante (analoga alla ricettività che in seguito sarebbe stata « scientificamente osservata» nei primati femmina), che serviva chiaramente a giustificare il sesso non consensuale loro inflitto: lo stupro delle donne nere non era considerato un reato perché queste non godevano praticamente di alcun diritto, né potevano opporsi a unioni forzate con altri schiavi volute dai loro padroni o a separazioni forzate dai familiari causate dalla vendita ad altri proprietari.
Le persone schiavizzate erano però anche desessualizzate per renderle meno pericolose, e tenute a bada come bambinə (in effetti servə) d’adozione o animali addomesticatə. Soprattutto quando fu interrotto il commercio transatlantico, le persone schiavizzate venivano anche «allevate» esattamente come si fa con gli animali «da reddito» per incrementarne la produzione, anche perché i figli e le figlie delle donne schiavizzate nascevano automaticamente schiavi e ciò era estremamente conveniente. Come per gli animali inutilizzabili, infine, anche quando troppo deboli o vecchi, le persone schiavizzate erano spesso «soppresse».
Cavie
Nel 1846 Marion Sims, considerato il padre della ginecologia e l’inventore dello speculum, allestì sul retro della propria casa a Montgomery, in Alabama, un ospedale destinato alle pazienti affette da fistole vaginali, con l’intento di sperimentare una cura. Le pazienti di Sims erano donne schiavizzate delle piantagioni limitrofe, madri precoci, sessualmente abusate e malnutrite, ormai rese «inabili alla schiavitù» a causa della loro patologia. I medici si servivano dello schiavismo e delle sue riserve di corpi, ma è anche vero che spesso non avrebbero potuto sopravvivere economicamente senza esercitare le loro cure sulle persone schiavizzate; il vero paziente finiva per essere il proprietario degli schiavi, che sosteneva economicamente i medici addetti alla «manutenzione» per il proprio futuro tornaconto, mentre le persone schiavizzate funzionavano come pezzi di ricambio (nel caso di Sims, sia come pazienti sia come aiutanti). Senza contare, poi, che molti medici erano essi stessi proprietari di piantagioni. Sui corpi delle sue cavie Sims interveniva inizialmente senza praticare alcuna anestesia, come avrebbe invece fatto in seguito, una volta divenuto famoso, sulle pazienti bianche di New York – con l’eccezione delle irlandesi, immigrate e povere, paragonate alle scimmie tanto quanto le donne nere.
Le sperimentazioni di Sims poggiavano sulla teoria della disestesia etiopica, formulata in quegli anni da Samuel A. Cartwright: questa asseriva che i neri fossero costituzionalmente più inebetiti e dunque insensibili al dolore – una variante della figura dello «schiavo felice» di essere schiavo perché realizzato nella sua vera natura animale. Cartwright infarciva queste analisi pseudoscientifiche di giustificazioni bibliche e riteneva la fisionomia e fisiologia del corpo nero come «inadeguate» alla libertà, arrivando a considerare come patologia il desiderio di fuga delle persone schiavizzate (patologia alla quale diede il nome di drapetomania).
L’uso dei corpi delle schiave da parte di Marion Sims è uno dei tanti esempi simili ormai tristemente noti (è persino entrato nella cultura mainstream, con il remake del film di David Cronenberg Inseparabili, in forma di serie tv « al femminile», che gli ha dedicato un’intera puntata). William Osler Abbott, gastroenterologo della University of Pennsylvania School of Medicine, negli anni ’30 sperimentava un modo rapido per intubare l’intestino usando volontari neri, pagati una miseria, che sottoponeva a radiografie continue per controllare il procedimento e che chiamava «i miei animali».
Noto è ormai anche il caso di Henrietta Lacks, afroamericana di Baltimora di umili origini morta di cancro nel 1951, divenuta inconsapevole «donatrice» – ma effettivamente defraudata – di cellule tumorali. Poi denominate HeLa, le sue cellule sono state replicate e sono usate nei laboratori di tutto il mondo ancora oggi. Ancora più noto è il «caso Tuskegee», un esperimento effettuato su seicento persone nere a partire dal 1932 per studiare il decorso della sifilide, proseguito per quarant’anni anche dopo la scoperta dell’efficacia della penicillina. E ancora: il Depo-Provera, anche nel periodo in cui era completamente proibito come farmaco contraccettivo – a seguito di effetti cancerogeni osservati sui beagles di laboratorio–, continuava a essere usato sui corpi delle donne nere e oggi è somministrato alle donne native americane e afroamericane; il Norplant, un contraccettivo a impianto sottocutaneo, quindi controllato esclusivamente dai medici e che rientra tra i cosiddetti Larc « imponibili» (dove la sigla sta per Long acting reversible contraceptives), negli Usa è stato ed è maggiormente prescritto alle donne nere, molto giovani e povere, considerate meno capaci di autodeterminarsi, spesso in cliniche pubbliche e tramite il sussidio Medicaid.
Ancora oggi è molto comune impiegare le persone detenute per le sperimentazioni mediche, visto che il loro consenso informato può essere più facilmente aggirato.