Vattene, disobbedisci, riorganizzati – David Graeber
Come siamo arrivati a ritrovarci in una situazione in cui non possiamo smantellare qualcosa che non serve più ai nostri scopi?
di: David Graeber


di: David Graeber


Assia Turquier-Zauberman: Abbiamo parlato a lungo prima degli slittamenti tra i differenti sistemi di valori, tra le differenti distribuzioni di potere e di organizzazione sociale, e del gioco necessario ad alternare questi processi.
David Graeber: Per gran parte della storia umana i termini sono stati instabili, fluidi, e a suo modo quell’instabilità era esattamente ciò che definiva la libertà, o almeno così siamo spinti a credere. Come ho già detto, quando David Wengrow e io abbiamo cominciato a scrivere il nostro libro, siamo arrivati rapidamente alla conclusione che di per sé il problema delle «origini della diseguaglianza» fosse abbastanza assurdo. In effetti, sarebbe davvero strano parlare della «diseguaglianza» come di un fattore uniforme delle società umane, qualcosa che si possa misurare con il coefficiente di Gini dall’Era glaciale ai nostri giorni.
Ci sono molti altri modi per individuare le cose che non vanno nel mondo: il capitalismo, il patriarcato, il potere di classe, lo sfruttamento, il dominio… Concentrarsi troppo sulle «diseguaglianze» può portare a un approccio tecnocratico – e liberale – alla soluzione dei problemi globali: bisogna darsi un po’ da fare con i salari, limitandoci però a qualche mezza misura perché noi non vogliamo affatto che tutti guadagnino allo stesso modo in quanto sarebbe folle e totalitario. Ma dal nostro punto di vista il problema non è che alcune persone hanno più cose, ma che queste persone possono trasformare la ricchezza in potere e costringere altre persone a fare cose che non vorrebbero fare, oppure possono creare un mondo in cui ad alcuni si dice che i loro bisogni e le loro idee non contano.
Una delle ragioni per cui la favola sulle «origini della diseguaglianza» ci sembra sensata è perché nella nostra testa abbiamo archiviato una specifica immagine delle popolazioni di cacciatori-raccoglitori (e di conseguenza di tutti gli umani primitivi), ossia popoli come gli Mbuti dell’Africa centrale, o i Boscimani del deserto del Kalahari, o magari gli Hazda dell’Africa orientale. Ma questi popoli, che vivono tutti in piccole bande egualitarie, non sono esempi rappresentativi delle popolazioni storiche di cacciatori-raccoglitori. Il fatto è che nel 1901 – quando Franz Boas stava conducendo le sue ricerche lungo la costa nord-occidentale degli Stati Uniti e lo stesso faceva Baldwin Spencer in Australia (dove le popolazioni indigene vivono in maniera molto differente) – gli antropologi ancora non andavano dietro alle persone con i cronometri, non calcolavano le loro calorie giornaliere e non documentavano tutto su pellicola. Con l’avvento dei «moderni metodi scientifici», le uniche popolazioni di cacciatori-raccoglitori rimaste erano estremamente ridotte ed ormai vivevano come profughi in posti dove nessun altro voleva stare (i deserti, la tundra, ecc.). In compenso, non solo c’era una gran quantità di documentari in circolazione ma alcuni informatori – come Nai e Nisa – erano persino diventati delle celebrità, tutte cose che non potevano non avere un forte impatto. Tanto che la stragrande maggioranza delle persone arrivò alla conclusione che quella fosse l’immagine che dava conto del 95% della storia umana. E anche vari anarchici in questo stesso periodo hanno cominciato a sostenere che la «civiltà» era stata un tremendo errore, che «noi» dovevamo tornare a vivere come i cacciatori-raccoglitori, di solito trascurando di citare o minimizzando il fatto (ammesso esplicitamente tra di loro) che in questo modo il 99,9% dell’attuale popolazione del pianeta sarebbe morta (il che dovrebbe quanto meno sollevare qualche domanda su chi compone quel «noi»).
Così abbiamo cominciato a interrogarci sulle forme di organizzazione, in particolare quelle politiche, che hanno caratterizzato la storia umana. Non sappiamo molto di quel che accadeva, diciamo, duecentomila anni fa – quel periodo è sostanzialmente una lanterna magica in cui le persone proiettano le proprie fantasie mitologiche – ma è possibile analizzare l’Era glaciale e poi fare confronti con la documentazione etnografica… e una delle cose più sorprendenti è che le persone cambiavano completamente le loro strutture sociali nel corso dell’anno.
C’è un bellissimo piccolo libro di Marcel Mauss, il Saggio sulle variazioni stagionali delle società eschimesi, che descrive questo tipo di «doppia morfologia», come lui la chiama. Durante l’estate gli Inuit si disperdevano in piccole bande patriarcali, avevano rigide regole sulla proprietà privata ed erano sessualmente puritani. Ma durante l’inverno si radunavano in microcittà, ricorrevano a forme di proprietà comunitaria e organizzavano grandi orge con scambio di mogli sotto il segno di Sedna, la Signora delle Foche. Le strutture sociali erano insomma completamente diverse nei vari periodi dell’anno. Ed era una soluzione molto diffusa. Le popolazioni studiate da Boas avevano nomi diversi in diversi periodi dell’anno: diventavano letteralmente qualcun altro (uno dei ruoli dei poliziotti-clown era di punire le persone che usavano d’inverno i loro nomi estivi).
Di conseguenza, le persone erano ben consapevoli che le strutture sociali non erano qualcosa di immutabile: potevano essere riorganizzate in maniera diversa (e questo significa che quelle popolazioni erano molto più consapevoli di sé stesse, da un punto di vista politico, di quanto lo siamo noi).
Un altro esempio è quello di Stonehenge. Le persone che hanno costruito Stonehenge erano cerealicoltori che a un certo punto avevano smesso di coltivare la terra per tornare a raccogliere noci (anche se avevano mantenuto gli animali domestici). Questa cosa è accaduta su tutto il territorio delle isole britanniche e io mi sono sempre chiesto come abbiano fatto le popolazioni di allora a coordinare l’intero processo. Le isole britanniche non sono poi così piccole. Eppure, a quanto sembra, attorno al 3000 a.C. si è messo in moto un qualche meccanismo per cui tutti hanno deciso di smettere di coltivare cereali. Beh, una cosa che sappiamo con certezza è che alcune di queste popolazioni vivevano nei pressi di Stonehenge solo tre mesi all’anno. Normalmente vivevano altrove, ma si riunivano in quella zona, vicino ai loro giganteschi monumenti, per i loro rituali di metà inverno, in un periodo in cui a quanto pare avevano un re. Poi tornavano a frammentarsi in piccole bande per il resto dell’anno con i loro animali, vivendo sostanzialmente di noci e bacche. Probabilmente in questa seconda fase i re avevano una vita del tutto simile agli altri membri della popolazione, e così il regno veniva ripristinato e smantellato ogni anno. Verosimilmente è per questo che troviamo tutti quei miti alla Frazer sui re che vengono annualmente uccisi e offerti in sacrificio. A me pare che questa abilità di spostarsi avanti e indietro tra strutture sociali diverse, questa idea che sia possibile riorganizzare tutto nella società (adottare un modello agricolo e poi abbandonarlo, ad esempio), sia qualcosa che noi oggi non saremmo in grado di fare.
Se questo è vero, allora la domanda che bisogna porsi non è tanto «Com’è nata la disuguaglianza?», quanto «Come siamo arrivati a ritrovarci in una situazione in cui non possiamo smantellare qualcosa che non serve più ai nostri scopi?». Tracce di quel modo di fare rimasero nelle feste popolari come il carnevale, durante le quali si sperimentavano strutture sociali alternative che talvolta diventavano il punto di partenza di molte rivolte contadine. Ma questo era solo un pallido riflesso delle forme precedenti.
ATZ: Tutto ciò ovviamente solleva la questione di come siamo arrivati a essere «intrappolati» in una struttura sociale fissa.
DG: E questo essere «intrappolati» comporta di fatto molto altro: comporta essere «intrappolati» in un luogo specifico, in una struttura specifica e in relazioni di dominio specifiche che non si possono facilmente ignorare o aggirare.
Se vogliamo abbandonare l’espressione «società egualitarie», allora la prima domanda da porci è come definire quelle qualità che tanto ammiriamo nelle società indigene o nelle società senza Stato. Cosa hanno in comune gli Mbuti, i Jivaro e i Britanni di Stonehenge (partendo dal presupposto che qualcosa in comune ce l’abbiano davvero)? Io sono arrivato alla conclusione che la cosa migliore è chiamarle semplicemente «società libere». Al di là del fatto che ci siano state o meno cariche politiche formali, o divisioni formali tra uomini e donne, e così via, la cosa per me più sorprendente è che noi umani abbiamo perso nel corso del tempo proprio quelle forme di libertà che un tempo erano del tutto ovvie e che adesso ci sembrano così esotiche da poterle a malapena immaginare.
Vorrei ora elencare, in maniera assolutamente provvisoria (la lista può senz’altro essere estesa e raffinata), tre forme di libertà primordiale. Prima libertà: la libertà di andarsene. Che è anche la libertà di viaggiare. Spesso una porzione significativa delle persone che vivono in una banda di cacciatori-raccoglitori viene da un posto lontano. Noi abbiamo questa idea bizzarra per cui «nei tempi antichi» ogni straniero era considerato un nemico e dunque poteva anche essere ucciso. Ma in realtà in svariati tempi e luoghi erano in vigore delle elaborate regole di ospitalità. In Nord America, ad esempio, dovunque tu andassi avresti trovato altri membri affiliati al clan dell’orso, e in Australia avresti trovato dovunque persone della stessa metà che avrebbero avuto l’obbligo di darti sostegno. Insomma, un tempo non esisteva alcun meccanismo per escludere le persone che decidevano di spostarsi (anche se in seguito, in molti luoghi, le cose sono cambiate, e questo è un altro esempio dell’aspetto semanticamente complesso del termine «cura», che a volte si trasforma nel suo opposto: il termine «ospite», ovvero chi si prende cura dei viaggiatori, è etimologicamente correlato anche a «ostile» e a «ostaggio». Così, se tutti hanno il diritto di andarsene, ci sono però forti limiti alla creazione di relazioni sociali abusive.
Ricordo di aver letto una conversazione tra alcuni antropologi e un amico della Papua Nuova Guinea che stava facendo un viaggio in America. Qualcuno chiese a quest’ultimo se ammirasse le libertà americane. Lui rispose: «In tutta onestà, penso che ci sia più libertà dove vivo io. Guardate quella collina laggiù, starà a cinque miglia da qui. A casa mia, se vedo una collina e voglio vedere cosa c’è in cima, mi basta camminare e arrivare in cima. Qui ci sono mille ragioni per cui non posso farlo».
Può sembrare strano descrivere come una forma di libertà, come un diritto, la libertà di andarsene da qualche altra parte, perché nessuno ne parla così nelle società in cui tutto questo è permesso. Noi ricorriamo al linguaggio, parliamo del diritto alla libertà di movimento, ma questo linguaggio è in gran parte illusorio, dato che il diritto legale di andare, per fare un esempio a caso, in Malesia, non ha alcun significato se non puoi permetterti di pagare il biglietto aereo (per non parlare del viaggio in direzione opposta, dalla Malesia all’Europa o agli Stati Uniti). Solo per potersi spostare molti migranti rimangono indebitati a vita, con conseguenze atroci. Le società che riconoscono davvero il diritto di movimento non usano quindi questo linguaggio bensì parlano di «responsabilità dell’ospitalità». Il tuo obbligo a prenderti cura degli stranieri, visto da un altro punto di vista, rappresenta proprio la tua libertà di movimento.
La seconda libertà è la libertà di ignorare gli ordini, ed è forse quella più importante. Tutte le lingue umane hanno una forma imperativa, un modo per dire «Alzati!» o «Siediti!», ma per gran parte della storia umana chi era incline a dare ordini non aveva alcun mezzo per obbligarti davvero ad alzarti o a sederti se non lo volevi fare. Qualcuno potrebbe dire: «Kondiaronk non veniva da una società egualitaria, perché i Wendat avevano tutto un sistema di cariche politiche e lui stesso agiva come un ministro degli Esteri…». Il che è vero, ma è vero anche che lui non aveva alcun potere per obbligare qualcuno a fare qualcosa che non voleva. I gesuiti ne parlano spesso nei loro resoconti, ribadendo più volte come gli indiani li canzonassero perché avevano paura dei loro superiori mentre, dicevano, «noi ci facciamo beffe dei nostri capi, li prendiamo sempre in giro». Era questo a renderli un popolo libero (ed era questa la ragione per cui le loro figure politiche, come Kondiaronk, dovevano essere molto persuasive).
È interessante rilevare come in questi popoli si trovi un certo «comunismo di base» (o almeno io lo chiamerei così): a fronte di un’assoluta autonomia personale, fortemente rivendicata, ci si affida al contempo a pratiche di mutuo appoggio. In effetti, se tu fossi un mendicante, non saresti libero di fare nulla, anzi potresti facilmente ritrovarti in una situazione in cui non puoi rifiutare di obbedire a un ordine.
Per questo molte antropologhe femministe preferiscono non parlare di uguaglianza delle donne ma di autonomia delle donne. A loro avviso, il punto non è l’eguaglianza di status (anche perché non è chiaro cosa questo significhi in società dove uomini e donne nutrono per lo più un vago disprezzo reciproco): il punto è se gli uomini sono nella posizione, individuale o collettiva, di dire alle donne cosa devono fare o di interferire nei loro progetti.
Pertanto abbiamo la libertà di andarcene altrove e quella di ignorare i comandi. Direi che la terza libertà è quella di poter riorganizzare l’ordine sociale, totalmente, stagionalmente o in vari altri modi. Come ho già detto, i cambiamenti stagionali sono quelli che facilitano la comprensione di questo tipo di libertà, il che spiega tra l’altro perché Montesquieu rimase così impressionato dagli Osage. Siamo dunque rimasti «intrappolati» in almeno tre modi diversi.
ATZ: E quindi? A mio avviso, qui c’è qualcosa che rimanda al potere distruttivo della rappresentazione del capitalismo.
DG: È qualcosa accaduto molto prima del capitalismo. Ma di sicuro si può dire che il capitalismo è la forma più acuta di quel processo che ci ha «intrappolati». E questo anche se il capitalismo tipicamente si rappresenta come il suo opposto, ovvero come qualcosa che scioglie dai vincoli.
ATZ: E allora quand’è che abbiamo cominciato a mettere in scena le nostre rappresentazioni in un modo tale per cui adesso non riusciamo più a smantellarle?
DG: È un pensiero interessante. Pensi che le cose siano andate così? Vediamo… Se cerchiamo degli esempi di rappresentazioni che lasciano indietro la realtà, di rappresentazioni fuorvianti che diventano potenti e cominciano a riorganizzare attorno a sé la società, non è difficile trovarne. Mi vengono subito in mente quattro esempi.
Una cosa di cui mi sono reso conto tempo fa, senza sapere bene cosa farne, era che gli autori medievali, quando scrivevano di politica, davano sempre per scontato qualcosa che richiamava lo Stato-nazione anche se ancora non esisteva niente che gli assomigliasse anche solo vagamente. Gran parte dell’Europa dell’epoca… era in realtà una scacchiera incredibilmente complessa di diverse forme sovrapposte di sovranità. Eppure, se leggete l’epica medievale, o una favola, o un saggio scritto in termini teoretici da un pensatore dell’epoca sulla natura della politica, danno tutti per scontato l’idea di un singolo principe che esercita il potere su un territorio unificato.
Lo stesso accade con la schiavitù. Anche se in realtà c’erano infinite gradazioni di vassallaggio e servaggio, quando se ne parlava in astratto si tendeva a parlare di servi e di padroni. Si parlava del potere come se fosse una cosa incredibilmente semplice e unitaria, ignorando l’esperienza concreta delle persone, infinitamente più sfumata, dove si rinegoziano continuamente i termini dei rapporti gerarchici.
Un terzo esempio ha a che fare… ancora con la pleonexia. La danno tutti per scontata. O per essere più precisi, tutti danno per scontata l’idea agostiniana di una natura umana incorreggibile: siamo creature dotate di desideri infiniti; è questa la nostra punizione per aver disobbedito a Dio; per questa ragione siamo in guerra gli uni contro gli altri e ci mangeremmo come fanno i pesci grandi con i piccoli, se solo non ci fosse la mano salda della legge. Nel Medioevo tutti leggevano sant’Agostino e le tesi da lui sostenute, ma poi tanti non agivano di conseguenza. E la cosa appare più evidente nella sfera economica. Quasi nessuno perseguiva progetti di accumulo infiniti. Come in ogni epoca e in ogni luogo, gran parte delle persone, mercanti compresi, si poneva degli obiettivi economici, avevano un’idea di quel che era necessario ottenere per godersi una «buona vita». Ma quando ci arrivavano, smettevano di lavorare e «ottimizzavano il tempo libero», come direbbe un economista dei nostri giorni, in modo da poter davvero godere di quella buona vita. E questo nonostante aderissero a una teologia che diceva loro che non dovevano farlo. Ovviamente, con il tempo, alcune persone cominciarono a mettere in pratica quella teoria agostiniana. E ci si potrebbe chiedere il perché. Weber suggerisce che questo aveva a che fare con il calvinismo, con la sua ansia incessante per la salvezza, con la sua idea che godersi la vita fosse peccaminoso. Gradualmente questa sensibilità si diffuse, anche se non raggiunse mai tutti. (Detto per inciso, è la ragione per cui è così difficile trovare un taxi quando piove: i tassisti hanno la tendenza a fissare i propri obiettivi economici giornalieri, e quando li hanno raggiunti, cosa semplice da fare quando piove, se ne tornano a casa).
Infine c’è un quarto esempio, decisamente meno medievale. Ricordo di aver letto un saggio di Pierre Bourdieu in cui sostiene che se si legge la teoria dello Stato burocratico in Marx, o in Durkheim, o in Weber, è facile accorgersi che all’epoca in cui loro scrivevano sostanzialmente era sbagliata. Ma con il tempo quelle teorie sono diventate sempre più vere, soprattutto perché chiunque gestisce un sistema burocratico ha fatto dei corsi universitari in cui è stato obbligato a leggere Marx, Durkheim e Weber.
Così abbiamo la sovranità, il dominio, la pleonexia, la burocrazia… e c’è una quinta cosa! Ossia la proprietà privata. Ecco, questo potrebbe essere un ulteriore esempio. Se c’è qualcosa che mi stupisce sempre qui in Inghilterra è la bizzarria del sistema di proprietà. Nessuno sa davvero a chi appartiene la terra. A quanto pare ci sono cinque o sei baroni e duchi che possiedono «in realtà» Londra e ci sono almeno quattro o cinque diversi pretendenti che rivendicano diritti di vario tipo su ogni edificio. Ci sono forme di locazione, diritti sul suolo, proprietà fondiarie e tutta una serie di regole che risalgono al possesso feudale. Ricordo di aver pensato una volta: «Altolà! Ma l’Inghilterra non è stata la prima patria dell’individualismo proprietario, dei moderni diritti di proprietà rivendicati ‘contro tutti’, il primo paese dove le persone hanno riconfigurato i loro diritti e obblighi reciproci in termini di diritti di proprietà esclusiva?». E invece in Inghilterra non esistono diritti di proprietà esclusivi. Ancora oggi. Forse in Scozia, ma decisamente non in Inghilterra. Così la relazione tra pratica e rappresentazione è molto diversa da quella che viene immaginata.
Ecco allora la domanda: le rappresentazioni semplificate hanno alla fine invaso il territorio più complesso della pratica? Marshall Sahlins sostiene ovviamente che la scienza dell’economia, nel suo complesso, è solo una versione secolarizzata della teologia medievale, con alcuni termini invertiti. Nel caso illustrato ha vinto la rappresentazione semplificata. Ma la nobiltà terriera britannica, per contrasto, è stata in gran parte capace di resistere a un tale processo di semplificazione della proprietà terriera.
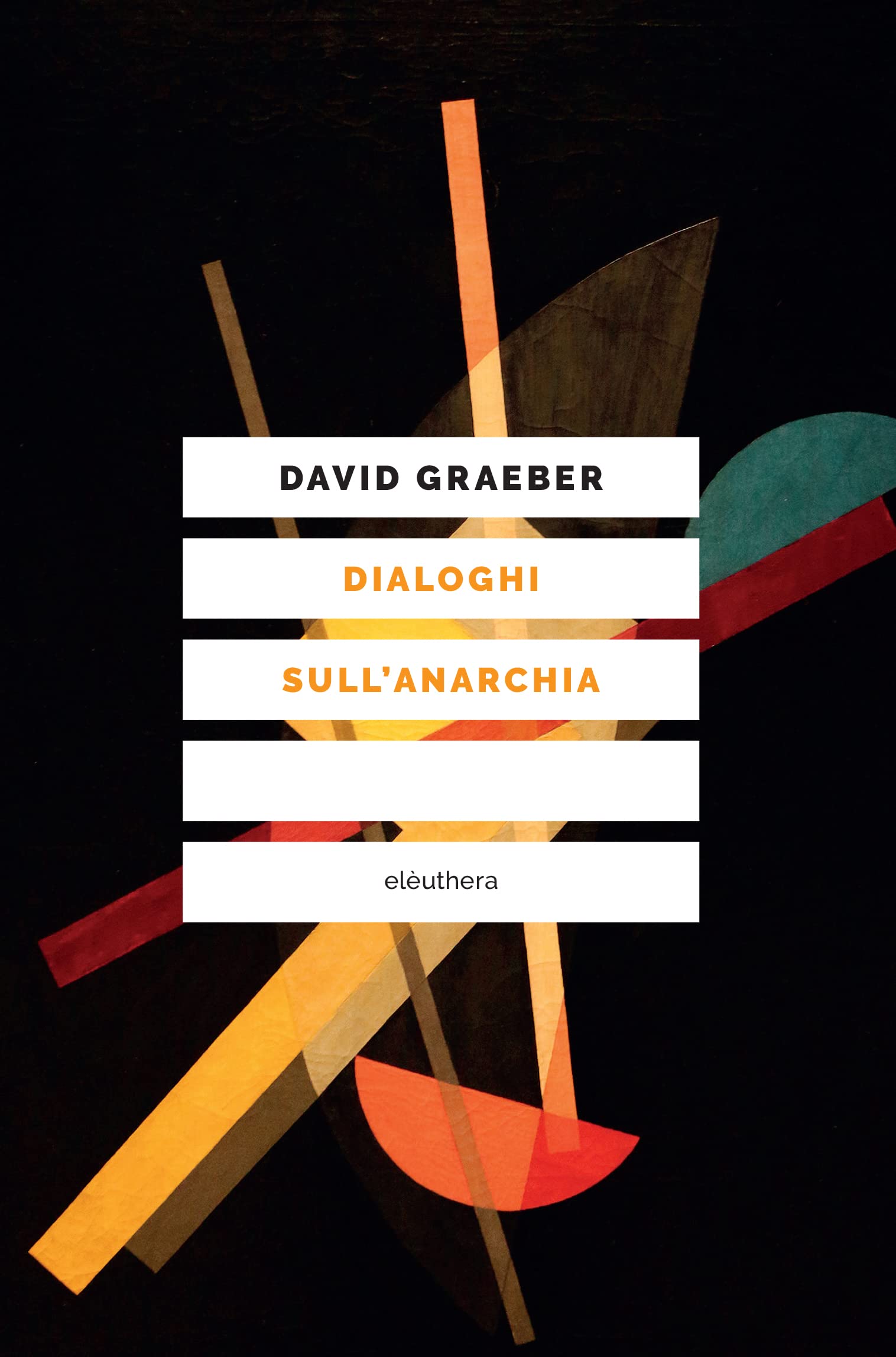
Pubblicato il: 13.06.2023