Ottimismo, oggetti, desiderio – Lauren Berlant
Ogni affetto è ottimistico. Quando parliamo di un oggetto del desiderio in realtà stiamo parlando di un insieme di promesse che vorremmo ci fossero rese realizzabili
di: Lauren Berlant
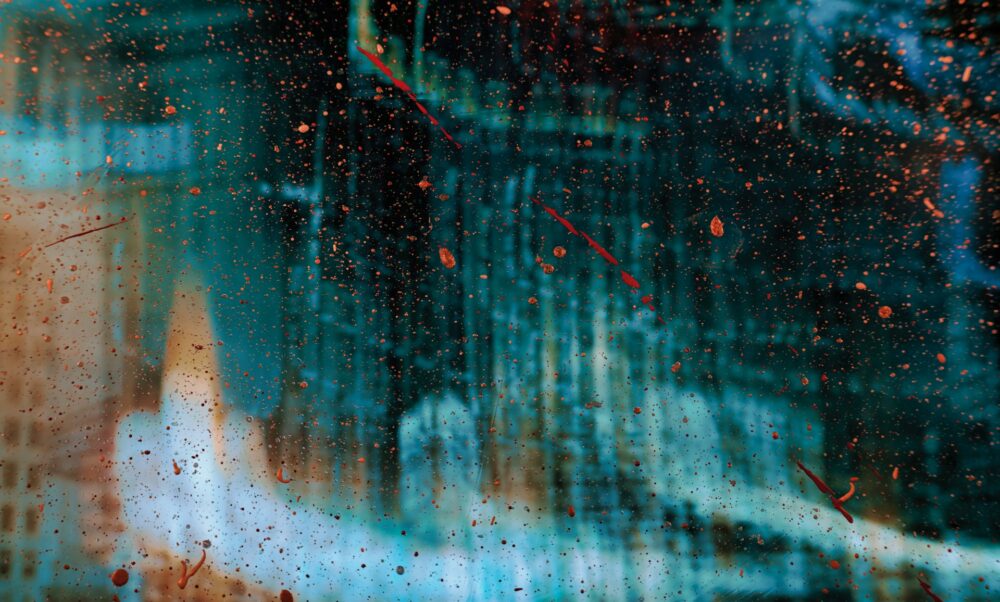
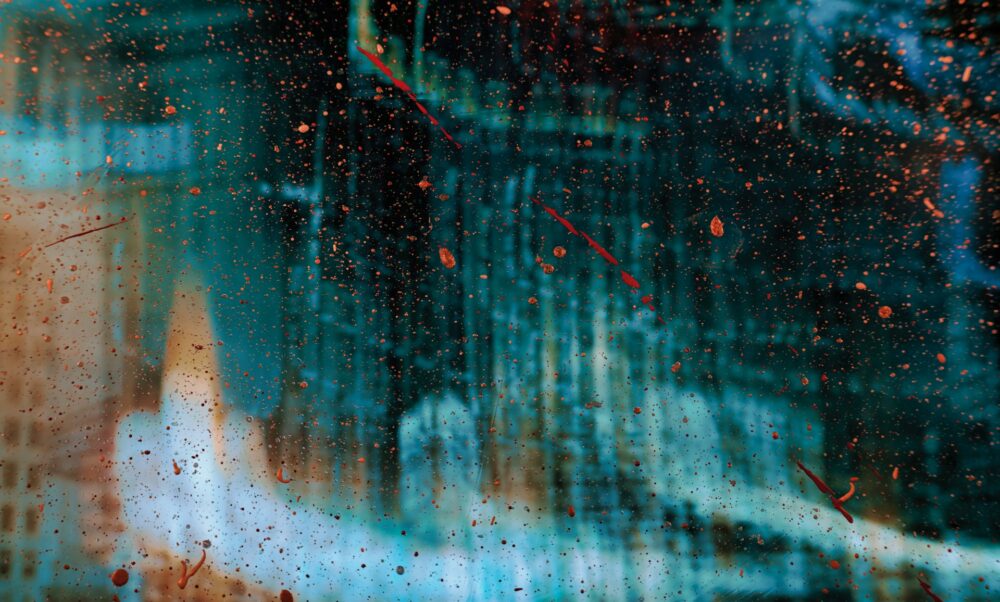
di: Lauren Berlant
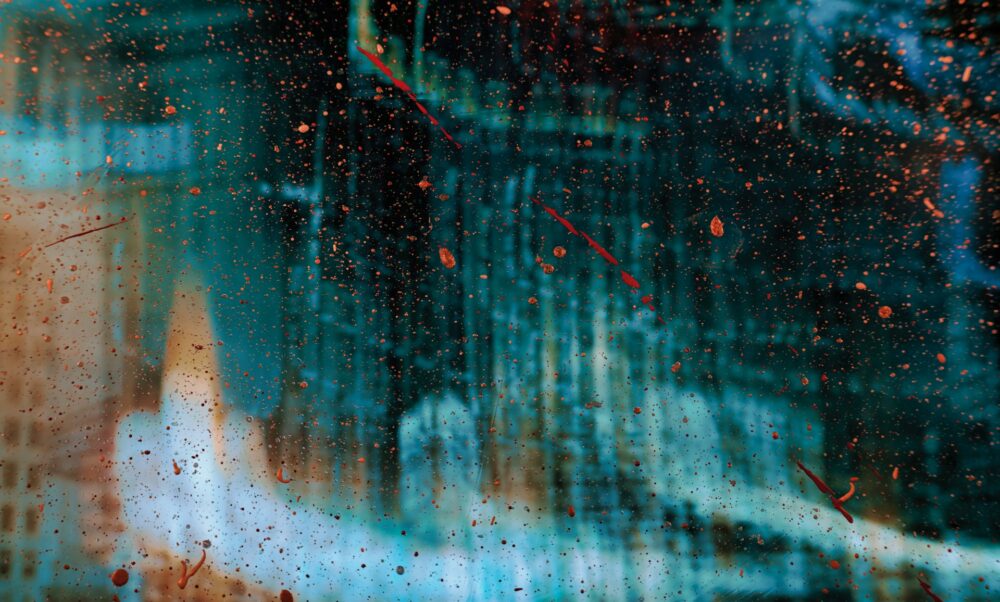
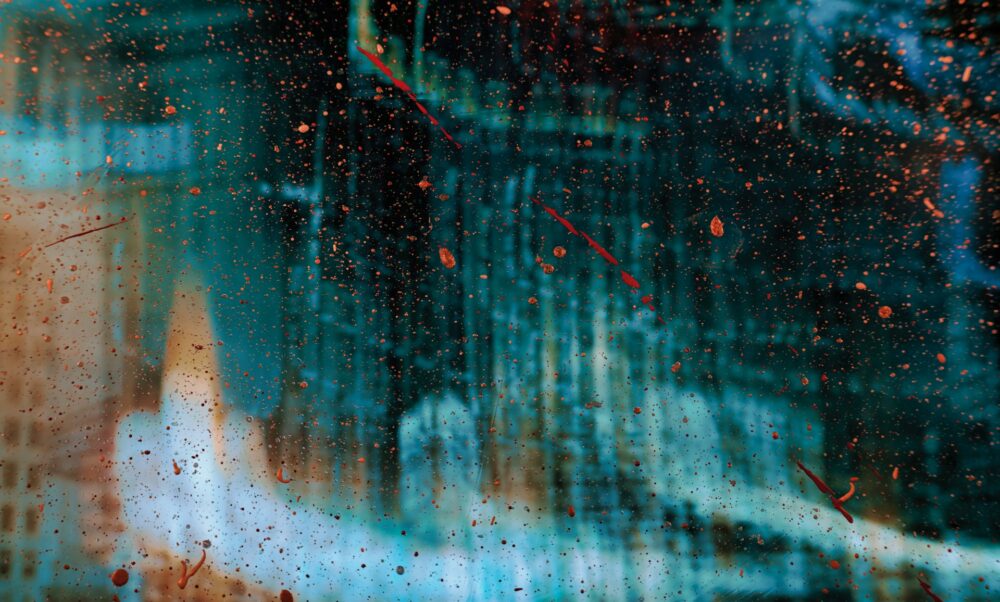
Ogni affetto è ottimistico. Quando parliamo di un oggetto del desiderio in realtà stiamo parlando di un insieme di promesse che vorremmo ci fossero rese realizzabili. Questo insieme di promesse potrebbe prendere di volta in volta la forma di una persona, una cosa, un’istituzione, un testo, una norma, un ammasso di cellule, di odori, una buona idea… di qualunque cosa. Riferirsi a «l’oggetto del desiderio» come a un insieme di promesse è necessario per aprirci a quel che di incoerente o enigmatico ha quel nostro attaccamento, e ciò non serve a confermare la nostra irrazionalità, ma a spiegare il senso della nostra perseveranza nell’oggetto, in quanto la vicinanza a quello specifico oggetto equivale alla vicinanza all’insieme di cose che quell’oggetto promette: alcune possono esserci chiare e farci bene, altre meno.
È per questa ragione che non percepiamo tutti gli affetti come ottimistici: una persona potrebbe avere paura, per esempio, di tornare sulla scena di un desiderio, di uno struggimento o lì dove ha vissuto le prevedibili e farsesche distorsioni di un amante o di un genitore. Ma sentirsi chiamati a ritornare sulla scena in cui aleggia l’oggetto nelle sue potenzialità è un’operazione che prende l’ottimismo in quanto forma affettiva. Nell’ottimismo il soggetto si offre alle promesse racchiuse nel momento presente in cui incontra l’oggetto.*
Nell’introduzione ho descritto l’«ottimismo crudele» come una relazione di attaccamento a condizioni in cui le possibilità sono già compromesse, la cui realizzazione si scopre essere o impossibile – una fantasia pura e semplice – o troppo possibile e tossica. A essere crudele, e non semplicemente sconveniente o tragico, in queste forme di attaccamento, è il fatto che il soggetto che possiede X nella propria vita potrebbe non sopportare la perdita di quell’oggetto/scena del desiderio, anche nel caso in cui la sua presenza dovesse minacciare il benessere del soggetto stesso, perché, quale che sia il contenuto dell’attaccamento, la continuità della sua forma offre una parvenza di continuità a quel che per il soggetto significa vivere e guardare con speranza al futuro che lo attende.
Questa frase vuole indicare una condizione diversa dalla malinconia, che si manifesta nel desiderio del soggetto di indugiare nell’esperienza della perdita di un oggetto/scena in cui ha investito la continuità del suo Io. L’ottimismo crudele è la condizione in cui manteniamo l’attaccamento a un oggetto che è significativamente problematico. E ancora: a volte, la crudeltà di un attaccamento ottimistico può essere più facilmente percepita da un analista esterno che riesce a osservare il prezzo che un singolo, o un gruppo, si ritrova a pagare proprio a causa del proprio attaccamento a X, poiché spesso le persone e le comunità si concentrano solo su alcuni aspetti delle loro relazioni con un oggetto/mondo, e ne ignorano altri.*
Ma quando la crudeltà di un attaccamento invece viene percepita, anche in maniera vaga, da un soggetto o un gruppo, insieme alla stessa sovviene la paura che la perdita di quello stesso oggetto/scena possa rendere impossibile la speranza. Spesso la paura di perdere una figurazione ottimista non la si riesce neanche a definire, riusciamo solo a sperimentarla come una forma improvvisa di incapacità a gestire situazioni spiazzanti, come vedremo nel corso del libro.
Si potrebbe dire che tutti gli oggetti/scene di desiderio sono problematici, dato che gli investimenti e le proiezioni non riguardano tanto gli oggetti/scene in sé, quanto l’insieme di desideri e affetti che riusciamo a tenere loro legati. E in effetti mi sono chiesta se in fondo, forse, non siano crudeli tutte le forme di ottimismo, perché l’esperienza di perderne le condizioni di riproducibilità può essere sconvolgente, così come nell’ambito delle pulsioni legate al nostro attaccamento la minaccia di poter perdere l’oggetto/scena X può essere avvertita come una minaccia alla vita in sé. Ma alcuni scenari ottimisti sono chiaramente più crudeli di altri: dove opera l’ottimismo crudele, la stessa potenza vivifica, o di animazione, di un oggetto/scena del desiderio contribuisce a logorare quella stessa realizzazione che il meccanismo dell’attaccamento, per primo, avrebbe dovuto rendere possibile. Il che può far riferimento a una cosa banale come un amore morboso, ma si può estendere anche a desideri ossessivi come lo stacanovismo, il patriottismo… qualsiasi cosa. Negoziamo, in termini emotivi, e spesso solo inconsciamente, il costo dei nostri attaccamenti, e molte di queste contrattazioni comportano una vicinanza protratta alla scena del desiderio/logoramento.
Questo significa che una poetica dell’attaccamento implica sempre separare, in qualche misura, la storia che posso raccontare sul desiderio di essere vicino a X (come se X avesse delle qualità indipendenti) dall’attività dell’habitus emotivo che ho costruito come funzione della presenza di X nella mia vita, così che, in prossimità dell’insieme di cose che X sembra offrirmi e promettermi, sia possibile proiettare all’esterno la mia perseveranza.
Dunque per comprendere l’ottimismo crudele bisogna intraprendere un’analisi dell’indiretto, grazie alla quale diventa possibile pensare alle strane temporalità della proiezione verso un oggetto che è uno stimolo e, al tempo stesso, è invalidante. Cosa che ho imparato a fare leggendo il lavoro di Barbara Johnson sull’apostrofe e il discorso indiretto libero. Nella sua poetica dell’indiretto entrambe le forme retoriche sono plasmate dalle modalità in cui una soggettività autoriale ne evoca altre, di modo che, in una performance di intersoggettività fantasmatica, lo scrittore ottiene un’autorità osservativa sovrumana che, grazie alla vicinanza dell’oggetto, rende possibile una drammatizzazione dell’esistenza. Poiché questo processo estetico è simile a quello che descrivo nell’ottimismo dell’attaccamento, esaminerò anche la struttura del mio transfert nei confronti del pensiero di Johnson.
In «Apostrophe, Animation, and Abortion», che è qui il mio riferimento principale, Johnson traccia le conseguenze politiche dell’apostrofe in relazione a quel che è diventata la personificazione del feto: un interlocutore silenzioso, presente affettivamente ma fisicamente dislocato (un amante, un feto) che prende vita nel discorso – abbastanza distante per avere una conversazione, ma abbastanza vicino perché il parlante, nella testa del quale si sta svolgendo l’intera scena, possa immaginarla.* Ma la condizione di possibilità proiettata, di un ascolto che non può avere luogo nei termini della propria enunciazione («tu» non sei qui, «tu» sei eternamente in ritardo rispetto alla conversazione con te che sto immaginando) crea un falso momento presente di intersoggettività
in cui può tuttavia essere inscenato un discorso. Il momento presente è reso possibile dalla fantasia di un tu, vestito di tutte le qualità X che sono in grado di proiettare, data la tua conveniente assenza.
L’apostrofe dunque sembra rivolgersi a un tu, un movimento diretto da luogo X a luogo Y, ma in realtà si rivolge all’indietro, è l’animazione di un ricevente in nome del desiderio di fare accadere qualcosa ora che realizzi qualcosa all’interno del parlante, e rende il soggetto più possibile o possibile in modo differente, perché ha ammesso, in un certo senso, l’importanza di parlare per, parlare come e parlare a due – ma solo a condizione, e illusione, che i due siano in realtà (all’interno di) uno.
L’apostrofe è quindi un movimento – indiretto, instabile, fisicamente impossibile, ma fenomenologicamente vivifico – di animazione retorica che permette ai soggetti di sospendersi nell’ottimismo di una potenziale collocazione nello stesso spazio psichico degli altri, ovvero gli oggetti di desiderio che rendono possibile il tu (poiché presentano qualità promettenti, e non presenti).†
In lavori successivi, come «Muteness Envy», Johnson ha descritto la retorica politica di genere di questa proiezione di intersoggettività volubile.* Sussiste il paradosso per cui un’immersione proficua di una coscienza in un’altra richiede una doppia negazione: dei limiti del soggetto parlante, così che possa divenire più grande in una vicinanza retorica all’oggetto del desiderio; e del soggetto parlato, che è, in pratica, un segnaposto, muto e potente, che fornisce al parlante un’opportunità per immaginare la sua/loro realizzazione.
Certo, l’intersoggettività, esistenzialmente e psicoanaliticamente parlando, è impossibile. È un’aspirazione, un desiderio, una richiesta di sentirsi costantemente in presenza e all’interno di X, e si collega al grande nodo che segna la relazione indeterminata tra il sentimento di riconoscimento e di misconoscimento. Come spiegherò meglio nel quarto capitolo, il riconoscimento è il misconoscimento che si è in grado di sopportare: un compromesso che afferma il soggetto senza necessariamente suscitare un sentimento positivo o dover essere particolarmente accurato (può idealizzare, affermare la tua mostruosità, rispecchiare il tuo desiderio di vivere senza dare nell’occhio, sembrare esattamente la cosa giusta, e così via).†
Per elaborare l’aspetto tragicomico del misconoscimento intersoggettivo come forma di realismo, il lavoro di Johnson sulla proiezione mina gli spazi – proiettivi e in grado di dissolvere i limiti – dell’attaccamento all’oggetto del discorso, che deve necessariamente essere assente per permettere al soggetto desiderante dell’intersoggettività di ottenere una certa aderenza, di consolidare la vicinanza all’oggetto/scena promessi.
Quando Johnson passa al discorso indiretto libero, con la sua circolazione di soggettività osservative che si fondono e immergono l’una nell’altra, la proiezione del desiderio di intersoggettività ha degli esiti ancora meno dannosi.* In caso di fusione parziale di un narratore con la coscienza di un personaggio, per esempio, il discorso indiretto libero concretizza l’impossibilità di individuare un’intelligenza osservante in un corpo o nell’altro, e quindi costringe il lettore a negoziare un rapporto di ciò che sta accadendo di differente e più aperto rispetto a quanto sta leggendo, giudicando, provando e pensando di comprendere.
Nell’opera di Johnson questo compromesso trasformativo attraverso la lettura/il parlato «apre» il soggetto in maniera positiva, indipendentemente da qualsiasi desiderio possa avere di non diventare significativamente differente.† In questo, il suo lavoro ha predetto l’estetica dell’interpenetrazione soggettiva approfondita più recentemente da Levinasian di Tim Dean e dall’ottimismo psicoanalitico di Leo Bersani sulla decisione cognitivo-etica di essere trasformati dal progetto di un’intersoggettività limitata, un’ammissione dell’essere dell’Altro senza alcuna pretesa di poterne conoscere l’intimità.‡ Il loro focus, come nel lavoro di Johnson sulla proiezione, riguarda l’ottimismo dell’attaccamento, ed è spesso a sua volta ottimistico rispetto alle negazioni ed estensioni dello statuto di persona che le forme di intersoggettività sospesa richiedono all’amante/lettore.
Ciò che segue, invece, non è così ottimista: questo capitolo elabora e politicizza l’osservazione di Freud secondo la quale «le persone non abbandonano mai volontariamente una posizione libidica, anzi, neanche di fronte alla proposta di una posizione sostitutiva».* Eve Sedgwick descrive la posizione depressiva di Melanie Klein come un’inclinazione a voler creare un circuito di riparazione per una relazione compromessa con il mondo.† La posizione depressa politicamente inasprisce la posizione classica, sollevando il problema dello stile di attaccamento in relazione a un conflitto di intenzioni. La posizione politica depressiva può essere disinvolta, cinica, chiusa, intensamente razionale o riluttante, e tuttavia, avendo adottato una modalità che possiamo definire di distaccamento, potrebbe, in realtà, non essere per nulla distaccata, ma navigare invece una relazione continua e sostenuta con gli scenari, e l’alternarsi, di ottimismo e delusione. (L’apparente distaccamento della razionalità, per esempio, non è affatto un distaccamento, ma una modalità emotiva associata a una pratica retorica per via normativa.)
Rimane quindi da domandarsi in che direzione si muove questa riparazione, se va incontro o si allontana dalla ricostruzione di una relazione con l’oggetto/scena politica che ha fin lì strutturato la relazione che comunemente si ha con gli sconosciuti, col potere e con le infrastrutture che determinano appartenenza. Quindi rimane anche l’interrogativo su chi sia in grado di sopportare la perdita del mondo (la «posizione libidica»), su cosa accada quando la perdita di ciò che non funziona è più insopportabile del suo possesso, e viceversa.
Ottimismo crudele si occupa di quelle pratiche di auto-inter-ruzione, auto-sospensione e auto-abbandono che rivelano gli sforzi che le persone affrontano per cambiare, seppur in modo non traumatico, i termini valoriali in cui la loro attività di vita è stata collocata.*
«Ottimismo crudele» è, quindi, come tutte le espressioni, un deittico: un enunciato che indica una posizione di vicinanza spaziale. Come leva analitica è un invito a occupare e inseguire l’attaccamento sentimentale a quella che chiamiamo la «buona vita», che, per molti, rappresenta una vita sbagliata e in grado di logorare il soggetto che, ciononostante, vi trova le proprie condizioni di possibilità esistenziale. Non si tratta soltanto di uno stato psicologico.
Le condizioni di vita ordinaria nel mondo contemporaneo, anche quando di relativo benessere, come negli Stati Uniti, sono condizioni di logoramento o esaurimento del soggetto, e l’ironia del fatto che il lavoro di riproduzione della vita nel mondo contemporaneo sia, al contempo, l’attività per cui quella stessa vita ci esaurisce ha delle implicazioni specifiche per la riflessione sull’ordinarietà della sofferenza, della violenza della normatività e delle «tecnologie della pazienza» che consentono al concetto di dopo di sospendere gli interrogativi sulla crudeltà dell’ora.†
L’ottimismo crudele è, in questo senso, un concetto che punta a un modo per vivere l’immanenza che sappia svilupparsi a partire da un’intuizione delle ragioni per le quali le persone non sono Bartleby, per cui preferiscono non interferire con le diverse forme di impoverimento, ma scelgono di cavalcare l’onda del sistema di attaccamento a cui sono abituate per sincoparvi, o per mantenervi almeno una relazione di reciprocità, riconciliazione, o una forma di rassegnazione che non equivalga a una sconfitta. O forse si muovono verso la normatività per essere anestetizzate dalla promessa consensuale e per non riconoscere quella promessa di per sé come una conquista.
Analizzando brani di John Ashbery, Charles Johnson e Geoff Ryman, questo capitolo esamina tre episodi in cui quello che costituisce il vincolo crudele dell’ottimismo si rivela sorprendente e stimola diverse rappresentazioni drammatiche dell’adattamento all’essere post-genere, post-normativi e al non avere un’idea chiara di come vivere. In mezzo a tutto questo, troveremo un ritmo nell’impasse in cui le persone possono entrare mentre tentennano, barcollano, fanno compromessi, sperimentano, o vengono logorate dalle promesse alle quali si sono legate in questo mondo.
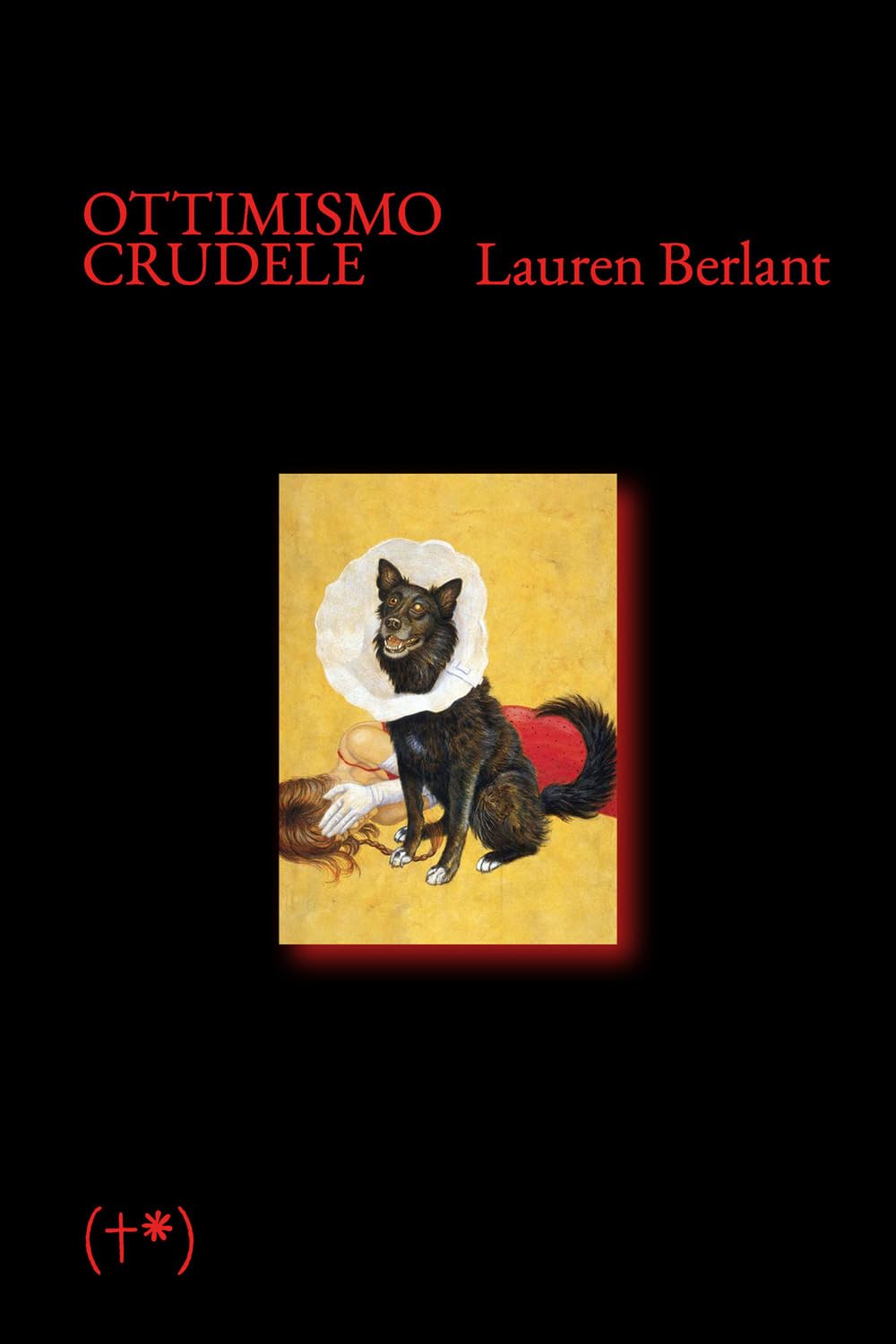
* L’espressione «momento presente» di Daniel Stern introduce qui una concettualizzazione del «presente» come una durata non sempre persa e fuggevole, ma che le persone rallentano, proiettandola o spostandola nello spazio. Vedi Ghent, «Masochism, Submission, Surrender», e Stern, The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life.
* Per alcuni esempi di casi studio di ottimismo crudele, vedi Frank, What’s the Matter with Kansas?, e Micheal Warner, The Trouble with Normal.
* Barbara Johnson, «Apostrophe, Animation, and Abortion».
† Si intuisce come, in questa scena, Johnson evochi il presente assente dell’objet petit a lacaniano; ma per molti versi il lavoro di Johnson sull’intersoggettività retorica è più vicino alla costruzione di Mikkel Borch-Jacobsen della proiezione nell’attaccamento mimetico in The Freudian Subject.
* Barbara Johnson, «Muteness Envy».
† Per maggiori informazioni sulla sopportazione nel transfert con l’oggetto, vedi Benjamin, «What Angel Would Hear Me?». Trattando l’insistenza con cui l’analizzato vuole essere trovato o riconosciuto, da qualche parte, da qualcuno, questo meraviglioso saggio sopra-allinea l’ottimismo formale dell’attaccamento in quanto tale e gli affetti del desiderio di autoconservazione.
* Barbara Johnson, «Metaphor, Metonym, Voice in Their Eyes Were Watching God» e «Thresholds of Difference».
† Barbara Johnson, «Bringing Out D.A. Miller».
‡ Vedi Bersani e Phillips, Intimacies, e Tim Dean, Unlimited Intimacy.
* Freud, Lutto e Melanconia. Grazie a Tom Strillinger per avermi introdotto a questo testo un decennio fa.
† L’espressione «depressione politica» emerge da un dibattito in una tavola rotonda sui Sentimenti Collettivi. Uno speciale riconoscimento va a Ann Cvetkovich, Katie Stewart, Debbie Gould, Rebecca Zorach e Mary Patten.
* Sedgwick, «Teaching/Depression», www.barnard.columbia.edu
† Berlant, The Queen of America Goes to Washington City.
Pubblicato il: 06.05.2025