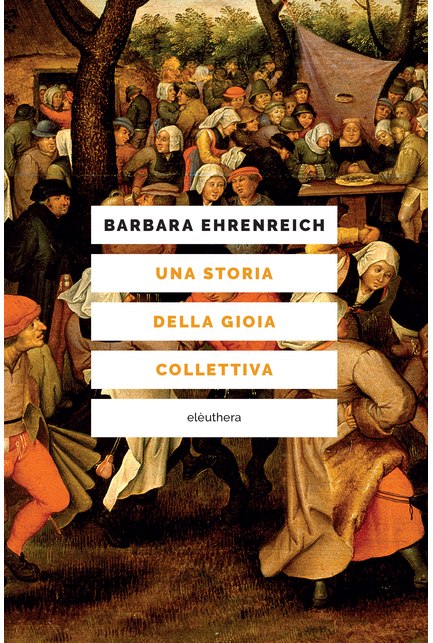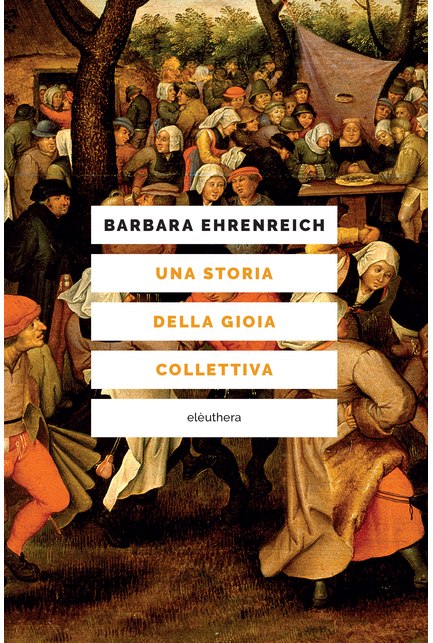Il testo qui riportato è tratto dal primo capito del libro Una storia della gioia collettiva di Barbara Ehrenreich, pubblicato recentemente dalla casa editrice Eleuthera. Barbara Ehrenreich (Butte 1941 – Alexandria 2022), di formazione chimica e biologa, si allontana dal mondo scientifico per occuparsi a lungo di salute e femminismo, avanzando una dura critica al complesso “medico-industriale”. Si è occupata principalmente di disuguaglianze sociali e ha operato tutta la vita come saggista, giornalista e attivista politica, collaborando inoltre con le maggiori università americane. Come testimoniano i rituali del Paleolitico, il culto di Dioniso o le pratiche danzanti del cristianesimo medievale, in passato le società umane hanno sempre dato vita a momenti di festa ed estasi collettiva. Un invito a «perdersi» che permetteva a ognuno di entrare in comunione diretta con gli altri (e con il divino). Perché allora questa festività spontanea, un tempo così diffusa, oggi è quasi scomparsa, se non nella forma di un consumo passivo? Perché il suo afflato liberatorio ha sempre più scatenato nelle élite il timore – in effetti giustificato – che questi raduni potessero sfidare le gerarchie sociali. Il libro Una storia della gioia collettiva rintraccia storicamente i passaggi salienti di questa vicenda ed è soprattutto un inno alla libertà di gioire insieme, nonostante tutto.
Se andassimo indietro nel tempo fino a diecimila anni fa, ci imbatteremmo in umani impegnati nelle tante attività quotidiane necessarie alla sopravvivenza: caccia e raccolta, fabbricazione di armi e abiti, primi esperimenti di agricoltura. Ma se planassimo nella giusta notte di luna o nel giorno esatto di un cambio di stagione, ecco che ci imbatteremmo in quello che, al confronto, sembra uno spreco gratuito di energia, ovvero in umani intenti a danzare, in fila o in cerchio, con indosso maschere o costumi di un qualche tipo, e spesso con rami o bastoni in mano.
È probabile che a ballare sarebbero tanto gli uomini quanto le donne, ma gli uni e le altre in una fila o in un cerchio propri. I loro volti e corpi sarebbero dipinti di ocra rossa, o così ritengono gli archeologi in base alla presenza diffusa di quel pigmento a base minerale nei siti di insediamento umano. La scena, in altre parole, potrebbe non essere molto diversa dai rituali «selvaggi» in cui si imbatterono gli occidentali del xix secolo tra i popoli nativi del mondo.
Possiamo dedurlo dalle figure danzanti raffigurate nelle pitture rupestri preistoriche rinvenute negli scavi in Africa, India, Australia, Italia, Turchia, Israele, Iran, Egitto e altrove. Comunque fossero organizzate le loro vite quotidiane, a quanto pare i nostri lontani antenati trovavano tempo in abbondanza da dedicare a quelle che l’antropologo Victor Turner giudicava attività liminali o periferiche rispetto al compito prioritario di sopravvivere.
La danza cerimoniale non è un tema raro o occasionale nell’arte rupestre. L’archeologo israeliano Yosef Garfinkel definisce le scene di danza «un soggetto molto popolare, o quasi l’unico, impiegato per descrivere l’interazione tra persone nei periodi del Neolitico e Calcolitico». Non sappiamo quando siano sorti quei rituali, ma alcuni indizi permettono di datarli al Neolitico, o Età della pietra.
In uno scavo recente, in Inghilterra, i disegni sulla volta di una grotta hanno portato alla luce donne che danzano in fila, come in una conga, accanto a immagini di animali che in Inghilterra si estinsero diecimila anni orsono, come il bisonte e lo stambecco. Dunque, ben prima di avere un alfabeto e forse persino prima di divenire stanziali, gli umani ballavano e consideravano la danza abbastanza importante da lasciarne una documentazione sulla pietra.
Non è facile leggere l’eccitazione di un ballo rituale nelle opere preistoriche. Le figure sono altamente stilizzate; molte di quelle catalogate da Garfinkel sono appena abbozzate, poco più che silhouette, e ben poche hanno un volto o espressioni facciali. Persino identificarle come figure danzanti richiede un certo lavoro interpretativo; per riconoscerle come tali, i loro movimenti non devono essere associabili ad alcuna attività ordinaria, ovvero devono essere ritratte in cerchio, ad esempio, con le braccia tese in aria o le gambe sollevate, come in un balzo. Ma persino in questi ritratti approssimativi e bidimensionali spiccano elementi tipici di tradizioni cerimoniali più recenti – maschere e costumi, ad esempio.
Alcune figure maschili portano maschere a testa d’animale o con forme astratte; altre indossano quelli che gli archeologi interpretano come «costumi», ad esempio pelli di leopardo. Uno dei tratti più rilevanti per cogliere il movimento, e forse l’eccitazione, sono i capelli, lunghi e fluenti, sollevati in aria, come se la figura stesse eseguendo passi rapidi e scuotendo la testa al ritmo di tamburi per noi silenziosi da eoni.
Con ogni evidenza, le danze rituali non sembravano una perdita di tempo alle genti preistoriche. Dedicavano del tempo a realizzare maschere e costumi; bruciavano con abbandono calorie nell’esecuzione della danza; ritraevano queste scene più spesso di qualsiasi altra attività di gruppo. Consegnare la danza rituale a un ruolo occasionale, marginale o liminale, come ha fatto Turner, appare particolarmente ingiustificato nel caso preistorico, e indicativo più della mentalità orientata alla produzione tipica della nostra era industriale che delle priorità antiche.
Certo, quei popoli dovevano senz’altro conoscere la fatica, la minaccia di carestie, malattie e fiere selvatiche. Ciononostante, i rituali di gruppo, espressi nella danza e forse di natura estatica, restavano una parte centrale delle loro vite. Forse è proprio a partire dalla nostra quotidianità – tanto più facile da tanti punti di vista, ma così fortemente limitata dall’imperativo del lavoro – che dobbiamo provare a rispondere a molti perché.
L’ipotesi più accreditata tra gli antropologi per la funzione evolutiva della danza è che autorizzasse o incoraggiasse gli umani a vivere in gruppi più allargati rispetto alle piccole bande di individui strettamente imparentati tra loro. Si presume che il vantaggio dei gruppi più numerosi fosse lo stesso che si riscontra tra i primati ancora osservabili in natura: più si è e meglio si è grado di difendersi dai predatori.
Diversamente da quasi tutte le altre specie (le antilopi, ad esempio), i primati hanno la capacità di organizzare una difesa di gruppo: avanzano in massa contro l’intruso agitando rami e provano a scacciarlo spaventandolo con un baccano infernale. Nel caso dei primi umani, il pericolo poteva provenire non solo da predatori come i grossi felini ma anche da altri ominidi oggi estinti, e forse persino dalle scorrerie di altri Homo sapiens. Naturalmente, nel caso degli umani, le armi difensive avrebbero incluso il fuoco, le pietre e bastoni appuntiti. Ma la prima linea di difesa era formare un gruppo.
In un libro giustamente popolare, Grooming, Gossip, and the Evolution of Language [Dalla nascita del linguaggio alla Babele delle lingue], l’antropologo inglese Robin Dunbar calcola che il numero ottimale per un gruppo del Paleolitico fosse di centocinquanta unità circa. La sua ipotesi è che il linguaggio – il «gossip» del titolo – avesse contribuito alla coesione di gruppi di quelle dimensioni quanto il grooming reciproco – liberarsi a vicenda il pelo da parassiti e sporcizia – per gli altri primati. Ma sebbene non compaia nel suo titolo, di fatto Dunbar cita la danza come elemento di unione per quei primi gruppi umani. Il problema del linguaggio, afferma, è la sua «totale inadeguatezza per l’espressione emotiva».
Nel momento in cui cominciammo ad acquisire la facoltà di discutere e razionalizzare, sorse anche il bisogno di un meccanismo di base che si appellasse piuttosto alle emozioni per tenere insieme i nostri grandi gruppi. Serviva qualcosa di più profondo ed emozionale per sovrastare la fredda logica delle argomentazioni verbali. A quanto sembra, a svolgere questa funzione furono la musica e il contatto fisico. Anzi, Dunbar considera il linguaggio subordinato alle danze rituali: «un modo per formalizzarne la spontaneità» e infonderle «significato metafisico e religioso». Merita anche osservare che mentre sono state rinvenute centinaia di immagini preistoriche di figure danzanti, non esistono pitture rupestri di figure stilizzate impegnate in conversazione.
Dunbar non è l’unico a considerare le danze di gruppo – soprattutto in fila e in cerchio – come il principale strumento per livellare e unire le comunità umane, capace di legare tutti i partecipanti al tipo di communitas riscontrata da Turner nei rituali nativi nel xx secolo. È interessante notare che la parola greca nomos, cioè «legge», ha anche il significato musicale di «melodia».
Abbandonandosi fisicamente alla musica attraverso la danza si veniva incorporati alla comunità in modo ben più profondo di quanto fosse possibile con la condivisione di miti o altre usanze. Il movimento in sincronia con la musica, strumentale o cantata, tramutava le piccole rivalità o i conflitti tra fazioni che rischiavano di dividere il gruppo in competizioni innocue sulla destrezza di ballerini, o le cancellava del tutto. «La danza» nelle parole di un neuroscienziato «è la biotecnologia della formazione di un gruppo».
Dunque, i gruppi capaci di creare una coesione interna con la danza – e gli individui che ne facevano parte – avrebbero goduto di un vantaggio evolutivo rispetto ai gruppi e agli individui con legami più deboli: la possibilità di organizzare una migliore difesa collettiva contro gli animali o gli umani ostili che invadevano il loro territorio o li minacciavano in altro modo. Nessun’altra specie ha mai imparato a farlo.
Gli uccelli hanno i loro canti; le lucciole sanno sincronizzare le proprie esibizioni luminose; a volte gli scimpanzé pestano insieme i piedi e agitano le braccia in quello che gli etologi definiscono un «carnevale». Ma se esistono altri animali capaci di comporre una melodia e di muoversi in accordo con il suo ritmo, quel talento l’hanno tenuto ben nascosto agli umani. Soltanto noi siamo dotati del tipo di amore che Freud non fu capace di concepire: un amore, o quantomeno un afflato, che unisce gli individui in gruppi più numerosi della semplice coppia.