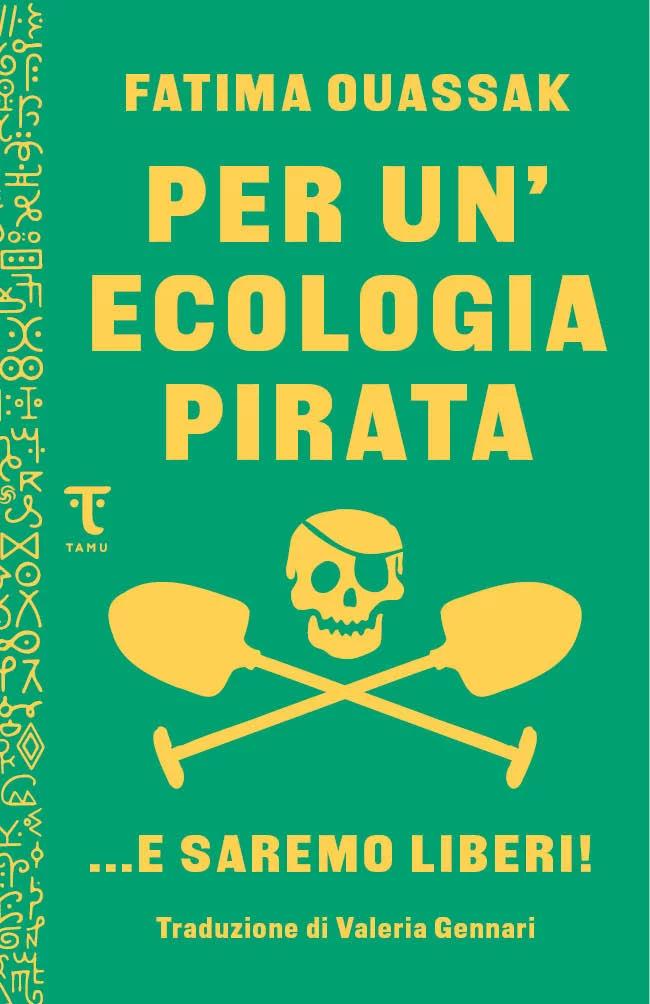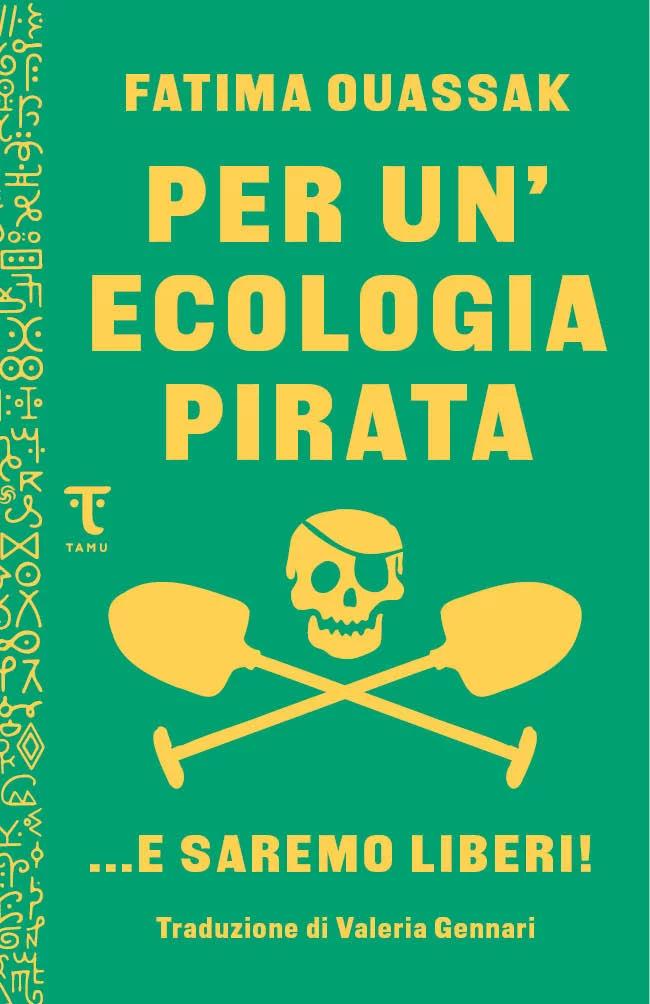Fatima Ouassak, è autrice di Per un’ecologia pirata. E saremo liberi, libro che possiamo leggere nella traduzione di Valeria Gennari, grazie a Tamu Edizioni. Ouassak è politologa e militante ecologista, femminista e antirazzista. È co-fondatrice del Front de mères, sindacato di genitori degli alunni dei quartieri popolari, e di Verdragon, la prima Casa dell’ecologia popolare in Francia, a Bagnolet. Presiede inoltre il Réseau Classe/Genre/Race, una rete che lotta contro le discriminazioni subite dalle donne con background migratorio.
Per un’ecologia pirata. E saremo liberi trae origine da alcune domande che nessuno si fa mai: che cosa hanno da dire gli abitanti dei quartieri popolari delle città europee sulla crisi ambientale in atto? Che cosa hanno da dire i bambini di questi quartieri, che si vedono sottrarre le aree verdi e respirano aria sempre più inquinata, e che conoscono lo spazio pubblico solamente come luogo di controllo poliziesco?
L’ecologia di cui parla questo libro è radicata nell’esperienza di chi è più esposto alla devastazione del territorio. Una visione che invita a prendere il largo come le navi di One Piece, il manga così amato nelle banlieue assetate di libertà.
Nel progetto dell’estrema destra la connessione tra cambiamento climatico e migrazione è chiara: muri sempre più alti a separare i quartieri ricchi dai quartieri poveri, e l’Europa dall’Africa, garantiranno a una minoranza di mantenere il proprio livello di benessere. Fatima Ouassak, formula un progetto in cui l’abolizione delle frontiere diventa il perno del diritto a respirare e vivere bene.
In moschea, il vecchio sente dire che in Algeria gli incendi stanno devastando migliaia di ettari. Tornato a casa chiede alla figlia: «Guarda su internet per vedere dov’è di preciso; hanno parlato anche del Congo, cerca bene, la Terra sta bruciando!»
La giovane si mette a cercare, ma è sorpresa: «Da quand’è che ti preoccupi della Terra che brucia?»
Il vecchio si stupisce a sua volta: «Con tutte queste foreste e questi corpi carbonizzati, come faccio a non preoccuparmi?»
La giovane: «E perché non ti preoccupi mai di quello che succede in Francia? Anche questa è la Terra, anche qui sta bruciando».
Il vecchio punta l’indice verso il suolo: «Questa non è la Terra. Questa è la terra dei francesi».
La realtà del disastro climatico è ormai ampiamente documentata e quantificata con estrema precisione. Si tratta di fatti scientifici attendibili e drammatici per ciò che ci insegnano sull’irreversibilità della catastrofe che i nostri figli e nipoti dovranno subire: il loro mondo è già in parte distrutto, qualunque cosa noi facciamo. Tuttavia, sono le nostre azioni di oggi a determinare l’entità della distruzione. Possiamo ancora fare qualcosa per rendere questo mondo meno invivibile, più respirabile di quello che promette di diventare se non facciamo nulla.
Come si spiega allora che i discendenti dell’immigrazione africana che vivono nei quartieri popolari si interessano alle conseguenze del cambiamento climatico sull’altra sponda del Mediterraneo, in Africa, arrivando a organizzarsi collettivamente per finanziare progetti di piantumazione di alberi o di trivellazione di pozzi, ma non si curano di ciò che rischia di accadere su questa sponda del Mediterraneo, in Europa, dove hanno vissuto così a lungo e dove sono nati i loro figli e nipoti?
Eppure nessuno è più sensibile al disastro ecologico delle persone che vivono nelle periferie delle grandi città. Allora perché, per poter respirare meglio, non cercano di proteggere i loro quartieri dalla cementificazione? Perché la terra a cui tengono, quella che vorrebbero difendere da inondazioni e siccità, è quella del paese, in Africa, e non quella in cui vivono, in Europa?
Per cominciare, va detto che gli abitanti dei quartieri popolari hanno buone ragioni per essere più preoccupati per l’Africa che per l’Europa. È vero che «la nostra casa è in fiamme», ma il sistema distingue tra le case che contano e quelle che non contano. E gli abitanti dei quartieri popolari lo sanno per due motivi: perché in Francia vivono in quartieri segregati e perché provengono da paesi colonizzati dalla Francia. Sanno che è la casa europea che ogni sera, da secoli, dà fuoco alla casa della vicina africana per preparare il suo lauto pasto, e che oggi più di ieri chiude le porte quando quella vicina viene a cercare rifugio. È un dato di fatto che le persone che soffriranno di più a causa del disastro climatico sono quelle che vivono in Africa. I paesi europei sono responsabili di una quantità di emissioni di gas serra di gran lunga superiore rispetto a quella dei paesi africani, ma sono questi ultimi a pagare il prezzo del riscaldamento globale che l’Europa ha causato in misura maggiore, decennio dopo decennio.
Ma soprattutto, il disinteresse verso la questione climatica delle persone che vivono nei quartieri popolari è legato al loro disancoraggio organizzato e sistematico, ai processi, ripetuti di generazione in generazione, che li rendono dei senza-terra e quindi dei senza-potere. Si fa di tutto per impedire a queste persone di ancorarsi in questa terra europea e condannarle all’erranza. Mille frontiere fisiche e simboliche le tengono in trappola: non sei di qui, non sei più di lì, non sei di nessun luogo. Anche ai figli e ai nipoti nati qui, che non conoscono altre terre, viene costantemente ripetuto che sono stranieri, che non sono a casa loro, al posto loro, che non hanno il diritto di muoversi liberamente, che devono mostrare i documenti come se dovessero passare la dogana quando invece non stanno facendo altro che chiacchierare giù dal loro condominio.
Non possiamo chiedere agli abitanti dei quartieri popolari di impegnarsi nella lotta contro chi sta distruggendo la terra qui e, allo stesso tempo, ricordargli costantemente che non sono a casa loro a colpi di discriminazione razziale in ogni ambito sociale, controlli razzisti della polizia, difficoltà nell’ottenere i documenti o islamofobia più o meno accettata. Non possiamo aspettarci che persone che non hanno nemmeno il diritto di dire pubblicamente «Dio è grande» si uniscano al fronte climatico per amore di Gaia, oscura sotto-divinità greca. Non siamo nelle condizioni di proteggere una terra in pericolo quando noi stessi siamo schiacciati e sotto controllo permanente. Non siamo nelle condizioni di proteggere una terra lì dove non abbiamo il potere di cambiare le cose. Nei quartieri popolari la questione ecologica non può avere come obiettivo la protezione della terra – ambiente, natura ed esseri viventi – ma la sua liberazione.
Non sarà un affare da poco. «La casa è in fiamme», come dimostrano migliaia di articoli scientifici riassunti dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc): l’estrazione di combustibili fossili, il trasporto su strada e l’allevamento industriale sono tra i principali responsabili delle emissioni di gas serra, a loro volta responsabili del riscaldamento globale. Eppure questo non impedisce alla Total di continuare a infierire, in particolare in Uganda, con un progetto di gasdotto riscaldato le cui conseguenze sociali, ambientali e climatiche si preannunciano drammatiche. Né all’industria automobilistica di produrre sempre più Suv. Né al settore agroalimentare di allevare sempre più animali da consumo e di disboscare sempre più foreste. L’Europa si accontenta di delocalizzare le sue industrie più inquinanti e a più alta emissione nei paesi del Sud ed è determinata a estrarre quanta più energia possibile dai combustibili fossili. Gli obiettivi degli stati europei oggi restano quelli di soddisfare il bisogno di energia, di manodopera, di consumatori, di dati personali e di discariche, tutti elementi essenziali per la sopravvivenza del sistema capitalista.
La forza di questo sistema sta nella sua capacità di cadere in piedi, mettendo gli uni contro gli altri come ha sempre fatto. Questo è ciò che la configurazione coloniale e razzista del mondo gli permette di fare: scindere il mondo da proteggere e quello da saccheggiare, per negoziare con l’uno contro l’altro. La sua proposta è nota: l’alto livello di emissioni di anidride carbonica e di metano porterà certamente alla distruzione di gran parte dell’umanità e degli esseri viventi, ma grazie alla geoingegneria e a muri invalicabili il benessere degli europei sarà più che mai protetto; questo benessere potrebbe addirittura crescere grazie all’aumento delle disuguaglianze causato dal riscaldamento globale.
Sono in molti in Europa a non credere a questa favola della geoingegneria. Soprattutto i giovani, che vedono che il loro mondo, il mondo di domani, viene sacrificato per soddisfare gli assurdi bisogni materiali e l’avidità senza limiti di pochi.
Come fare allora per indurre gli stati europei a invertire la rotta e cambiare radicalmente la loro direzione politica? È la domanda che l’intero movimento europeo per il clima si pone e alla quale da diversi anni risponde lavorando alla creazione di un grande movimento di protesta. Ma la mobilitazione è relativamente debole di fronte a un’emergenza climatica sempre più concreta. Questo movimento, composto essenzialmente da persone appartenenti alle classi medie e alte bianche, non è popolare, o almeno non lo è abbastanza considerata la gravità della situazione.