Rotta per Utopia – China Miéville
Abbiamo bisogno di utopie. È quasi un fatto scontato, nell’attivismo. Se un’alternativa a questo mondo fosse inconcepibile, come mai potremmo cambiarlo?
di: China Miéville


di: China Miéville


Sapendo da dove spiegare le vele, con la complicità e l’esperienza di un fido timoniere, non ci vuole poi molto per raggiungere Utopia.
Fin da quando la prima donna, o il primo uomo, desiderò con ardore raggiungere un posto migliore, i sognatori hanno sognato questi luoghi in cima a una montagna, o al riparo in valli nascoste, al di là delle nubi o tra le viscere della terra. Ma, più di ogni altra cosa, li hanno immaginati su un’isola. L’utopia insulare è uno standard che ricorre fin dall’antichità: la Panchea di Evemero e l’Isola del Sole di Iambulo; l’Isola dei Pine di Henry Neville e il regno di Antangil descritto nell’omonimo romanzo del 1616; la Bensalem di Bacon; la Nosmnbdsgrutt del Peter Wilkins di Robert Paltock; la Pala di Huxley; l’Islandia di Austin Tappan Wright, e innumerevoli altre. E, al centro di questo vasto arcipelago di dissidenza e speranza, un luogo e un nome si ergono al di sopra di tutti gli altri.
Quest’isola, questo libro, rappresenta il paradigma. Nelle parole dello studioso Roland Greene, «L’Utopia di Moro è forse il testo che ha fissato l’insularità come precoce punto di osservazione moderno […] introducendo un modo di pensare che è stato appropriatamente denominato utopismo», caratterizzato da un «fenomeno multiforme che chiamerò logica insulare».
Ma, lo ripeto, non si tratta di un viaggio così lungo. Gli abitanti di Utopia coltivano «la pratica e la conoscenza delle cose di mare», navigando avanti e indietro, intenti in una gran varietà di occupazioni e scambiando beni in eccedenza quali «miele, lana, lino, zafferano, porpore, pelli, cera, sego, cuoio, animali […] con altre regioni». Nulla più che un sottile tratto d’oceano separa Utopia dal continente. Fin troppo vicina alla riva per trattarsi di un non-luogo notoriamente e costitutivamente situato in nessun dove.
E vi è qualcosa di ancor più sorprendente riguardo alla sua insularità, un fatto molto spesso trascurato:
Una volta questa terra […] non era circondata tutta dal mare, e fu un uomo, Utopo, […] a renderla tale. Dopo averla conquistata (conquista che condusse quelle popolazioni rozze e selvagge a un grado di civile cultura nel quale ormai son superiori a quasi tutti i popoli della terra), Utopo, subito dopo il primo sbarco vittorioso, fece tagliare la terra per quindici miglia, dalla parte che era unita al continente, e così il mare la chiuse tutt’intorno. A compiere quest’opera Utopo non s’avvalse soltanto del lavoro degli isolani, ma vi aggiunse anche tutti i suoi soldati affinché i nativi non avessero a sentirsene umiliati, distribuendo le fatiche e i compiti fra tanta gente in modo che tutto fu ultimato con grande rapidità, talché i vicini, i quali all’inizio ne ridevano come d’impresa folle, rimasero poi stupefatti insieme e spaventati.
Il più celebre esempio di utopia insulare – il suo stesso idealtipo – in realtà non è affatto un’isola. Le quindici miglia di acqua che la tengono separata dal corpo politico principale non sono lì per volontà di Dio, ma in virtù del sudore dei nativi (e non solo), i quali hanno scavato per ordine di un conquistatore straniero. Questo splendido – utopico – isolamento è parte di un violento bottino imperiale.
La più classica critica reazionaria all’impulso utopico si fonda, per l’appunto, sul fatto che l’utopia sia un non luogo, qualcosa di impossibilmente distante. Ma al cuore del mito fondativo ideato da Moro per la sua città da sogno si annida un problema – sconfessato e bene in vista – ben diverso: l’impressione è che, trattandosi di un prodotto della brutalità imperiale, di qualcosa di imposto dall’alto, Utopia sia, al contrario, fin troppo vicina.
[…]
Ma il fatto che l’impulso utopico non sia mai senza macchia non significa che possa o debba essere negato o frenato. L’impulso utopico è inevitabile come l’odio, la rabbia e la gioia, e altrettanto necessario.
L’utopismo non è speranza, né tantomeno ottimismo: l’utopismo è bisogno, ed è desiderio. Desiderio di riconoscimento – come ogni altro desiderio – ma anche desiderio di quelle specifiche fantasticherie che gli sono proprie; e, soprattutto, desiderio di qualcosa di meglio tout court. Desiderio di alterità, di qualcosa di diverso dall’estenuante menzogna sociale. Desiderio di riposo. E quando le crepe nella storia si aprono a sufficienza, tale impulso può addirittura contribuire a spalancarle.
Non possiamo fare a meno di questo libro. Tutti noi siamo e siamo sempre stati figli di Tommaso Moro. Persino i suoi antenati letterari erano anche suoi discendenti preventivi, i quali lo sfoggiarono, ne fecero un cardine, di modo che il futuro re potesse retroattivamente dare un nome ai loro aneliti. Il fatto stesso di dover di continuo tornare sul testo, seppur carichi di sospetti, è il nostro modo di rendergli onore. Utopia ci ha donato la formula, l’esatto concetto, di cui avevamo bisogno.
Anche se, forse, è giunto il momento di ripensare questa parola.
Non sappiamo granché della società che Utopo e i suoi eserciti hanno distrutto – tale è la natura dell’oblio forzato – ma ne conosciamo il nome. Essa viene menzionata, con tutta la spavalderia colonialista dell’en passant, all’interno di un hapax legomenon preso in prestito direttamente dallo gnosticismo: «L’isola che prima di lui si chiamava Abraxa». E noi conosciamo bene la storia di questi primi incontri; ogni popolo brutalizzato, genocidizzato e schiavizzato della storia, al pari degli abraxani, è parso «rozzo e selvaggio» agli occhi degli invasori.
Per ogni utopia davvero abitabile, un buon punto di partenza potrebbe consistere nel rovesciare le stronzate raccontate dall’impero e, con rispetto ma senza alcun sentimentalismo, rivisitare le culture travisate e diffamate sulle cui ossa sono stati impilati i sogni utopici di qualche conquistatore.
«Utopia» sta all’immaginario politico ideale come «Rhodesia» sta allo Zimbabwe, o «Gold Coast» al Ghana.
Come fare, dunque, per raggiungere Nuova Abraxa?
«Non credo che riusciremo mai a raggiungere l’utopia semplicemente andando avanti», afferma Le Guin in «Una visione non euclidea della California come luogo freddo», suggerendo, invece, la formula che i popoli della Swampy Cree First Nation hanno tradizionalmente usato per orientarsi verso il futuro: Usà puyew usu wapiw! «Vado indietro, guardo avanti». Un’espressione ispirata al porcospino, Erethizon dorsatum, che indietreggia nelle fessure della roccia, così da poter scrutare il pericolo che gli si para dinanzi. «Per poter speculare in modo sicuro su un futuro abitabile», scrive Le Guin, «forse faremmo bene a trovarci una fessura tra le rocce e ritirarci». Tutt’altro che iperbolico, l’aggettivo «abitabile» sembra, piuttosto, ammirevolmente sobrio al cospetto del degrado sociale ed ecologico causato dall’accelerazione neoliberale.
Nascosto tra le rocce, il porcospino è libero di progettare le proprie utopie. Inoltre, cosa altrettanto importante, andando indietro guardando avanti, può tentare di sfuggire alle incalzanti utopie di chi è al potere.
Ma le utopie dei potenti hanno già spianato molti paesaggi. Si distinguono per il loro potere livellante, per i cumuli di macerie che si lasciano alle spalle. E se spazzassero via tutte le rocce, e non ne lasciassero neppure una in cui nascondersi?
L’andatura difensiva del porcospino ne riporta alla mente un’altra. Una controparte, un’inversione struggente di tale movimento, il riscuotersi di una figura ormai da tempo tramutatasi in un cliché del pessimismo radicale, ma la cui infinita citazione (presente anche qui, in «I limiti dell’utopia») non riesce comunque a spogliarla del tutto del suo potere e della sua rilevanza.
L’angelo della storia di Walter Benjamin.
Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. […] Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. […] Ma una tempesta spira dal paradiso. […] Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta.1
Il porcospino indietreggia guardando avanti, scrutando i vari futuri possibili – per evitarne alcuni e pianificarne altri. L’angelo va avanti guardandosi indietro, in preda all’angoscia: si tuffa verso un futuro che non può vedere, rimpiangendo un passato che non può riscattare.
In quale direzione ci stanno conducendo le utopie predatorie? Il porcospino sta per essere strappato alla sua fessura e trascinato a tutta velocità nella loro corrente? Oppure l’angelo riuscirà ad afferrare le pareti del canyon, aggrappandovisi con le ali tese, a voltarsi e infilarsi nella fessura, per nascondersi allo sguardo e stringere i denti e affrontare il telos del vento?
Il porcospino diventerà un angelo, o sarà l’angelo a tramutarsi in porcospino?
Ancora una volta, le due cose non si escludono a vicenda. La storia di tutte le società finora esistite – come sottolineato più volte – è una storia di mostri, da entrambi i lati. Il nostro utopismo è già da sempre una chimera: Angelus erethizon, un porcospino dotato di ali celesti; un serafino irto di aculei.
E come quegli altri ibridi che alla fine sono riusciti a rovesciare l’orrenda utopia che li ha creati e disprezzati – i nostri cugini, gli uomini-bestia di More(au) – anche questa creatura dovrà imparare a muoversi secondo una nuova andatura chimerica, usando le sue parti e i suoi poteri in modo sgraziato ma efficace. A camminare sulle punte delle ali come su dei trampoli; ad afferrare con piume appuntite come aculei e aculei affilati come armi; a combattere su quattro zampe, su due, e su nessuna; e a nuotare – non è poi così lontano dalla riva – verso Nuova Abraxa.
Magari avanzerà come forse potremmo fare anche noi, secondo i dettami di un nuovo movimento, al tempo stesso animale e divino, senza essere nessuno dei due.
I limiti dell’utopia
Le distopie infettano i rapporti ufficiali.
Il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (ipcc) ha chiesto di abbattere di un terzo le nostre emissioni se vogliamo evitare il disastro più totale. Il kpmg, nel plumbeo chiacchiericcio del power-pointese aziendale, prospetta il medesimo orizzonte. Persino la nasa ha in parte finanziato un rapporto che avverte che il collasso sistemico della civiltà «è difficile da evitare».
Possiamo cavillare sui modelli, ma non sul fatto che la fine di tutto sia di fronte a noi, sotto gli occhi di tutti.
Il fetore e il fragore delle città avvelenate, i lugubri bunker sotterranei, i paesaggi coperti di cenere… il peggio è solo il meglio in malafede, e le distopie altro non sono che rimproveri intrinseci alla tradizione utopica. Bramiamo e ammoniamo: i nostri sogni migliori e i nostri incubi peggiori alleati contro la nostra veglia.
Se mandiamo tutto a puttane non ci resterà altro che una Terra bruciata, allagata, gelida, torrida, morta. E se invece facciamo tutto bene? Ci sono innumerevoli pre-sogni di Nuovi Eden, da Le Guin a Piercy e indietro nel tempo fino all’antichità; visioni che rimandano a quello che, quasi due millenni fa, il padre della Chiesa Lattanzio, nelle Istituzioni Divine, chiamava il «Mondo Rinnovato».
La terra sarà feconda e produrrà da sé i frutti più abbondanti; dai monti pietrosi colerà miele; scorreranno torrenti di vino e fiumi di latte; in breve, il mondo stesso si rallegrerà e la natura tutta esulterà, essendo stata salvata e liberata dal dominio del male e dell’empietà, della colpa e dell’errore.
E non è mai soltanto il mondo a essere in discussione: per Lattanzio, come in tutte le migliori utopie, lo è anche l’umanità. Il mondo si rallegrerà perché finalmente saremo capaci di abitarlo, liberi dal male e dall’empietà, dalla colpa e dall’errore con i quali lo abbiamo tartassato. Il rapporto tra l’umanità e quello che oggi chiamiamo ambiente sarà risanato.
Tuttavia una così ricca eredità non ha impedito a innumerevoli forme di ambientalismo di fallire, non solo nel proposito di cambiare il mondo, ma persino in quello di cambiare l’agenda per cambiare il mondo.
Noi che desideriamo un’altra Terra – una Terra migliore – siamo comprensibilmente orgogliosi di tenere in vita tutte le alternative in un’epoca che punisce chi pensa al cambiamento. Abbiamo bisogno di utopie. È quasi un fatto scontato, nell’attivismo. Se un’alternativa a questo mondo fosse inconcepibile, come mai potremmo cambiarlo?
Ma l’utopia ha i suoi limiti: l’utopia può essere tossica. A caro prezzo giunge la disperazione; ma che prezzo ha la speranza?
Nel 1985, un anno dopo che il California Waste Management aveva versato mezzo milione di dollari dei contribuenti alla società di consulenza Cerrell Associates per un’analisi sull’ubicazione ideale di tali controverse strutture tossiche, il governo cittadino annunciò che avrebbe installato un inceneritore di rifiuti a South Central Los Angeles. Il Cerrell Report è una sorta di manuale di istruzioni, una lista che delinea «i profili di personalità che oppongono minore resistenza». Tra le indicazioni vi è quella di puntare alle fasce di popolazione meno istruite. E agli anziani. Il rapporto avverte che «i quartieri di fascia socioeconomica media e alta dovrebbero trovarsi a una distanza di almeno 1-5 miglia dal sito designato».
Il target ideale sono i poveri.
Il fatto che la strategia sia questa non sorprende di certo. Ciò che fa quantomeno alzare un sopracciglio è il fatto che lo ammettano così candidamente. «Ma lo sapete», verrebbe quasi da sussurrare, «che riusciamo a sentirvi?».
In effetti la comunità locale ha opposto resistenza, e con successo. Ma quelli che vengono a volte chiamati Big Ten, i dieci maggiori gruppi ambientalisti – Sierra Club, Amici della Terra, National Resources Defence Council, Wilderness Society e via dicendo – hanno rifiutato di unirsi alla campagna. Questo perché, così hanno detto, non si trattava di una questione ambientale, bensì di una questione «sanitaria» della comunità.
Ecco la fallacia dei Big Green. Si comincia con euristiche quali «rurale vs urbano», o «natura vs società», e di fronte al potere oppressivo si finisce facilmente col diventare complici (o peggio) dell’ingiustizia ambientale, del razzismo. Questo semplicistico utopismo urbanofobico è in grado di mettere d’accordo il più nostalgico dei conservatori che cerca conforto nel verde di un parco nazionale e il più estroverso dei post-hippy intento a pubblicizzare una eco-start-up.
Per Lattanzio sarebbe stato Dio, prima o poi, a guarire la natura infranta. La nostra è un’epoca (più o meno) laica. Eppure, non tutti sono pronti a mettere da parte il messianismo: alcuni lo incorporano in una nuova, e ancor più vacua, totalità.
Nel 1968, Stewart Brand inaugurò il primo Whole Earth Catalogue con un’immagine del Pianeta Blu, l’Astronave Terra, una capsula di sopravvivenza sulla quale potersi coccolare reciprocamente. Accanto a essa un testo recitava: «Siamo come dèi, tanto vale imparare a farlo bene».
Ecco una bella totalità gaiana, dice l’immagine. Ed ecco il soggetto ecologico, dicono le parole che la accompagnano: «Noi». Un noi che, ovviamente, lascia senza risposta la scomoda domanda posta da Tonto al Ranger Solitario: «Chi è “noi”?».
Posti dinanzi alla portata di ciò che sta per accadere, tendiamo a rispondere con un banale, orribile contegno, una castrante cortesia green. «Qualunque cosa», diciamo, «è pur sempre meglio di niente». Da qui le soluzioni orientate al business, gli appelli a una razionalità economica improntata all’ecologismo. Il capitalismo, afferma Jonathan Porritt, un eminente ambientalista britannico, è l’unico gioco a disposizione.
Le imprese si adattano di conseguenza, in base alle loro priorità. A prescindere dagli schiamazzi dei loro negazionisti da compagnia, tutte le compagnie petrolifere possiedono almeno una divisione dedicata al cambiamento climatico – non tanto per combatterlo, quanto per pianificare i propri profitti nel mentre. Le multinazionali si stanno avventurando in nuovi territori della monetizzazione. Da qui il fugace boom dei biocarburanti, una presunta soluzione ai problemi del pianeta che ha condotto a una rapida deforestazione e a rivolte per il cibo, prima che quell’industria e quel mercato arrivassero a un punto morto. Si suppone che la mano invisibile ripulisca da sola i casini che crea, con sistemi di scambio di quote di emissioni e piccole compensazioni. Crescono le opportunità e gli incentivi per accordi loschi e stime gonfiate, inesorabilmente, come le emissioni. I carbon bond emessi dall’Unione Europea sono e restano spazzatura. Proliferano nuovi strumenti finanziari: derivati sul clima che rendono anche il caos climatico un buon affare. Le cosiddette obbligazioni sulla catastrofe passano di mano in vaste quantità, giacché una delle vittime del capitalismo è proprio la vergogna.
I cittadini si preoccupano dei propri rifiuti, che certo, senza dubbio, andrebbero assolutamente ridotti. Ma nel Regno Unito solo il 10% dei rifiuti viene prodotto dalle famiglie. Vale la pena ricordare che il concetto stesso di «inquinamento», inteso come atto individuale di abbandono dei rifiuti, è stato inventato nel 1953 dall’industria degli imballaggi americana, in risposta a un divieto locale sulle bottiglie monouso. Il calderone di sensi di colpa atomizzati e privatizzati nel quale siamo incoraggiati ad affannarci è un deliberato atto di depistaggio.
Su scala più ampia, le organizzazioni verdi più concilianti si occupano di nascondere alla vista l’intreccio di degrado ecologico, capitalismo e imperialismo in cui sono invischiate. Nel 2013 la Usa Environmental Protection Agency ha consegnato il National Climate Leadership Award alla Raytheon, per aver «affrontato la sfida del cambiamento climatico attraverso soluzioni pratiche, di buon senso e a basso costo».
Non è ancora chiaro se i droni fabbricati dalla Raytheon sfoggeranno il simbolo del premio, di modo che il loro impegno per la sostenibilità possa scintillare fiero mentre dispensano morte sui villaggi afghani.
Al servizio del profitto, persino piantare alberi – ufficialmente per controbilanciare le emissioni – può tramutarsi in una forma di violenza. Questi stratagemmi di compensazione delle emissioni per mezzo della riforestazione sostenuti dalle Nazioni Unite, noti come redd (Reducing Emissions from Deforestation e Forest Degradation), non sono semplicemente fallimentari, ma legittimano l’espropriazione dei terreni in nome del pianeta, così da consentire alle multinazionali di continuare a inquinare. In Uganda 22.000 agricoltori sono stati sfrattati per far spazio alle Nuove Foreste accreditate dall’Onu. Un vero e proprio piano aziendale. In Kenya, il popolo Ogiek rischia di essere scacciato con la forza dalla Foresta di Mau a causa di un progetto patrocinato dalle Nazioni Unite. E nel caso si necessiti di una metafora sfacciata, in Brasile il progetto di azione climatica di Guaraquecaba, finanziato da Chevron, General Motors e American Electric Power per impedire al popolo Guarani l’accesso alla sua stessa foresta impiega guardie armate chiamate Força Verde (Forza Verde).
Ambientalismo per mezzo dell’esproprio: quello che l’Indigenous Environmental Network ha denominato «Colonialismo del carbonio».
E nel frattempo gli stock dell’industria pesante salgono. Il recente rapporto dell’ipcc ha lasciato del tutto indifferenti i mercati finanziari: il valore che questi ultimi continuano ad attribuire alle riserve di petrolio, carbone e gas ignora del tutto gli obiettivi internazionali, secondo i quali la maggior parte di tali riserve non solo sarebbe ancora custodita tra le viscere della terra, ma dovrebbe anche rimanere dov’è. La bolla del carbonio proclama che bisogna scegliere tra la catastrofe climatica e un’altra catastrofe finanziaria.
O entrambe, ovviamente.
Dimenticate tutte le spurie totalità umane: vi è una nuova moderna totalità al comando, estremamente reale e pericolosa, con la quale buona parte dell’ambientalismo non è riuscito a fare i conti. Per usare le parole di Jason Moore: «Wall Street è un modo di organizzare la natura».
Lo stesso termine «Antropocene», ponendo l’accento sui fattori umani che determinano il cambiamento ecologico, con una mano dà e con l’altra toglie, traendoci in inganno con quell’implicito «noi». Dopotutto, che si tratti della deforestazione dell’odierna Gran Bretagna, o dell’estinzione della megafauna nel Nord America, o di altri innumerevoli esempi, l’Homo sapiens, l’anthropos, ha da sempre operato sul proprio –cene, l’ecologia di cui è parte integrante, modificando il mondo. Né ad amplificare queste alterazioni, fino ad allora relativamente locali, fino a renderle planetarie ed epocali – al punto da giustificare un nuovo termine geocronologico – è stata la nascita (come viene presentata da troppi resoconti storici, quasi fosse un evento miracoloso) dell’industria pesante, ma un mutamento dell’economia politica attraverso il quale l’industria è organizzata, e noi con essa: quel ciclo accelerato di profitto e accumulazione.
Ecco perché Moore, tra gli altri, ha a più riprese sostenuto che il nome di questa catastrofe potenziale non dovrebbe essere Antropocene, ma Capitalocene.
Le utopie sono necessarie. Ma non solo sono insufficienti: possono, in certi casi, divenire parte integrante dell’ideologia di sistema – la cattiva totalità che ci organizza, surriscalda i cieli e condanna milioni di persone al peonaggio su cumuli di immondizia.
L’utopia del «noi» è una menzogna. Giustizia ambientale significa riconoscere che non esiste una sola Terra, un «noi» senza un «loro». Che non siamo tutti sulla stessa barca.
Il che significa opporsi al fatto che le sanzioni per lo sversamento di sostanze tossiche in aree a predominanza bianca siano cinque volte superiori a quelle emanate per incidenti avvenuti in zone popolate da minoranze. Significa non solo dare di che vivere a chi sopravvive setacciando ammassi di rifiuti nelle discariche tossiche, ma anche lottare contro l’imperialismo dell’immondizia che le ha create, e al neoliberismo in virtù del quale i paesi più poveri competono tra loro per trasformarsi in depositi di spazzatura.
E significa opporsi direttamente al potere militare e alla violenza. Il numero di ambientalisti e attivisti per i diritti della terra uccisi nel 2012 è triplicato rispetto a dieci anni prima. Giustizia ambientale significa punire la Shell non solo per aver reso l’Ogoniland, in Nigeria, un pozzo degli orrori, una distesa di Ragnarok petrolchimici, ma anche per aver armato per anni lo stato nigeriano durante e dopo il governo di Sani Abacha.
Il commercio di armi, le dittature e gli omicidi sono parte integrante della politica ambientale.
Chi commette questi crimini non conta soltanto sulla quiescenza di coloro contro cui si scaglia, ma anche sulla loro debolezza. Il rapporto Cerrell è chiaro a proposito: «Tutti i gruppi socioeconomici tendono a risentirsi rispetto alla collocazione di grandi impianti di smaltimento nelle loro vicinanze, ma gli strati socioeconomici medi e alti possiedono migliori risorse per mettere in pratica la loro opposizione». In altre parole, i poveri devono essere il target non perché non lotteranno, ma perché, essendo poveri, non vinceranno. La battaglia per la giustizia ambientale è la battaglia per smentire questo assunto.
1 Walter Benjamin, Angelus Novus, Einaudi 1961, p. 80.
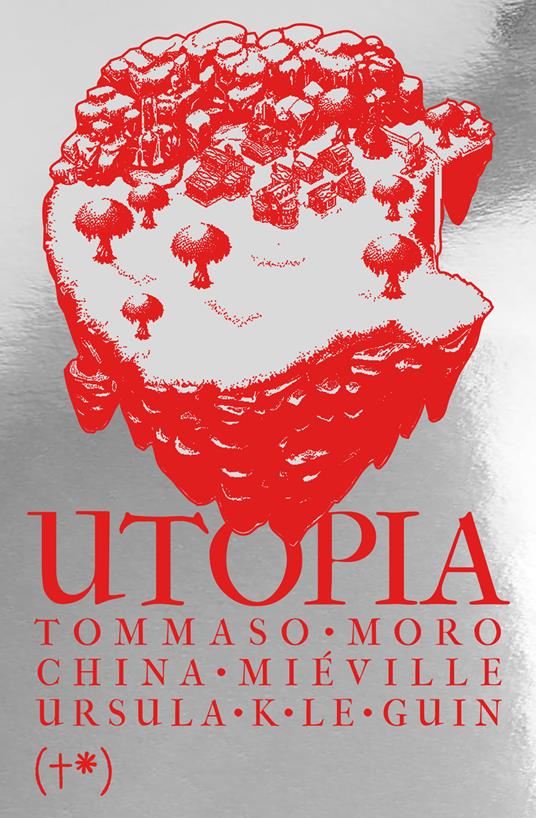
Pubblicato il: 21.03.2023