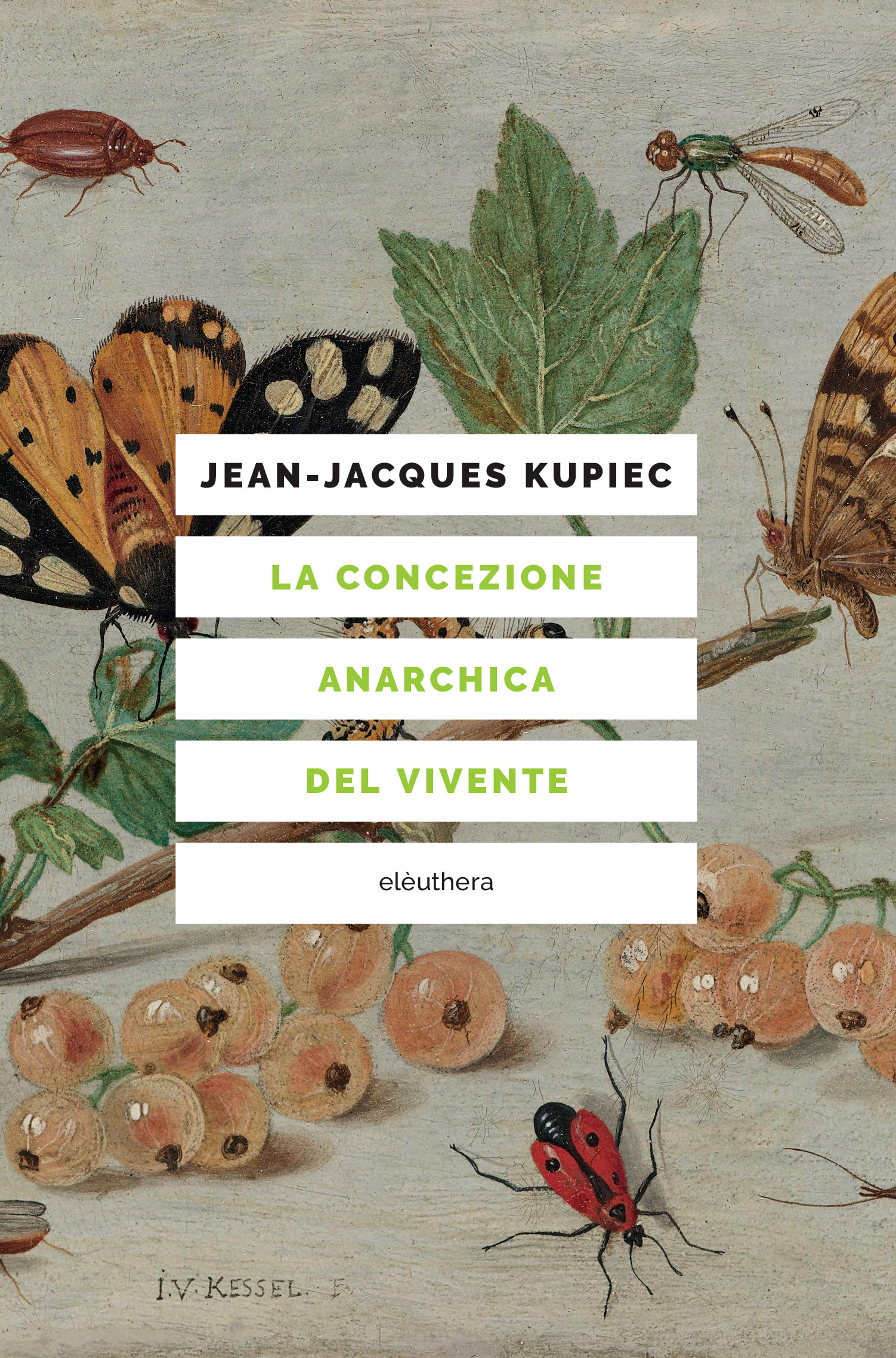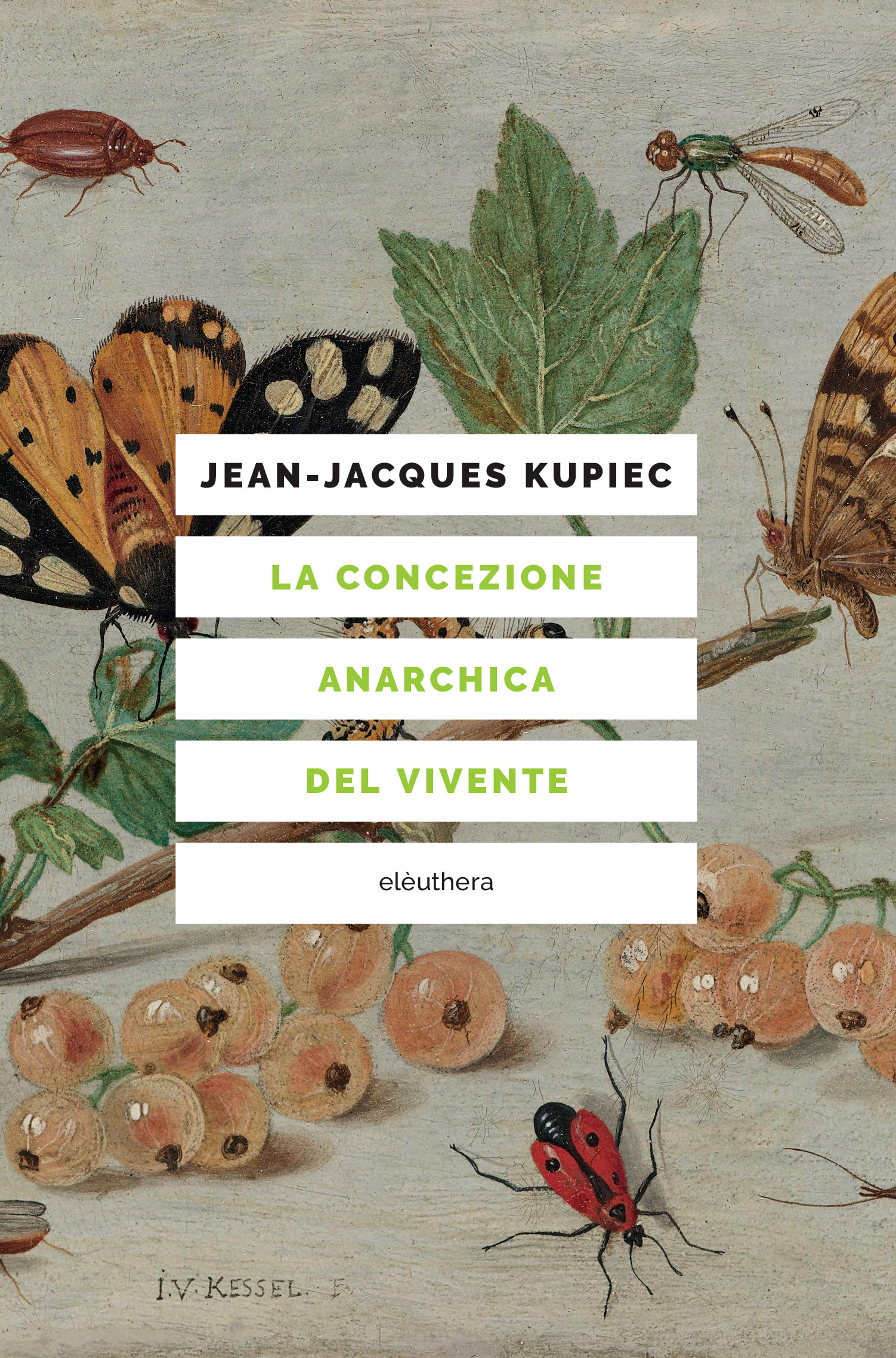Il biologo ed epistemologo Jean-Jacques Kupiec, nel suo straordinario libro La concezione anarchica del vivente, ci parla delle sua teoria biologica, elaborata in decenni di studi ed esperimenti, che lo porta a rimettere in discussione i presupposti deterministici della genetica. Il mondo è intrinsecamente ordinato o l’ordine è solo un principio della nostra mente che ci serve per afferrarlo? l’idea di ordine è un ostacolo alla comprensione del vivente? Nella biologia e nella genetica l’importanza della variabilità è evidente su ogni scala della vita, ma si vuol vederla solo come rumore. Non viene percepita come il segnale di un fenomeno intrinsecamente stocastico, ma come un margine di fluttuazione inevitabile in un quadro deterministico. Kupiec si spinge qui a sostenere che nel vivente non c’è un ordine stabilito bensì un disordine organizzato che rende possibile la vita e la sua evoluzione.
Il libro, da cui è tratto il brano proposto, è pubblicato da Eleuthera nella traduzione di Carlo Milani. Ringraziamo la casa editrice per la disponibilità.
L’idea di ordine, per non dire l’ossessione nei confronti dell’ordine, è di ostacolo alla comprensione del vivente. Poggia infatti sulla convinzione che ogni cosa sia determinata dalle relazioni che intrattiene con gli altri, che abbia un posto assegnato e che il mondo non possa esistere altrimenti. Questa idea imperversa in ogni ambito, ma il suo campo privilegiato è quello della vita.
L’essere vivente sarebbe, secondo questa interpretazione, un esempio perfetto di organizzazione e ciascuna delle sue parti esisterebbe esclusivamente per assicurarne il buon funzionamento. D’altronde, viene definito «organismo»: il nome stesso evoca tutta una filosofia.
È pur vero che ci sono coloro che sostengono l’«ordine dall’ordine», secondo i quali l’ordine biologico deriva da un ordine molecolare, a sua volta inscritto nei geni da loro chiamati «informazione genetica», e coloro che invece predicano l’«ordine dal rumore», secondo i quali l’ordine biologico deriva da un ordine molecolare perturbato da accidenti, in un processo che chiamano «auto-organizzazione». Tutti però sono concordi nell’affermare l’esistenza di un ordine del quale pretendono di spiegare la genesi.
Tuttavia, una scoperta contraddice l’idea stessa di ordine: il funzionamento del genoma è probabilistico. Basta dare un’occhiata alla storia della biologia per capirne l’importanza. Fin dall’antichità si è ritenuto ovvio che il caso non potesse essere un agente causale della vita.
Darwin ha senz’altro iniziato a sfatare questo luogo comune spiegando come gli esseri viventi si trasformino grazie a variazioni aleatorie sottoposte alla selezione naturale. Ma tale teoria riguarda solamente l’evoluzione.
L’ontogenesi, invece, continua a essere considerata un fenomeno deterministico. L’idea che il caso possa giocarvi un ruolo chiave non è stata quasi mai presa in considerazione. Così Erwin Schrödinger (1887-1961), quando nel 1944 getta le basi teoriche della biologia molecolare, contrappone l’inerte al vivente e riafferma il dogma deterministico erigendo l’ordine a principio fondamentale del vivente. Quel che viene chiamato «ordine» nel mondo inerte si produce a partire da ciò che viene definito «disordine».
L’ordine fisico macroscopico, cioè quello che si verifica al livello delle nostre percezioni, descritto dalle leggi deterministiche scaturisce dal comportamento probabilistico di atomi e molecole. Per via dell’immenso numero di particelle implicate in qualsiasi sistema fisico, le loro variazioni individuali si annullano rendendo trascurabile la variazione del sistema complessivo.
Schrödinger scarta l’idea che un simile «principio dell’ordine dal disordine» possa trovarsi all’opera nel vivente, sostenendo che l’ordine macroscopico derivi dall’ordine molecolare perché le molecole biologiche non si comporterebbero in modo probabilistico ma al contrario in maniera molto specifica.
Questo «principio dell’ordine dall’ordine» evocato da Schrödinger corrisponde a quella che alcuni anni dopo è stata chiamata «informazione genetica». Com’è noto, i biologi non pensano che il vivente funzioni secondo le leggi della fisica statistica, ma che sia invece guidato da un’informazione genetica codificata nel dna, la cui espressione corrisponderebbe a un programma.
Inizialmente teorizzato da Schrödinger, questo determinismo genetico è stato sostenuto in maniera ricorrente da tutti i nomi principali della biologia molecolare. Dopo il chiarimento della struttura del dna nel 1953, il concetto di informazione genetica è diventato la chiave universale per spiegare la vita. Per quanto riguarda l’espressione dei geni, si è pensato che alcune proteine regolatrici agissero come segnali binari, avviando o inibendo la loro attività. Si diceva quindi che un gene era «acceso» o «spento».
Di conseguenza, si è creduto anche che in una data cellula una proteina o vi era espressa o non lo era, e che tutte le cellule riceventi i medesimi segnali esprimevano i geni in maniera identica. Questa visione deterministica ha tenuto banco all’incirca fino agli anni Duemila. Prima era tecnicamente impossibile lo studio dell’espressione dei geni in singole cellule. I dati potevano essere ottenuti solo su grandi popolazioni di cellule prese tutte insieme. Perciò era possibile misurare solo la media dell’espressione genica in seno a grandi popolazioni cellulari.
Questa situazione si è evoluta quando nuove tecniche hanno consentito lo studio in singole cellule. È allora diventata evidente l’esistenza di una grande variabilità intercellulare di espressione genica.
Due cellule non esprimono mai i geni in maniera identica, anche se possono essere dello stesso tipo, possedere lo stesso genoma e vivere nello stesso ambiente, ricevendo quindi gli stessi segnali.
Tale variabilità intercellulare è spiegabile unicamente attraverso modelli stocastici (probabilistici, aleatori) nei quali ai geni vengono assegnate probabilità di espressione.
L’espressione stocastica (aleatoria) dei geni pone un problema: contraddice completamente il principio dell’ordine dall’ordine di Schrödinger. Colloca la probabilità nel cuore stesso della genetica e ne minaccia il fondamento.
L’espressione genica è il passaggio fondamentale che dovrebbe consentire ai geni di esercitare il loro potere. Se il loro funzionamento è aleatorio, come spiegare il fatto che eseguano in maniera precisa le istruzioni di un programma codificato nel genoma?
La questione è a tal punto essenziale che a buon diritto ci domandiamo se non sia il caso di rimettere in discussione l’attuale paradigma deterministico della biologia. Ed è appunto questo l’argomento del libro. Nel quale si sostiene che fin dalla nascita la genetica ha incontrato una serie di problemi derivanti dal suo determinismo, il cui punto culminante è stato toccato proprio con la scoperta dell’espressione stocastica dei geni.
Dal momento che questi problemi toccano le fondamenta stesse della genetica, non è possibile riformarla. È quindi necessaria una teoria anarchica che rifiuti l’ordine come principio primo e riconosca invece al suo posto la variazione aleatoria.
[…]
Molti esseri viventi vivono in gruppo. Si tratta dell’aspetto più visibile della propensione del vivente alla socialità. Esiste anche una socialità interna. La comparsa della multicellularità è una tappa fondamentale dell’evoluzione.
Piante e animali sono costituiti da una miriade di cellule e ciascuna di queste unità, potenzialmente in grado di vivere per conto suo, possiede tutte le proprietà della vita. Ciò che abitualmente percepiamo come essere vivente individuale è una molteplicità di unità individuali più piccole.
Un corpo vivente è in altri termini una società di cellule che lavorano per il mantenimento delle funzioni vitali. Come nella maggior parte delle società umane, anche qui si verifica una divisione del lavoro. Le cellule si specializzano in diversi compiti: le cellule neurali, muscolari, sanguigne, ossee e cutanee non fanno le stesse cose.
Si differenziano biochimicamente, morfologicamente e funzionalmente, nonostante siano tutte generate a partire da una stessa cellula-uovo che si moltiplica durante l’embriogenesi.
Comprendere il funzionamento degli esseri viventi implica una caratterizzazione della natura delle società cellulari: che tipo di relazioni intrattengono le cellule tra di loro e nei confronti dell’intero corpo? Come si differenziano le une dalle altre per formare tessuti specializzati?
Dobbiamo a questo punto riconoscere che la biologia moderna concepisce le società cellulari in maniera autoritaria. Già Schrödinger l’aveva espresso senza ambiguità parlando dei cromosomi come di un «principio dirigente contenuto in ogni cellula», paragonandoli a «uffici centrali» che dirigono le cellule in tutto il corpo:
Sapendo quanto potenti siano questi minuscoli uffici centrali nelle singole cellule, non sembrano queste ultime le sedi di un governo locale disperse in tutto il corpo e in grado di comunicare con grande facilità le une con le altre grazie al codice che è comune a tutte?
In questa visione autoritaria del vivente, il concetto di induzione svolge un ruolo centrale. Quando cambiano stato o realizzano una qualsiasi funzione, le cellule agirebbero in maniera determinata, in risposta a segnali veicolati da molecole dette induttrici.
In questo processo non ci sarebbe spazio per il caso, a meno che non venga ridotto a rumore. E questa non era solo l’opinione personale di Schrödinger, ma una visione profondamente radicata. Anche André Lwoff (1902-1994) ha espresso in maniera assai netta la visione di questo ordine molecolare autoritario:
In un organismo tutte le molecole devono lavorare in armonia. Ogni molecola deve sapere cosa fanno le altre. Ogni molecola dev’essere in grado di ricevere messaggi e dev’essere sufficientemente disciplinata per obbedire agli ordini […]. In una società molecolare ideale, ogni molecola lavora per la comunità, ossia per l’organismo. È quel che accade normalmente. Succede, però, che una molecola decida di sottrarsi alle catene del coordinamento, di lavorare per sé stessa e di vivere la propria vita. Ne derivano ogni sorta di malattie molecolari. La libertà molecolare è una catastrofe.
In questa prospettiva, dal momento che si suppone che le molecole induttrici (quelle che inviano gli ordini) siano delle proteine (o altre molecole che dipendono dalle proteine) e poiché la loro azione è programmata nel genoma, quest’ultimo è il potere centrale cui le cellule obbediscono.
Visto che la finalità del programma genetico è la costruzione e la gestione dell’organismo che forma una totalità integrata, le cellule sono agenti alienati il cui comportamento è predeterminato. Esse non lavorano e non vivono per sé stesse, ma per l’organismo che devono costruire.
Questa concezione deterministica si scontra con una massa di fatti empirici che la contraddicono. I biologi ne sono ben consapevoli. Sanno che il determinismo genetico dev’essere moderato da altri fattori, quali l’ambiente, i processi metastabili o l’epigenetica.
Da alcuni anni questa tendenza ha riscosso un grande successo. Si sente persino parlare di «rivoluzione epigenetica». In realtà non c’è nulla di nuovo. Tutto ciò non rimette in causa la genetica dalle sue fondamenta. Semplicemente, si considera che questi fattori la completino, sommandosi all’azione dei geni.
Fin dalle sue origini, il determinismo genetico è stato contraddetto da una massa di dati e i genetisti hanno cercato di integrare l’azione dell’ambiente. In passato questa integrazione si chiamava «norma di reazione». In effetti, la genetica presenta un problema cronico, mai risolto: il riconoscimento e lo studio empirico del ruolo dei fattori ambientali o epigenetici non spiegano a livello teorico come questo possa conciliarsi in maniera coerente con il suo postulato fondamentale, ovvero che la trasmissione dei caratteri ereditari è dovuta alla trasmissione dei geni.
Il problema del determinismo genetico risiede nel suo ricorso a una causalità deterministica. Per cui aggiungere il determinismo dell’ambiente a quello dei geni non è una soluzione. Non fa altro che raddoppiare il problema!
È allora necessaria una teoria che rompa con il determinismo, integrando pienamente la variabilità come motore del vivente, e al contempo spieghi come si articolano le azioni dell’ambiente e dei geni. Altrimenti ci si limita a un discorso doppiamente contraddittorio che consiste nell’affermare, da un lato, che i caratteri biologici sono determinati dai geni, come suppongono le leggi fondamentali della genetica, e nel ricorrere, dall’altro, a ipotesi ad hoc per compensare le falle di queste stesse leggi fondamentali. Vedremo che in effetti i genetisti tengono questo doppio discorso fin dagli albori della genetica.
Per uscirne, e così risolvere davvero i problemi che si sono posti alla genetica, bisogna riconoscere che la variazione aleatoria è una proprietà primaria del vivente, anche in biologia funzionale, e non un accidente del suo funzionamento deterministico. Il che procede di pari passo con una nuova concezione della società cellulare, in cui le cellule si comportano come farebbero i membri di una società anarchica autogestita: ogni individuo è libero, ma la sua libertà è limitata dalla presenza di altri individui della comunità che godono della medesima libertà.
Questo vincolo sociale sulle vite individuali genera un comportamento collettivo basato sul mutuo interesse di tutti, senza bisogno di uno Stato centralizzato che dia ordini. Allo stesso modo, le cellule individuali degli esseri viventi non hanno alcun bisogno di segnali di induzione o di ordini dettati dal genoma per cambiare di stato. Lo fanno grazie alla loro variazione aleatoria intrinseca.
Ma al tempo stesso si trovano continuamente in un ambiente interno differenziato che è il risultato, per ogni data cellula, dell’attività delle altre cellule. Questo ambiente interno agisce come un vincolo che limita la libertà cellulare.
Cambiando di stato in maniera aleatoria ogni cellula vi si adatta e ottimizza l’utilizzo delle risorse disponibili. In questo processo ogni cellula agisce per sé stessa, ma l’intreccio dei vincoli (ambienti interni differenziati) che lega tutte le cellule in seno alla società cellulare fa in modo che esse si comportino secondo l’interesse collettivo. Questa teoria, che spiega il principio generale della messa in opera della società cellulare nel corso dell’ontogenesi, consente di effettuare predizioni sperimentali e di sviluppare un nuovo programma di ricerca.