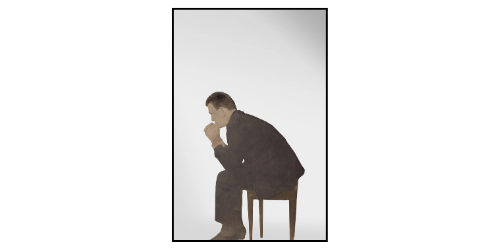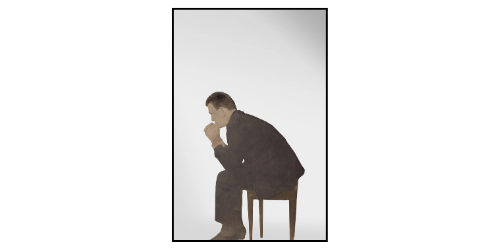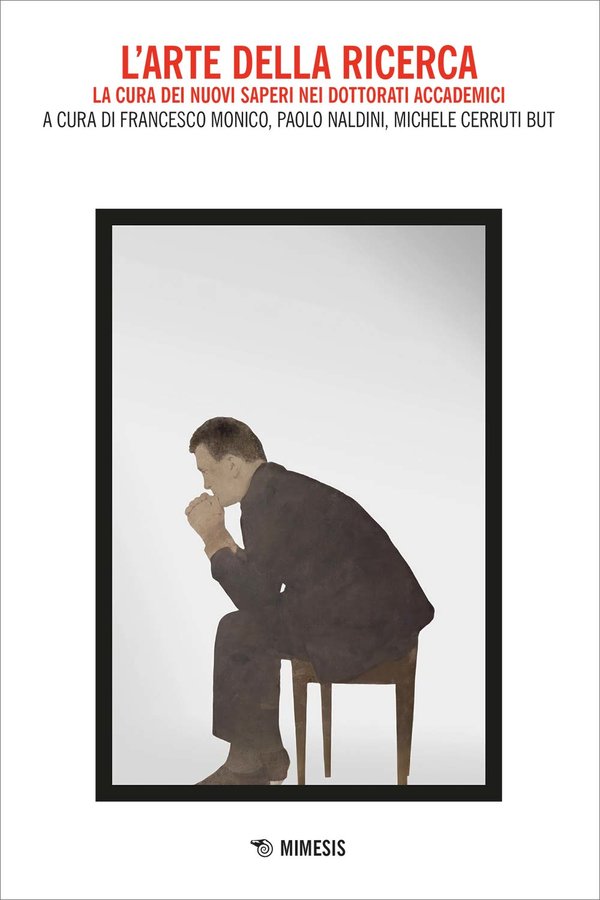Pubblichiamo oggi il terzo di tre estratti dal libro L’arte della ricerca. La cura dei nuovi saperi nei dottorati accademici – il libro che inaugura la nuova collana Arte e pratiche sociali a cura dell’Accademia Unidee, presso Mimesis edizioni. Il testo che qui leggete è tratto dal primo capitolo firmato da Francesco Monico: è un contributo che esplora il modo in cui la percezione e il valore dell’arte rappresentino l’eredità di un lungo dibattito moderno che ha posto le basi per considerare l’arte come un campo legittimo di ricerca speculativa. Lungi dall’essere univocamente e popolarmente legata alla bellezza o all’estetica, l’arte viene qui presentata come una prospettiva critica per esaminare il mondo contemporaneo.
Francesco Monico, PhD, è docente di Sociologia del mutamento presso l’istituto Isia Roma Design e di Filosofia dell’arte presso l’Accademia Unidee di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, già direttore fondatore di vari percorsi didattici e istituzioni in ambito AFAM (NABA, Accademia Costume & Moda, Accademia Unidee, PhD Planetary Collegium M-Node). Dopo gli studi di specializzazione al McLuhan Program in Culture & Technology presso la University of Toronto in Canada e il successivo PhD in Media e Arte presso la University of Plymouth in Inghilterra, si è specializzato nella ricerca sugli immaginari prodotti dallo sviluppo della tecnica.
Il testo riflette su come la percezione e il valore dell’arte siano cambiati nel tempo, evidenziando come i contributi di filosofi, artisti e movimenti culturali possano rappresentare oggi un degno campo della Speculative Research.
La ricerca speculativa esplora gli scenari e le possibilità attraverso l’immaginazione e la teoria critica, oltrepassa i metodi convenzionali focalizzati sulla raccolta di dati per indagare ipotetici sviluppi in vari campi quali la tecnologia, la società, l’economia e l’ambiente. Il suo obiettivo è stimolare il pensiero, promuovere la discussione e ispirare l’innovazione, mettendo in luce le implicazioni, nascoste o non percepite, di certe tendenze e generando ipotesi su come queste potrebbero evolvere.
Attraverso l’utilizzo di artefatti, prototipi, narrazioni, scenari e immaginari, cerca di evidenziare le sfide e le opportunità che le società potrebbero essere chiamate ad affrontare. La ricerca speculativa ha un potenziale impatto nei campi della progettazione, dell’architettura, della pianificazione urbana e dell’ingegneria tecnologica, ma in un’epoca di accelerazione e trasformazione come l’attuale, si sta diffondendo in ambiti quali la politica, la sanità e l’istruzione per esplorare nuove idee e strategie rispetto a questioni in rapidissima evoluzione. Attraverso l’approccio artistico si cerca di anticipare i cambiamenti e prepararsi meglio ad affrontarli, promuovendo allo stesso tempo l’innovazione e la creatività.
L’arte ha un valore quando le sue pratiche e processi costituiscono una ricerca di comprensione creativa di un nuovo comportamento, di nuovi ambienti, di nuovi orizzonti spirituali e sociali, e di un senso esteso del Sé. Nella cultura contemporanea, il nostro pianeta è telematico, la nostra cultura è emulsionata, la nostra mente è technoetica [1], il nostro corpo è trasformabile, e la nostra realtà è sincretica. Siamo impegnati nella riprogettazione di noi stessi, nella creazione di nuove reti sociali, e nuovi regimi di tempo e spazio. La cibernetica è implicata nella tecnologia delle New Media Art, il sincretismo informa la psiche. La para-noia privata viene annullata dalla tele-noia sociale. Un’ipercorteccia planetaria si sta evolvendo, e l’accesso al campo delle coscienze si amplia. (Roy Ascott 2007)
Il 7 maggio 1959 il fisico e romanziere inglese Charles Percy Snow tenne una conferenza all’Università di Cambridge intitolata Le due culture. Sosteneva che la rottura della dialettica tra le scienze e le discipline umanistico-artistiche, le “due culture” della società moderna, fosse un grave ostacolo alla soluzione dei problemi del mondo [2]. All’epoca l’accusa era rivolta verso una cultura umanistica che la faceva ancora da padrone nei programmi formativi inglesi, a differenza di quelli americani che invece puntavano di più sulle discipline scientifiche. Il critico letterario dell’Università di Cambridge Frank Raymond Leavis interpretò il richiamo alla seconda legge della termodinamica citato da Snow nel suo discorso come un tentativo da parte di questi di sminuire l’importanza della cultura umanistica [3]. Ne nacque la “controversia delle due culture”.
Storicamente la cultura occidentale ha sempre percepito una differenza tra la conoscenza oggettiva dei fatti di natura (Scienze della natura) e l’indagine creativa su ciò che pensano e fanno gli esseri umani (Scienze dello spirito).
La frattura tra le due culture è diventata sempre più evidente nel XX secolo allorquando lo scienziato e l’umanista sono divenuti delle professioni. Ludovico Geymonat sostenne che nessuno può essere così cieco da non rendersi conto che l’esistenza di due culture tanto diverse costituisce un motivo di crisi della nostra civiltà. Giuseppe O. Longo, informatico e scrittore, affermò che il problema della diversità e della lontananza tra cultura letterario-umanistica e scientifico-tecnica è sempre più attuale per effetto dell’accelerazione dello sviluppo tecnologico-scientifico e delle problematiche presentatesi all’umanità nella contemporaneità.
Perché si è avuta una vera rivoluzione: la velocità dell’innovazione tecnica è cresciuta a dismisura, soprattutto grazie alle macchine che elaborano e trasmettono l’informazione. L’importanza assunta dalla tecno-scienza e il predominio esercitato dall’economia e dal mercato richiedono una ridefinizione del sapere (Longo 2005). La questione era stata posta da Percy Snow puntando il dito da un lato verso gli scienziati con “il futuro nel sangue” in quanto animati da un radicale progressismo superficiale; e dall’altro accusando gli artisti e gli umanisti di limitare la riflessione sull’arte a una riflessione troppo personale e soggettiva. Questa differenza, vera e propria “différance” della ricerca, è quindi diventata reale tra le università e le accademie di Belle Arti [4].
Nel 1998 il biologo di fama mondiale Edward O. Wilson pubblicò L’armonia meravigliosa. Dalla biologia alla religione, la nuova unità della conoscenza (1999) nel quale con consilienza – o convergenza o concordanza di prove – propose la spiegazione di un dato fenomeno mediante l’accordo fra diverse induzioni provenienti da diverse fonti di dati e domini della conoscenza. Il termine deriva dallo storico della scienza ottocentesco William Whewell, che coniò la frase “consilienza di induzioni” (“consilience of inductions”) riferendosi a un “salto congiunto in avanti” della conoscenza attraverso l’apporto di più domini della conoscenza. Wilson, dall’alto della sua autorità di scienziato, asserì la necessità di integrare il metodo scientifico con la conoscenza umanistica. Sostenne che la consilienza ci permette di avanzare sulle questioni tradizionalmente appartenenti ai domini dell’arte e delle discipline umanistiche, ovvero etica, cultura, creatività fino alla questione della mente.
Sono queste le premesse fondanti di fronte alla questione di una ricerca dottorale nelle accademie di Belle Arti.
***
Nell’immaginario comune le accademie di Belle Arti sono luoghi dove si studia e si produce il bello. È una definizione semplicistica e molti storceranno il naso poiché dalla fine del XIX secolo l’arte ha sostituito il bello con l’interessante [5].
Era stato con il Cristianesimo prima e quindi durante il Medioevo, che l’arte divenne importante. La bellezza venne posta in chiave mistico-spirituale e questo naturalmente fece sì che non si potesse parlare di arte al di fuori di un supposto bello. L’arte era veicolo di una concezione di natura divina: e così era bello ciò che in qualche modo manifestava la grazia divina, l’ordine divino del mondo. Nel rinascimento nacque l’idea di ingegno, l’idea di un soggetto incarnato nel genio e nella creatività.
L’idea di estetica così come l’abbiamo noi oggi è moderna, fondamentalmente nata come teoria filosofica nel ’700 con Alexander Gottlieb Baumgarten per distaccare l’esperienza dei sensi da qualsiasi pregiudizio ed elevarla a campo di studio umanistico riguardante la conoscenza specificatamente attraverso i sensi e il bello. Nella sua opera Aesthetica, Baumgarten sviluppa l’idea di una forma di conoscenza basata sulle percezioni sensoriali e non sull’intelletto razionale, sottolineando così l’importanza delle emozioni e delle sensazioni nell’esperienza conoscitiva. La consapevolezza dell’influenza delle emozioni innescata dal bello aumenterebbe la comprensione e l’apprezzamento del mondo, in una parola, della conoscenza stessa (Baumgarten 1758).
Questo approccio pose le basi per una nuova interpretazione del giudizio, incentrato più sul piacere e sulle emozioni che sulla misurazione e descrizione razionale. Quindi l’estetica si strutturò ulteriormente allorché le categorie del bello e del sublime vennero poste da Kant, il quale utilizzò proprio il testo di Baumgarter per il suo insegnamento (Kant 1790). L’arte viene sistemata senza concetto; non c’è necessità di concetti per comprendere l’arte: la si comprende a-concettualmente perché la sua natura non è quella di essere logico-razionale. L’arte viene collocata nella categoria di ciò che si manifesta in sé stesso, in modo a-concettuale, mostrando tutta la complessità dell’animo umano.
È Hegel, quindi, a originare la vulgata che l’arte nella modernità si fa così pregna di elementi intellettuali e teorici da perdere ogni immediatezza estetica [6]. All’opposto è l’idealismo romantico a veicolare con eroismo il primato del segno estetico sulla cognizione. Se per Hegel la “razionalizzazione” è espressione propria della modernità occidentale, all’opposto i romantici si oppongono a un’intellettualizzazione nominalista, ma questo dinamico confronto soccombe di fronte alla scienza, all’industrializzazione e all’affermarsi della borghesia imprenditoriale.
Dalla rivoluzione industriale in poi l’arte si libera di ogni valore cultuale, fino ad allora praticamente egemone, e assume una dimensione riflessiva, così che sul finire del XIX secolo il bello è bello, se e solo se, implica l’interessante.
La filosofia novecentesca mantiene il principio fondamentale di Kant, ovvero che l’esperienza estetica non abbia niente a che fare né con l’esperienza teoretica né con l’esperienza morale: quando si fa arte, quando si giudica qualche cosa bella, non si dice né se sia vera o falsa né se sia buona o cattiva, ma si esprime semplicemente qualche cosa che non ha a che fare né con la teoria né con la pratica nel senso etico della parola. Questa idea che l’arte non abbia a che fare con questi valori di verità o di bellezza o di bontà, di valore morale, ecc., ha finito per costruire intorno all’arte una specie di alone di indipendenza, di autonomia, ma anche di vacuità. Infatti se è vero che l’arte in tal modo risulta autonoma, non si può condannare un’opera d’arte perché non dice la verità e ciò non ha nessun senso.
Alcuni filosofi del XX secolo hanno invece a cuore il problema dell’arte e della sua verità. Theodore W. Adorno è un autore della cosiddetta “teoria critica”, ovvero quella teoria nata sull’onda dei processi in atto nei primi decenni del Novecento: il dispiegarsi del pensiero calcolante, l’avvento della medicalizzazione, il mercantilismo, il consumismo, l’economicizzazione e finanziarizzazione della vita, e, appunto, il ruolo dell’arte. L’ultima opera che ha scritto, uscita postuma nel 1970, è intitolata proprio Teoria estetica.
Qui ci sono le basi per una concezione delle avanguardie artistiche, come di movimenti che si rivoltano a starsene tranquillamente dentro una cornice rispettata e neutralizzata dell’arte. Il primo paragrafo della Teoria estetica di Adorno è intitolato: L’ovvietà dell’arte è andata perduta. Cioè, l’arte non può produrre opere se non mettendo anche in discussione il proprio stato, la propria situazione, la propria collocazione storica, sociale, culturale. Da qui emergono una quantità di conseguenze critiche: gli artisti, secondo Adorno, a differenza di Benjamin, sono tali quando producono opere che perturbano, che danno a pensare. Per Adorno le opere d’arte sono quelle che richiamano l’attenzione per gli elementi di inquietudine che ci forniscono, anche e soprattutto rispetto al che cosa sia l’arte: qui l’arte ritrova l’arte come esperienza di verità.
Riproponendo l’arte come esperienza di verità, il XX secolo si sviluppa con una cognizione d’arte definita non più da estetiche sensoriali bensì da elementi intellettuali quali le riflessioni politiche, sociali, filosofiche, antropologiche. La riflessione novecentesca recupera il binomio arte-verità continuando a escludere il bello. Così, all’interno della rappresentazione artistica, il primato viene assunto da un approccio nominalistico e dai susseguenti concetti [7]. Se il primato nella rappresentazione è la riflessione, ciò vuol dire che la nostra epoca è segnata da discorsi concettuali e il primato artistico diventa anch’esso parte della filosofia e della scienza. Questo perché, nella misura in cui l’arte assume in sé elementi sempre più nominalisti e razionali, riconosce e assume il primato del concetto.
Tuttavia, tale primato contemporaneamente si contrappone a un’ostinazione propria dell’arte che vuole restare estetica e bella. Questa è la condizione dell’arte ipermoderna; essa, non potendo più pretendere alcun primato, indipendenza gnoseologica ed epistemologica, come invece i romantici avevano reclamato, si colloca all’interno di un processo di razionalizzazione della cognizione umana: “il futuro nel sangue”, l’ottimismo superficiale denunciato da Percy Snow fino a quell’esigenza di “new knowledge” che il modello contemporaneo e camaleontico del capitalismo impone (Boltanski, Chiapello 1999). Quindi, l’arte contemporanea oggi è un’arte ragionevole, eminentemente intellettuale e ogni gesto artistico è chiamato a giustificarsi all’interno di un paradigma di validazione nominalista. Questo nominalismo dell’arte ne determina la fine di ogni immediatezza, implicando il senso nelle premesse, e giustificandosi nelle discorsività a loro volta implicate, risultando così interessante.
Ma l’artista è tradizionalmente visto come un’antenna sensibile alle dinamiche culturali, sociali e storiche del tempo e per ciò vive il presente, cosa non così scontata nella misura in cui l’umano è sociale e per questo sempre indietro nella percezione del mondo.
Infatti, affinché un significato acquisisca verità si ipotizza per convenzione che debba essere condiviso da almeno cinquanta milioni di individui, e perché ciò avvenga ci vuole tempo, che, seppur oggi accelerato a causa dell’avvento dell’ubiquità isomorfica dei media digitali, abbisogna sempre e comunque di una latenza [8]. Ecco che l’artista è colui che si fa antenna della cultura e capta il presente come senso delle nuove proporzioni tra umani, non umani, viventi e non viventi. Facendo ciò, l’artista non solo risponde alla cultura, ma è sempre un passo avanti nella comprensione del mondo e agisce come un medium attraverso il quale la cultura stessa può essere interpretata, criticata o riflessa (McLuhan 1962).
In sostanza, l’artista è visto come un catalizzatore delle influenze del proprio zeitgeist, come colui che con le sue opere riflette la complessità e la ricchezza della società in cui vive. Come ha ricordato Papa Francesco all’incontro degli artisti presso la Cappella Sistina nell’estate del 2023, “l’artista è un bambino […] che si muove anzitutto nello spazio dell’invenzione, della novità, della creazione, del mettere al mondo qualcosa che così non si era mai visto” (Papa Francesco 2023).
La ricerca artistica ha la capacità di immaginare nuove versioni del mondo, le quali introducono novità nella storia. Riappare quindi l’opera artistica che mostra a-concettualmente tutta la complessità dell’essere umano e si fa cultura al suo massimo livello (Croce 1929) [9]. Si produce però un’aporia: ovvero, come fa una teoresi a-concettuale a produrre concetti? A maggior ragione se la teoresi, per essere tale, ha abbracciato proprio il concettualismo nominalista – ovvero non il segno estetico, il bello –, come fa a manipolare proprio ciò che essa stessa nega?
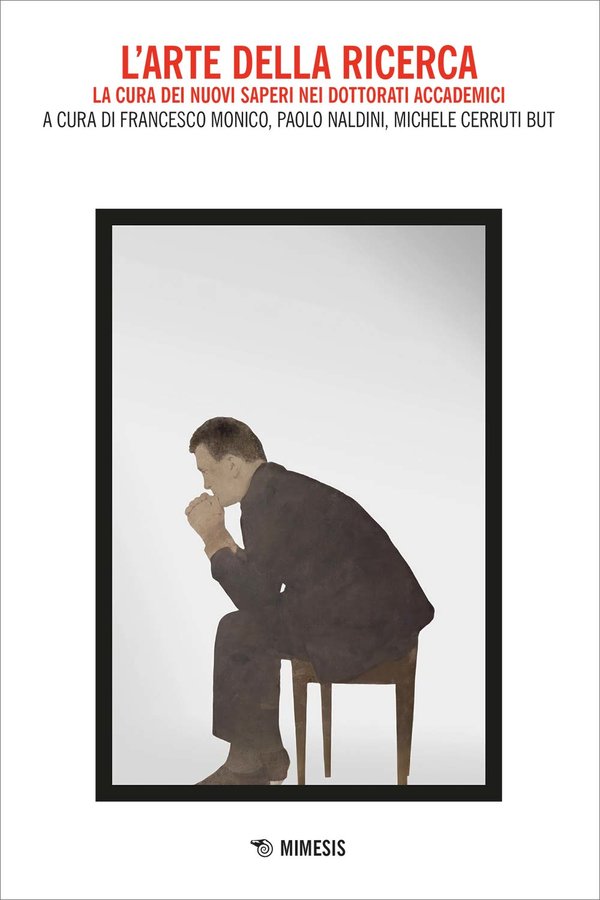
1. Il termine è un’unione tra techne e noetikos: tecnoetica è quella speculazione che concerne l’impatto della tecnologia sui processi della coscienza.
2. Rede Lecture dell’Università di Cambridge del 7 maggio 1959 dal titolo Le due culture, quindi pubblicata come Le due culture e la rivoluzione scientifica (1959), in Italia da Feltrinelli con prefazione di Ludovico Geymonat nel 1964.
3. Leavis ha introdotto l’idea del “terzo regno” come nome per il metodo di esistenza dell’arte letteraria; opere che non sono private come un sogno ma esistono nella mente umana come opera di cultura collaborativa.
4. Il termine différance (Derrida 1972) rende conto della procedura della significazione, in quanto rende conto delle condizioni di possibilità di ciò che è presente: il differire da sé, l’essere altro, quale condizione della presenza, dunque del senso. La procedura della significazione artistica si distingue da quella scientifica non solo per il metodo, ma per la natura stessa del senso che produce: tra le due si istituisce una différance, nel senso derridiano del termine, ovvero un differimento e uno slittamento del significato che impedisce una chiusura univoca e oggettivante.
5. L’idea del testo sarebbe proprio quella di “volgarizzare” il discorso sulla produzione di sapere delle accademie per sdoganare l’autonomia metodologica delle stesse rispetto all’università. Quindi, accanto a un’idea volgare come quella di “bello”, allo stesso tempo vi è la vulgata di Hegel quale sorta di teorizzatore della Rationalisierung o del pensiero calcolante, che certamente non è corretto ma è viabile.
6. Quando Hegel dice che “il reale è razionale” non sta dicendo banalmente che è razionale quello che esiste di per sé, ma ciò che esprime nell’esistere un concetto, ovvero il reale. Secondo Hegel il reale deve essere anche inteso come un processo di razionalizzazione, uno svolgimento dell’idea che si fa sempre più vera nel suo realizzarsi storico. La vulgata moderna tende a ridurre Hegel a un pensatore conservatore, per il quale tutto ciò che è esistente sarebbe ipso facto razionale. In realtà, egli distingue tra l’esistente e il reale: solo ciò che è intrinsecamente razionale merita, nel suo sistema, il titolo di realtà.
7. Per nominalismo si intende quella tradizione di pensiero che nega ogni esistenza reale alle entità astratte – concetti, idee, universali – riducendole a mere convenzioni linguistiche o segni funzionali. Da questa linea, che dai filosofi stoici giunge a Guglielmo di Occam e a Thomas Hobbes, si dipanano sviluppi che porteranno al pragmatismo moderno e al pensiero calcolante-razionale, fondato su un teatro linguistico che definisce, quantifica e misura il mondo. In tal senso, il nominalismo diviene il sostantivo implicito di un razionalismo radicale, che assume il linguaggio come unica matrice di realtà.
8. È solo una mera convenzione quella che stabilisce che, affinché un fatto/concetto sia condiviso come vero, debba essere conosciuto da un numero minimo di persone. Tale valore minimo accettabile sarebbe quantificabile in cinquantamila individui su un totale di otto miliardi di abitanti.
9. Sorge qui necessaria la domanda “che cos’è l’arte?”, e una delle risposte plausibili ci viene fornita proprio da Croce nell’Aestetica in nuce: non può dirsi né sentimento né immagine né somma dei due, ma contemplazione del sentimento o intuizione pura di ogni riferimento storico e critico alla realtà (intuizione lirica). Secondo Croce, l’arte in quanto intuizione coglie il puro palpito della vita nella sua idealità.