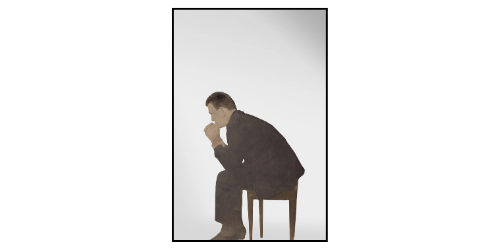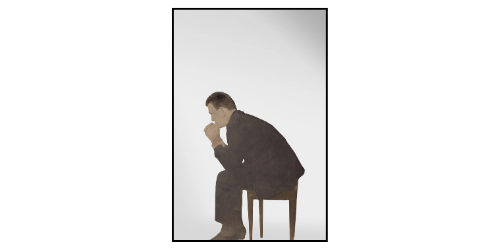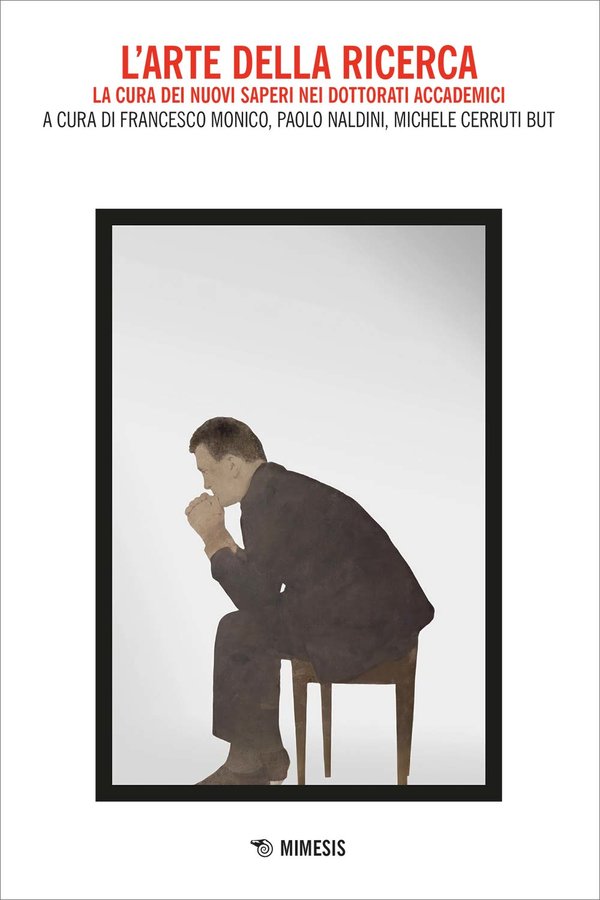Pubblichiamo oggi il secondo di tre estratti dal libro L’arte della ricerca. La cura dei nuovi saperi nei dottorati accademici – il libro che inaugura la nuova collana Arte e pratiche sociali a cura dell’Accademia Unidee, presso Mimesis edizioni. Il testo che qui leggete è tratto dal capitolo “La controversa idea di ricerca artistica” di Michele Cerruti But, il brano articola una documentata e profonda riflessione sulle possibilità che la ricerca artistica possiede ai fini di incrementare la comprensione e la conoscenza dei problemi e delle soluzioni della nostra contemporaneità e la produzione di nuovo sapere.
Michele Cerruti But è coordinatore accademico di Accademia Unidee e docente presso il Politecnico di Torino. Nella sua ricerca, che è sempre all’incrocio di discipline diverse, studia i modi in cui si producono lo spazio e i vettori di trasformazione del territorio. Ha studiato a lungo le forme spaziali della produzione contemporanea soprattutto nei territori mediali, piattaforma della modernità occidentale. Si occupa delle forme di ingaggio dell’arte nella costruzione di futuri e di urbanistica come progetto relazionale.
Il dibattito intorno a cosa sia la ricerca artistica, su come si debba (o si possa) fare, ma anche su come si debba (e possa) valutare, attraversa in modo violento il mondo culturale e scientifico da decenni; almeno dal 1979, quando l’UNESCO si trova a formalizzare gli strumenti di standardizzazione statistica internazionale, in particolare intorno ai temi della ricerca e dello sviluppo, ed esclude da questa lista “la ‘ricerca’ artistica, di qualunque tipo” (UNESCO 1979). Sullo stesso piano, peraltro, si colloca anche la “ricerca progettuale”, che parimenti si confronta con una dimensione di “incertezza”, “incomparabilità”, “impossibilità di riproducibilità”, ecc. (OECD 2015, p. 64).
Con almeno tre implicazioni: da un lato, la percezione comune che l’arte operi in un ambito esterno alle urgenze della società, e che quindi non sia rilevante rispetto al confronto con il futuro. In secondo luogo, la minorazione dell’agency di artisti, designer o di studenti che si sono laureati in queste discipline rispetto alle sfide del contemporaneo, e dunque la riduzione dell’impatto che la loro ricerca artistica potrebbe avere. In terzo luogo, la fragilità delle istituzioni dell’alta formazione artistica nell’implementazione di curricula solidi che giungano fino all’erogazione di titoli di dottorato.
Nonostante questo, da decenni artisti e designer ingaggiano loro stessi e la loro ricerca (individualmente, ma anche collettivamente o come parte di gruppi) con tutte le questioni pressanti che l’umanità sta affrontando. Tuttavia, la loro voce non ha l’impatto che potrebbe avere nell’affrontare le sfide e ridefinire i problemi della realtà: sfide certamente complesse e interconnesse, che si estendono dai campi delle disuguaglianze sociali (economiche, di genere, di abilità o di sessualità), a quelli della giustizia (climatica), della guarigione del pianeta e della perdita endemica della biodiversità. Di fatto, la debolezza epistemologica, ontologica e di valutabilità delle ricerche artistiche e progettuali segnano una frattura reputazionale o di credibilità che impedisce alla ricerca artistica di essere riconosciuta e riconoscibile come in grado di contribuire in modo rilevante rispetto alla comprensione del contemporaneo, la produzione di nuova conoscenza, la definizione di strategie o chiavi per affrontare le urgenti sfide del presente.
Tale tensione tra queste tre forze non coincidenti (da un lato l’ambizione dell’arte e del design di “ingaggiarsi”, “avere una voce” e tuttavia mantenersi libera, dall’altro la non riconoscibilità della ricerca artistica come driver dello sviluppo da parte dell’OECD, in ultimo il tentativo di istituzionalizzazione della ricerca operata dalle accademie e dal Processo di Bologna) genera uno spazio di produzione di realtà (Cerruti But et al. 2017) che costruisce traiettorie di critica tanto teoriche quanto sperimentali che mettono in crisi la ricerca artistica stessa. Posto che tale ricerca sia una declinazione istituzionalizzata del capitalismo (Burton-Jones 1999), o una tendenza specifica dell’arte contemporanea, l’intera controversia si confronta, in definitiva, con la questione definitoria: ontologica, epistemologica e metodologica. Un’impasse che può forse superarsi nella comprensione dell’arte (e della scienza) come forme o istituzioni storiche (Schwab 2023), aprendo in tal modo a una ricerca (tanto artistica quanto scientifica) profondamente libera, e in grado di confrontarsi con le sfide della contemporaneità.
Elementi per la ricostruzione del dibattito
Nel 1979 l’UNESCO si trova a formalizzare degli strumenti di standardizzazione statistica internazionale, in particolare intorno ai temi della ricerca e dello sviluppo, ed esclude la ricerca artistica. La ragione è definita: si tratta di “comparabilità internazionale delle statistiche” (UNESCO 1979, pp. 23-35). L’approccio suggerito consiste nel classificare i dati della ricerca e sviluppo in termini di
campi della scienza e della tecnologia in cui le istituzioni appartenenti ai settori dell’istruzione superiore e dei servizi generali svolgono attività di ricerca e sviluppo. (Ivi, p. 27)
Questa classificazione individua le Scienze naturali, l’ingegneria e tecnologia, le Scienze mediche, le Scienze agrarie, le Scienze sociali e umanistiche. Queste ultime sono poi divise in due gruppi ed è nel gruppo II, le scienze umane, che troviamo le lingue, la filosofia, la storia, la religione e le arti. Tra queste ultime, la “storia delle arti e critica d’arte, esclusa la ‘ricerca’ artistica di qualsiasi tipo”. In buona sostanza, la ricerca artistica non è neppure da considerarsi “ricerca”, sembra osservare quel testo, con un uso se non altro inaspettato delle intenzionali virgolette che pare suggerire come talvolta vi si possa fare riferimento (in modo improprio) in questi termini (Borgdorff 2009).
Il Manuale di Frascati dell’OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), che già nel 1963 aveva impostato il pensiero intorno al ruolo della ricerca per lo sviluppo economico intorno a tre parametri (la ricerca di base, la ricerca applicata, lo sviluppo sperimentale) incorpora le indicazioni dell’UNESCO solo nella sesta versione (OECD 2002). Allo stesso modo che nella Risoluzione di Parigi del 1979, anche qui si ritiene che
le discipline umanistiche siano una categoria a sé stante accanto alle scienze sociali, divise tra: storia, lingue e letteratura, altre scienze umane. Le “altre scienze umane” sono ulteriormente specificate come “filosofia (compresa la storia della scienza e della tecnologia)”, arti, storia dell’arte, critica d’arte, pittura, scultura, musicologia, arte drammatica, esclusa la “ricerca” artistica di qualsiasi tipo, la religione, la teologia. Le modifiche sono degne di nota e strane, ma non hanno bisogno di ulteriori commenti in questa sede. La questione che sto evidenziando è l’insistenza con cui la ricerca artistica viene esclusa ancora una volta dal dominio della ricerca e dello sviluppo. (Borgdorff 2009, trad. dell’autore)
Un’ulteriore conferma della posizione si ha con la versione aggiornata del Manuale di Frascati (OECD 2015), perché in questa versione la ricerca artistica viene – mi pare per la prima volta, a livello internazionale – identificata in una forma più articolata, che inevitabilmente raccoglie i dati di un dibattito tanto epistemologico quanto ontologico che la comunità scientifica e culturale aveva nel frattempo prodotto. La ricerca artistica infatti viene distinta tra le forme di ricerca per le arti, ricerca sulle arti ed espressione artistica (OECD 2015):
In order to address the discussion of R&D and artistic creation, it can be useful to make a distinction between research for the arts, research on the arts and artistic expression.
Pur osservando la ricchezza dell’articolazione suggerita, quel che tuttavia emerge è come la ricerca svolta attraverso l’arte e il design, che usa cioè i mezzi e i linguaggi propri dell’arte e del design per produrre risultati, non venga per nulla tenuta in considerazione, rispetto alla rilevanza in ordine alla Ricerca e Sviluppo (R&S).
L’espressione artistica, invece (che sarebbe di per sé “il mezzo e il linguaggio” di una ricerca svolta “attraverso” arte e design) è addirittura contrapposta alla ricerca:
Le performance artistiche sono normalmente escluse dalla R&S. Le performance artistiche non superano il Criterio di Novità della R&S in quanto sono alla ricerca di una nuova espressione, piuttosto che di una nuova conoscenza. Non è inoltre soddisfatto nemmeno il Criterio della Riproducibilità (come trasferire la conoscenza aggiuntiva potenzialmente prodotta). Di conseguenza, non si può ritenere che licei artistici e i Dipartimenti di Arte delle Università svolgano attività di R&S senza ulteriori prove di supporto. L’esistenza di artisti che frequentano corsi in queste istituzioni non è rilevante ai fini della misurazione della R&S. Tuttavia, gli istituti di istruzione superiore devono essere valutati caso per caso se concedono un dottorato a un artista come risultato di prestazioni artistiche. La raccomandazione è di adottare un approccio “istituzionale” e di prendere in considerazione solo le pratiche artistiche riconosciute come R&S dagli istituti di istruzione superiore come R&S potenziale (da utilizzare ulteriormente da parte dei raccoglitori di dati). (OECD 2015, 64, trad. e corsivi dell’autore)
Anche il design non è da ritenersi R&S:
Alcune attività di progettazione possono essere considerate R&S nella misura in cui svolgono un ruolo in un processo di sviluppo del prodotto, che mira a qualcosa di “nuovo” (ma non necessariamente a nuove conoscenze), è creativo e originale, può essere formalizzato (eseguito da un team dedicato) e porta a un risultato codificato da trasmettere al team di sviluppo. La differenza principale con la R&S è che è probabile che non ci siano incertezze quando si chiede ai designer qualificati di contribuire a un progetto di innovazione. Ciò porta a ritenere che la progettazione [il design] non sia R&S e che debba essere tenuta distinta dalla R&S per qualsiasi scopo statistico (ibidem).
Alcune attività di progettazione possono essere considerate R&S nella misura in cui svolgono un ruolo in un processo di sviluppo del prodotto, che mira a qualcosa di “nuovo” (ma non necessariamente a nuove conoscenze), è creativo e originale, può essere formalizzato (eseguito da un team dedicato) e porta a un risultato codificato da trasmettere al team di sviluppo. La differenza principale con la R&S è che è probabile che non ci siano incertezze quando si chiede ai designer qualificati di contribuire a un progetto di innovazione. Ciò porta a ritenere che la progettazione [il design] non sia R&S e che debba essere tenuta distinta dalla R&S per qualsiasi scopo statistico (ibidem).
Va tuttavia detto che accanto a tali posizioni piuttosto rigorose, nei quarantacinque anni che vanno dal 1979 a oggi, si sono susseguite non solo alterne vicende legislative, ma anche molteplici esperienze di esplorazione e sperimentazione della ricerca artistica e delle sue applicazioni sociali, portando a risultati talvolta acclamati, talaltra fallimentari o non riconosciuti. Rappresenta in questo senso una svolta il rivolgimento del sistema dell’alta formazione europeo, quando, con la Conferenza di Bologna del 1999, si apre una stagione di ricerca intorno a quella che potrebbe definirsi, semplificando, una koinè accademica: un linguaggio simile (gli ECTS), titoli e competenze comparabili (lo EQF), un unico spazio (l’EHEA). L’obiettivo non è certamente soltanto quello d’un puro idealismo europeista, quanto piuttosto il rendere l’alta formazione europea un sistema solido, comparabile, che garantisca diritti comuni e, soprattutto una “voce”.
È proprio nell’ottica dell’attuazione del Processo di Bologna che la ricerca artistica torna a essere rilevante: nel sistema di comparazione e trasparenza di titoli e competenze, gli istituti che si occupano di formazione artistica devono essere allineati, non “alternativi” o “minori”, rispetto al sistema universitario. Ma perlomeno equipollenti. Il che certamente ha a che fare anche con la ridefinizione dei percorsi formativi in funzione del Quadro delle Qualifiche Europeo (EQF), in cui l’alta formazione prevede tre livelli, che in Italia chiamiamo in modo non sempre coincidente come “laurea triennale”, “laurea magistrale”, “dottorato di ricerca”. O, in ambito AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica): “diploma accademico di I livello”, “diploma accademico di II livello”, “diploma accademico di formazione alla ricerca”.
La completa implementazione del Processo di Bologna è ben lontana dall’essere raggiunta, nonostante l’impegno costante e rilevante di ministeri, istituzioni, comunità accademiche, e non solo in Italia: percorsi simili, con altrettanto simili difficoltà, sono attraversati per esempio dalle gemelle istituzioni olandesi, francesi, tedesche o spagnole [2]. Non sempre, infatti, l’Alta Formazione Artistica prevede il “livello 7” (diploma di II livello-Master Degree-Laurea Magistrale), rarissimamente arriva al “livello 8” (i dottorati di ricerca).
In questo quadro che vede da un lato l’esclusione della ricerca artistica (e progettuale) come categoria rilevante per la R&S e, dall’altro, il tentativo di costruzione di un’unica Area Europea della Formazione Superiore, in cui anche gli Istituti di Formazione Artistica sono tenuti a raggiungere un livello paritario in termini di competenze, e pertanto anche a erogare dottorati di ricerca, le esperienze sono molteplici. Mi pare si possano distinguere due maggiori ambiti di sperimentazione. Da un lato i tentativi istituzionali, dall’altra quelli di ricerca.
Nel primo ambito vanno certamente rilevate le numerose esperienze in ambito nazionale o europeo [3]. La Svezia (e poco più avanti la Norvegia) ha per esempio inserito nella legislazione nazionale già nel 2000 (Zetterfalk 2020), promuovendo anche lo stanziamento di fondi annuali a favore della ricerca artistica e definendo modelli di valutazione e criteri condivisi. Per quanto riguarda invece gli sforzi europei di alcune organizzazioni, sono di fondamentale importanza quelli compiuti dall’European League of Institutes of the Arts (ELIA), fondata nel 1990, dall’Associazione Europea dei Conservatori – AEC (fondata nel 1953), da Cumulus, associazione fondata nel 2001, dall’European Artistic Research Network – EARN (2005) o dalla ancora più recente Society for Artistic Research – SAR (2010), che ha lo specifico scopo di diffondere a livello internazionale le diverse pratiche della ricerca artistica.
Esiti di tali organizzazioni sono documenti e azioni di sostegno all’implementazione del Processo di Bologna, visibili per esempio nell’avvio della rete SHARE (Step-change for Higher Arts Research and Education), che oltre a consentire il dialogo transnazionale tra istituzioni dell’arte ha pubblicato ricerche e volumi come l’Handbook for Artistic Research Education (Ruiten et al. 2013), importanti riviste peer-reviewed come il “Journal for Artistic Research” (Schwab 2011) o la piattaforma PARSE, archivi online come “The Research Catalogue” (Borgdorff, Schwabb 2014).
Ma sono, anche, documenti e position paper come i Florence Principles on the Doctorate of the Arts (ELIA 2016), diretta conseguenza al Manuale di Frascati, o la Vienna Declaration (ELIA 2020). Esperienze che hanno portato, anche a livello istituzionale, all’avvio di diverse esperienze di dottorato nelle arti, molte delle quali formalizzate attraverso il progetto europeo Creator Doctus (2018-2021), che ha costruito un archivio di oltre quaranta esperienze dottorali in altrettante scuole europee (Creator Doctus 2021) [4].
Nel secondo ambito vanno invece osservati i molteplici sforzi nella ricerca, di natura epistemologica, ontologica e di valutazione e misurazione. Alcuni studiosi, in particolare, sono stati senz’altro fondamentali nella costruzione del dibattito, come Henk Borgdorff, la cui instancabile attività ha senz’altro definito alcuni dei correnti principi e riferimenti teorici e metodologici [5], o anche Annette Balkema o Henk Slager (Balkema, Slager 2004; Slager 2015). Va tuttavia riconosciuto un ruolo prioritario al pensiero di tre studiosi, non contemporanei, che hanno decisamente permesso alla riflessione sulla ricerca artistica di muovere passi decisivi, pur se non direttamente: Gibbons, Frayling e Schön.
Il ruolo del primo (Gibbons 1994) è certamente non disciplinare, eppure ritenuto spesso centrale nella definizione della conoscenza che la ricerca artistica può produrre. La considerazione della modalità della conoscenza prodotta “nel contesto” e proposta come sostituzione di una tradizionale modalità “scientifica”, espressa e validata all’interno di circoli chiusi, è cioè una delle chiavi fondamentali impiegata nell’affrontare la specificità interdisciplinare, eterogenea ed estesa della ricerca artistica.
Il ruolo, invece, del lavoro di Christopher Frayling (1993), è senza dubbio quello di aver mosso – per primo [6] – la nozione di “research through art and design”. In questo caso, “Art and Design” sono intese come discipline sovrapposte, non così nettamente distinguibili – perlomeno per quanto riguarda la ricerca. Frayling, riprendendo il modello impiegato da Herbert Read negli anni ’40 per proporne uno pedagogico “through art”, suggerisce che siano tre i modelli di ricerca dell’arte e del design:
(i) Research into art and design; (ii) Research through art and design; (iii) Research for art and design.
Mentre il primo è un navigato modello di ricerca “a proposito dell’arte”, il secondo è quello più propriamente disciplinare della ricerca artistica e progettuale, fondamento della più parte delle attuali dibattute definizioni e pratiche che impiegano l’arte (o il design) stessa come strumento, linguaggio, mezzo della produzione della ricerca. Il terzo modello, invece, è piuttosto una forma di ricerca intrinseca:
Ricerca in cui il prodotto finale è un artefatto – e in cui il pensiero è, per così dire, incorporato – dove l’obiettivo non è principalmente la conoscenza comunicabile nel senso della comunicazione verbale, ma nel senso della comunicazione visiva o iconica o immaginifica. (Frayling 1993, p. 5, trad. dell’autore) [7]
Vale la pena ricordare come proprio il Manuale di Frascati, nel 2015, recuperi le nozioni di “research for the arts, research on the arts and artistic expression” e dedichi in modo paritetico una sezione all’esclusione della ricerca progettuale tanto quanto di quella artistica, per ragioni tra loro simili, come sopra descritto.
Il ruolo del lavoro di Donald Schön (1984), invece, è sorprendentemente attuale e presente, tanto nella letteratura intorno al ruolo della ricerca artistica (si veda, ancora, Borgdorff 2012) quanto in quella che concerne la ricerca progettuale [8]:
Gli artisti di oggi sono quelli che Donald Schön ha definito “professionisti riflessivi”. L’attuale dinamica del mondo dell’arte richiede che gli artisti siano in grado di contestualizzare il loro lavoro e di posizionarsi rispetto agli altri nel mondo dell’arte, rispetto alle tendenze e agli sviluppi attuali della pratica artistica, rispetto ai finanziatori e al pubblico in generale. Questa prospettiva esterna completa la visione dall’interno. Una concezione ingenua dell’arte, delle opere, della produzione e della ricezione dell’arte, appartiene al passato. Ci siamo lasciati alle spalle qualsiasi concezione precritica dell’arte, come quella che persisteva persino all’interno del modernismo. L’arte (e non solo l’arte concettuale) è altamente riflessiva, sebbene nella sua produzione e ricezione siano presenti anche aspetti preriflessivi (taciti). Questa riflessività dell’arte, insieme alla posizione riflessiva dell’artista, è uno dei motivi più importanti per la ricerca in campo artistico. (Borgdorff 2012, p. 117, trad. dell’autore) [9]
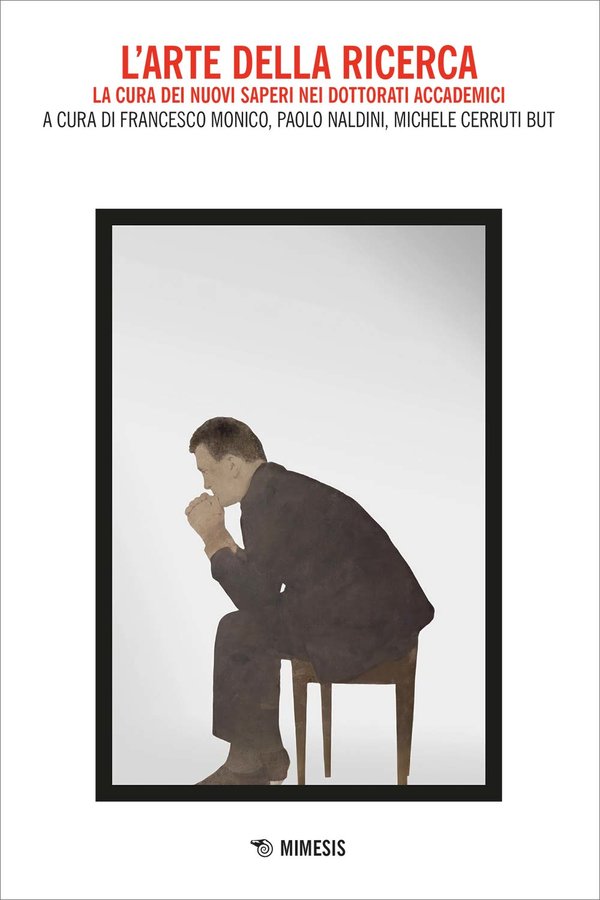
1. In italiano: “Per affrontare la discussione su R&S e creazione artistica può essere utile fare una distinzione tra ricerca per le arti, ricerca sulle arti ed espressione artistica”.
2. Interessante in questo senso l’esperienza dell’Inghilterra e del Planetary Collegium di cui si parla anche in questo volume, tra le prime in Europa per le ricerche dottorali in campo artistico, tentando un approccio comprensivista e multidisciplinare.
3. Un ottimo lavoro di sintesi si può ritrovare nel recente saggio di Mattia Quinteri (Quinteri 2023), che oltre a esplorare la specificità del caso italiano descrive minuziosamente l’avvicendarsi di queste esperienze di implementazione della ricerca artistica nell’EHEA.
4. Esperienza a cui purtroppo non ha partecipato nessuna istituzione italiana. Si veda il sito 3rdcycleinthearts.eu.
5. Centrale è, ad esempio, il volume che raccoglie molti dei suoi saggi fondamentali (Borgdorff 2012), o il volume curato nel 2019 (Borgdorff et al. 2019), che ha l’obiettivo di raccogliere i dialoghi tra la ricerca degli studi scientifici e tecnologici sulle arti e il campo emergente della ricerca artistica: “questo volume traccia un dialogo tra la ricerca degli studi scientifici e tecnologici sulle arti e il campo emergente della ricerca artistica. I temi principali del libro sono la comprensione avanzata della discorsività e del ragionamento nella ricerca artistica, la rilevanza metodologica delle pratiche e degli oggetti materiali e i modi innovativi di collegare, mettere in scena e pubblicare la ricerca in ambito artistico e accademico. Il libro tocca argomenti quali gli studi sulle pratiche artistiche, i reflective practitioners ai confini tra arte, scienza e tecnologia, le forme non propositive di ragionamento, i metodi di ricerca non convenzionali (basati sulle arti) e le modalità avanzate di presentazione e pubblicazione” (ibidem).
6. A dire il vero pare che il fondamentale articolo di Fraylin sia piuttosto stato l’esito di un lungo e frastagliato dibattito internazionale iniziato perlomeno nel 1948 con il famosissimo volume Education Through Art di Herbert Read (Read 1948), e un ampio sovrapporsi di ipotesi intorno ai modi della conoscenza attraverso il design (cfr. Galdon, Hall 2022; Guerra 2021).
7. Il testo prosegue in questo modo: “Ho menzionato la tradizione cognitiva nelle belle arti, e mi sembra una tradizione da cui potrebbero svilupparsi molte ricerche future: una tradizione che sta fuori dall’artefatto e allo stesso tempo sta al suo interno. Per quanto riguarda la tradizione espressiva, una domanda interessante è perché la gente voglia chiamarla ricerca con la “r” maiuscola. Qual è la motivazione? Vero, la ricerca è diventata oggi una questione politica o di risorse, oltre che accademica. […] La ricerca è diventata una questione di status, oltre che concettuale o addirittura pratica. E questo – lo confesso – mi preoccupa. Potrebbero esserci delle opportunità di ricerca all’interno della tradizione espressiva, ma necessitano di una ricerca spassionata piuttosto che di accese discussioni sullo status, sulla classe e sullo snobismo di ritorno” (Frayling 1993, p. 5).
8. Un lavoro eccellente in tal senso è fatto da Paola Viganò in I territori dell’urbanistica. Il progetto come produttore di conoscenza (2010), ma anche da Verbeke (2013) e da Candy (2019).
9. L’autore ricorda, tuttavia, che “la riflessività dell’arte – la sua qualità di interrogarsi e di dare spunti di riflessione, e quindi di mostrare anche una dimensione ‘concettuale’ – non va intesa in opposizione al contenuto (in senso filosofico) non concettuale e preriflessivo o non riflessivo che vi è racchiuso” (ibidem).