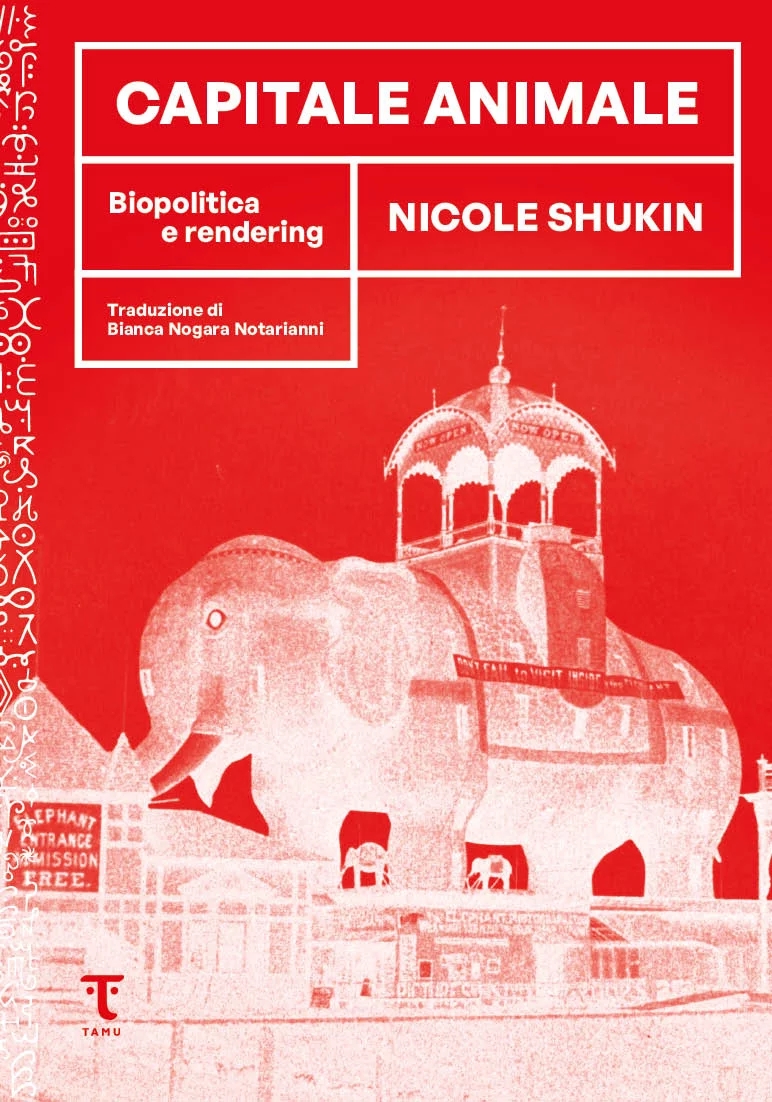Capitale animale – il testo da cui è tratto il presente brano – esplora un ricco campionario di fatti culturali e materiali riguardanti il rapporto degli esseri umani con le altre specie. Il capitale animale ha due facce: quella del mattatoio e quella della pubblicità – dove un animale esotico ci sorride in una rassicurante versione digitale.
L’autrice Nicole Shukin – professoressa associata presso il dipartimento di Inglese all’Università di Victoria, in Canada – espone contraddizioni profonde muovendosi tra studi culturali, storia dei media e critical animal studies.
Il libro Capitale animale è edito in Italia da Tamu edizioni nella traduzione di Bianca Nogara Notarianni e a cura di Massimo Filippi e Federica Timeto. Ringraziamo l’editore per la possibilità concessa.
La giustapposizione di due termini raramente teorizzati nella loro congiunzione – «animale» e « capitale» – segnala un intervento a doppio taglio su due argomenti la cui attrattiva rischiosamente universale colloca questo studio, di necessità, entro il più ampio campo degli studi culturali transnazionali. Da un lato, Capitale animale adotta un orientamento risolutamente materialistico alla «questione dell’animale» (nelle parole di Cary Wolfe): interroga l’approccio prevalentemente idealistico con cui questa viene trattata, nella teoria critica come negli animal studies, attraverso la teorizzazione delle modalità in cui la vita animale viene rappresentata (rendered) – culturalmente e materialmente – come capitale, entro specifiche congiunzioni storiche.[1]
Dall’altro, elaborando una serie di genealogie non ortodosse del capitale animale tra l’epoca fordista e postfordista, il libro prova a sanare il punto cieco critico della teoria marxista e post-marxista sul ruolo fondante, a livello ideologico e materiale, degli animali nella riproduzione dell’egemonia del capitale. Mentre lə teoricə del biopotere si sono interrogatə sulla sussunzione totale della vita sociale e biologica dell’anthropos entro le logiche di mercato, è stata prestata ben poca attenzione a quel che definisco capitale animale. L’intervento a doppio taglio di questo libro sottolinea quindi la necessità critica, nell’ambito degli studi culturali, di un’esplorazione del modo in cui le questioni dell’animale e del capitale si influenzano reciprocamente, lungo storie antiche e cruente di congiunzioni e congiunture.
Contro l’invocazione mitopoietica dei simboli animali come lingua franca universale che trascende spazio e tempo, provo a storicizzare le specifiche logiche culturali e le disposizioni materiali che hanno prodotto gli animali come « forme di capitale» (nelle parole di Pierre Bourdieu) durante il 20° e l’inizio del 21° secolo. L’espressione «capitale animale» evidenzia contemporaneamente la valuta semiotica dei simboli animali e il traffico materiale di sostanze animali in questo arco di tempo. Ancora più precisamente, segnala un intreccio di relazioni biopolitiche all’interno del quale il capitale economico e quello simbolico della vita animale non possono più essere considerati separatamente. In questo libro, infatti, sostengo che memi animali e materia animale si sovradeterminino vicendevolmente come forme di capitale; l’obiettivo è delineare quella che Bourdieu definisce l’«interconvertibilità» delle forme simboliche ed economiche del capitale attraverso la valuta feticistica della vita animale.[2]
Un’indagine congiunta sugli intrecci storici tra «animale» e «capitale» non solo è da tempo necessaria entro il variegato campo degli studi culturali transnazionali, ma è con tutta probabilità fondamentale per un’analisi critica del biopotere, o di quel che Michel Foucault descrive come una «una tecnologia di potere centrata sulla vita».[3] La posta in gioco del biopotere è nientemeno che la contesa ontologica su ciò che Michael Hardt e Antonio Negri definiscono « produzione e riproduzione dell’essere».[4] Foucault è stato il primo a sottolineare come il simbolo dell’animale sia emerso sulla «soglia della modernità biologica», segnando il passaggio all’«ontologia indomita» o alla «vita stessa» come nuovo oggetto di potere.[5]
Il fascino esercitato, nella pubblicità di «Maclean’s», dagli organi interni del castoro – piuttosto che dalle estremità corporee come denti, pelliccia, coda e zampe – sembrerebbe inscenare l’affermazione di Foucault secondo cui, quando la vita diventa il «punto di fuga sovrano» in relazione al quale si orienta il potere, sono le «ossature occulte» dell’animale, i suoi «organi mascherati» e le sue «molteplici funzioni invisibili», a emergere come sua cifra biologica.[6]
Il ruolo del biopotere nella globalizzazione del mercato ha sollecitato l’emergere di un corpus teorico teso a illuminarne mezzi ed effetti. Molte recenti teorie sul biopotere si sono allontanate dal focus foucaultiano – discorsi e tecnologie di stato – per analizzare invece le reti e le tecnologie del capitalismo globale. Hardt e Negri si rifanno a Foucault per teorizzare «la natura biopolitica del nuovo paradigma del potere» nel contesto di un impero transnazionale del capitale che, sostengono, ha soppiantato la sovranità dello stato-nazione. L’impero, proseguono, opera come una «società del controllo», una rete di potere diffusa in cui «i meccanismi di comando diventano sempre più ‘democratici’, sempre più immanenti al sociale, e vengono distribuiti attraverso i cervelli e i corpi degli individui».[7]
[…] Questo libro inaugura una diversa traiettoria della critica biopolitica – o, potremmo dire, zoopolitica –, una traiettoria che parte esattamente dal rifiuto dell’assunto secondo cui la carne sociale e il « corpo-specie», la posta in gioco del biopotere, siano prevalentemente umani.[8] Animali in carne e ossa vengono sottilmente dislocati già dalla categoria di «specie» nelle prime osservazioni di Foucault sul biopotere, così come nel lavoro di intellettuali successivə, per lə quali l’animalità opera prevalentemente come metafora per quella parte corporea dell’«umano» che diventa oggetto del calcolo biopolitico. Nell’influente teorizzazione della «nuda vita» di Agamben, per esempio, la relazione degli animali con il biopotere capitalista è occultata dalla declinazione specie-specifica di zoé nella figura avulsa dal sociale di homo sacer fatta risalire all’antichità.[9]
In ogni caso, la teorizzazione della nuda vita come «uccidibile e insacrificabile»[10] – uno stato di eccezione il cui scenario paradigmatico nella modernità è, per Agamben, il campo di concentramento – trova la sua controparte zoopolitica nella teorizzazione di Derrida della «messa a morte non criminale» degli animali, uno stato di eccezione affine il cui scenario paradigmatico è probabilmente il moderno macello industriale.[11] Il potere di ridurre gli esseri umani alla nuda vita del corpo-specie presuppone, crediamo, la sospensione delle altre specie in uno stato di eccezione in cui possano essere messe a morte in modo non criminale. Come scrive Cary Wolfe, «finché si dà istituzionalmente per scontato che sia giusto sfruttare e uccidere sistematicamente gli animali non umani semplicemente a causa della loro specie, il discorso umanista delle specie sarà sempre passibile di essere impiegato da alcuni esseri umani a scapito di altri esseri umani, per giustificare la violenza contro l’altro sociale di qualsiasi specie – o genere, razza, classe e differenza sessuale».[12]
Le fotografie trofeo che ritraggono le forze armate statunitensi mentre terrorizzano lə prigionierə irachenə nel carcere di Abu Ghraib nel 2004 mostrano, tra le altre cose, un uomo iracheno nudo a quattro zampe e con un «guinzaglio» al collo, nonché prigionieri che si accucciano davanti a pastori tedeschi. Il cane viene fatto crudelmente operare come protesi razzista del potere militare statunitense di animalizzare «l’altro», un potere che si applica in prima istanza all’animale stesso.[13]
La produzione biopolitica della nuda vita dell’alterità animale sottende perciò la produzione biopolitica della nuda vita dell’alterità razzializzata. Tornando alla riflessione di Foucault sul biopotere, diventa palese come dentro il « continuum biologico cui il biopotere si rivolge» ci sia una linea tracciata all’interno del vivente ancora precedente a quella inscritta dal razzismo: una linea di specie celata, e allo stesso tempo inavvertitamente rivelata, dal ricorso di Foucault al termine «sottospecie» per descrivere gli effetti della razzializzazione:
Ma che cosa è propriamente il razzismo? Il razzismo, in primo luogo, rappresenta il modo in cui, nell’ambito di quella vita che il potere ha preso in gestione, è stato infine possibile introdurre una separazione, quella tra ciò che deve vivere e ciò che deve morire. All’interno del continuum biologico della specie umana, l’apparizione delle razze, la distinzione delle razze, la gerarchia delle razze, la qualificazione di alcune razze come buone e di altre, al contrario, come inferiori, costituirà un modo per frammentare il campo del biologico che il potere ha preso a carico, diventerà una maniera per introdurre uno squilibrio tra i gruppi, gli uni rispetto agli altri, all’interno di una popolazione (…). E tutto questo permetterà al potere (…) di trattare e suddividere le specie di cui si è fatto carico nei sottogruppi che, a rigore, costituiranno le razze.[14]
L’intuizione cruciale di Foucault – ossia che il biopotere inauguri « niente di meno che l’ingresso della vita nella storia, cioè l’ingresso dei fenomeni propri della vita della specie umana nell’ordine del sapere e del potere»[15] – si scontra con il suo proprio limite, interno alla linea della specie. Le analisi biopolitiche ispirate da Foucault sono a loro volta limitate dalla riluttanza a perseguire gli effetti del potere al di là della produzione della vita sociale e/o della specie umana, nella zoopolitica del capitale animale.[16]
Cuore argomentativo di questo libro è che i discorsi e le tecnologie del biopotere si fondano sulla divisione di specie, sulla produzione zoo-ontologica della differenza di specie come linea strategicamente ambivalente più che assoluta, che ha il potere contraddittorio di dissolvere e di reinscrivere i confini tra umani e animali. L’espressione capitale animale indica, tra le altre cose, il paradosso di un capitalismo antropocentrico i cui mezzi ed effetti possono essere fin troppo postumani, vale a dire di un capitalismo che crede ideologicamente e investe materialmente in un mondo in cui i confini delle specie possano essere radicalmente superati (oltre che reinscritti) nella ricerca genetica ed estetica di nuovi mercati.
La «questione animale» richiede aə teoricə del biopotere e del capitale che si confrontino non solamente con le funzioni ideologiche e affettive dei simboli animali, ma anche con le
istituzioni e le tecnologie materiali dello specismo. Le dimensioni materiali della questione sono sollevate ancora da Derrida, che scrive in termini inequivocabilmente foucaultiani:
Nel corso degli ultimi due secoli, queste forme tradizionali del trattamento dell’animale sono state rivoluzionate – ed è fin troppo evidente – dai concomitanti sviluppi delle scienze zoologiche, etologiche, biologiche e genetiche e dalla parallela evoluzione delle varie tecniche di intervento nel proprio oggetto, di trasformazione del loro stesso oggetto e del contesto, del mondo del loro oggetto, l’animale vivente: con l’allevamento e l’addestramento dell’animale su una scala demografica che non ha eguali nel passato, con la sperimentazione genetica, con l’industrializzazione di ciò che si può chiamare la produzione alimentare della carne animale, con la diffusione massiccia dell’inseminazione artificiale, con manipolazioni sempre più audaci del genoma, con la riduzione dell’animale, non solo alla produzione e alla riproduzione sovradimensionata di carne alimentare (ormoni, incroci genetici, clonazione, ecc.), ma anche a tutte le altre finalizzazioni intese al servizio di un certo essere o di un supposto benessere umano dell’uomo.[17]
Le parole di Derrida ammoniscono che non è sufficiente teorizzare il biopotere solo in relazione alla vita umana; anche le vite e il lavoro riproduttivo di altre specie (lavoro sessualmente differenziato, non dimentichiamolo) sono materia di calcolo biopolitico. Tuttavia, il valore riproduttivo degli animali non è solo biologico, come potrebbe far credere, in prima battuta, il precedente passaggio; le figure e le metafore animali sono risorse simboliche fondamentali per la riproduzione del capitale. Data la vertiginosa crescita della speculazione sui simboli animali come valuta semiotica del mercato culturale, crescita che avviene nello stesso istante in cui gli animali vengono irregimentati in condizioni agghiaccianti a fini riproduttivi come fabbriche di proteine e geni, un’indagine del capitale animale in questa doppia accezione – contemporaneamente simbolo e sostanza del mercato – emerge come un compito urgente degli studi culturali.
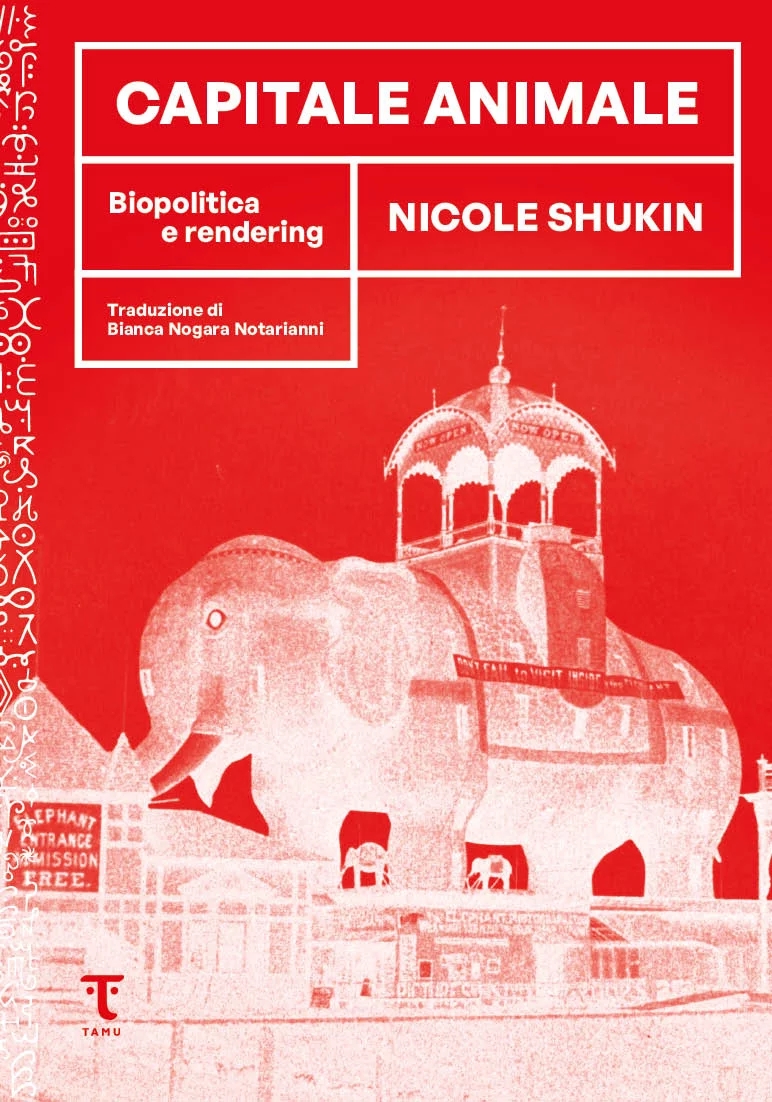
1 Wolfe, 2003
2 Bourdieu, 1993, p. 173
3 Foucault, 2019, p. 128
4 Hardt e Negri, 2007, p. 337
5 Foucault, 2019, p. 127. Foucault delinea chiaramente la nozione di biopotere nell’ultimo capitolo del volume, Diritto di morte e potere sulla vita. Come scrive l’autore, «si apre l’era di un ‘bio-potere’»: dal potere sovrano di amministrare la morte, con la modernità si giunge a «un potere che si esercita positivamente sulla vita, che incomincia a gestirla, a potenziarla, a moltiplicarla, a esercitare su di essa controlli precisi e regolazioni d’insieme» (Foucault, 2019, p. 121)
6 Foucault, 1967, p. 300
7 Hardt e Negri, 2007, p. 39
8 Foucault, 2019, p. 123
9 Agamben, 2005
10 Agamben, 2005, p. 23
11 Derrida, 2011, p. 36
12 Wolfe, 2003, p. 8
13 Sia perché la forza dell’animalizzazione presuppone l’abiezione degli animali sia perché la lotta per l’«umanità» è un obiettivo di per sé innervato dall’eurocentrismo umanista, lə geografə culturali Glen Elder, Jennifer Wolch e Jody Emel invitano a «rifiutare la ‘disumanizzazione’ come fondamento della critica culturale». Lə autorə sostengono che «le varie connotazioni del termine ‘disumanizzazione’ sono intrinsecamente insidiose. Implicano la superiorità umana e, quindi, sanciscono la padronanza sugli animali e sulla natura e al contempo suggeriscono che un trattamento violento o comunque dannoso sia accettabile, fintanto che i bersagli sono esseri non umani» (Elder, Wolch e Emel, 1998, p. 88)
14 Foucault, 2010, p. 220
15 Foucault, 2019, p. 125
16 In Agamben, 2002, l’autore si confronta con il tema della zoopolitica – ossia della produzione della distinzione uomo-animale a opera della «macchina antropologica» nella cultura occidentale –, ma il libro finisce per configurarsi come una storia culturale della rappresentazione degli animali nei discorsi dell’Occidente, con scarso riferimento alla storia materiale e alla macchina del capitalismo – che, come sostengo, sovradetermina la valuta culturale e materiale «dell’animale» nella modernità occidentale e nella postmodernità
17 Derrida, 2018, pp. 62-63