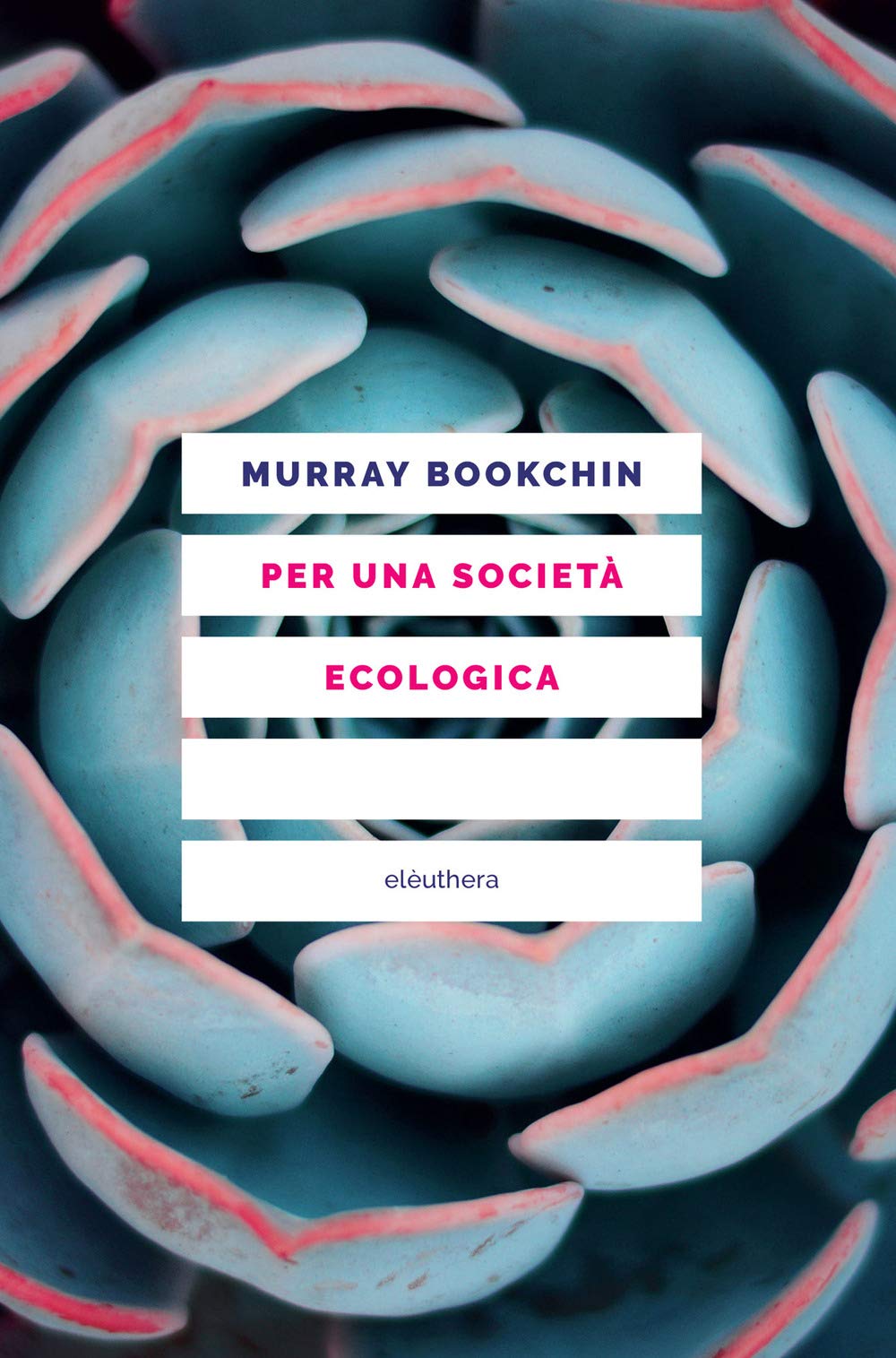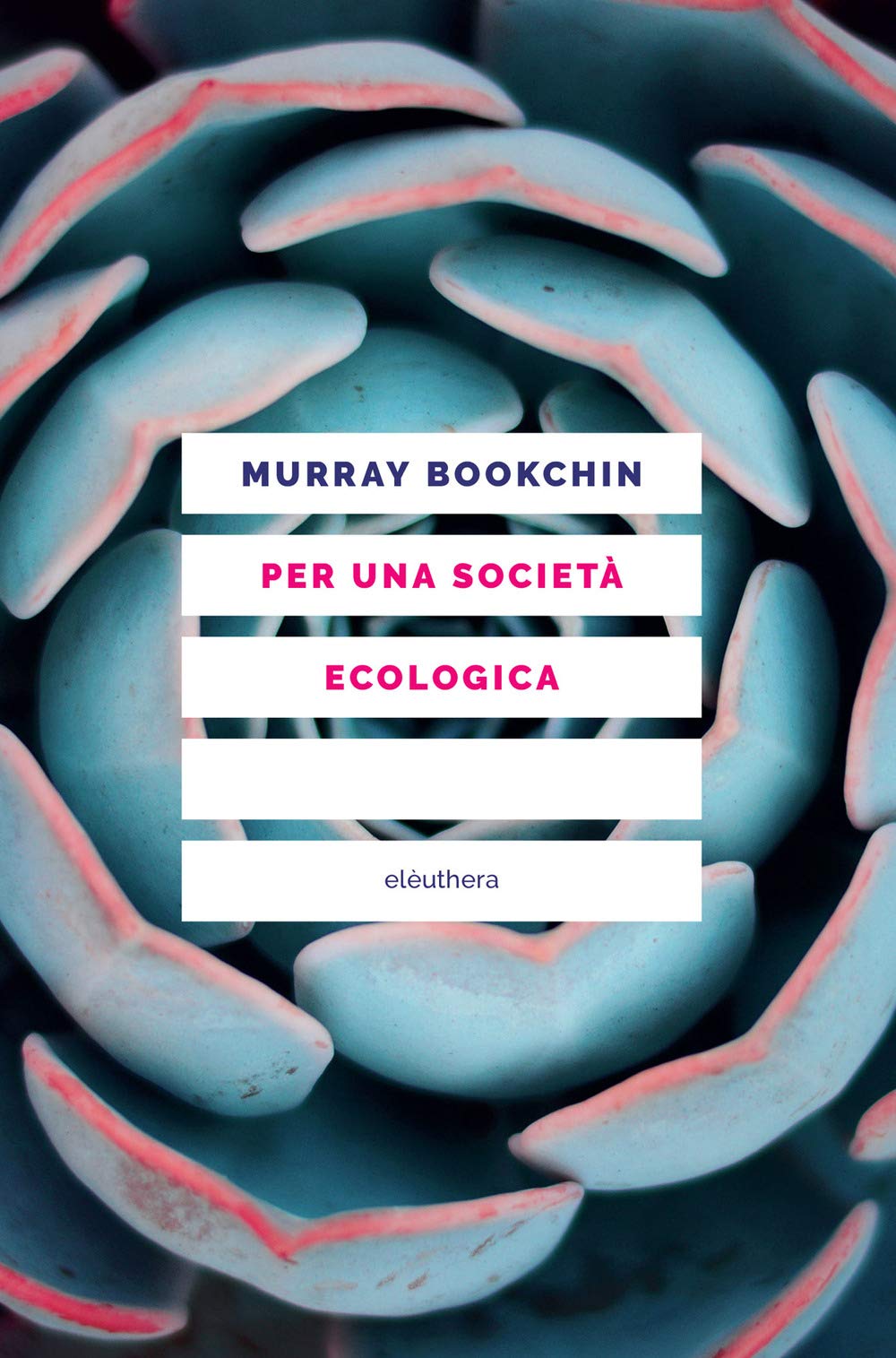Pubblichiamo un estratto dal libro Per una società ecologica, di Murray Bookchin, ri-edito recentemente dalla casa editrice Eleuthera che ringraziamo per la possibilità concessa.
Molti hanno oggi il problema di «definire» se stessi, di sapere «chi sono», e di ciò si nutre una vasta industria psicoterapeutica. Ma questo non è soltanto un problema individuale, è anche un problema sociale, della società nel suo complesso. Socialmente, viviamo nella disperata incertezza delle relazioni che debbono intercorrere tra le persone. L’alienazione e la confusione circa la nostra identità e il nostro destino non ci concernono solo in quanto individui: tutta la nostra società, intesa come un unico essere, stenta a riconoscere la propria natura e il proprio orientamento. Le società di un tempo tendevano a promuovere la fiducia nelle virtù della cooperazione e dell’accudimento, dando così un senso etico alla vita associata; la società moderna promuove invece la fiducia nelle virtù della competizione e dell’egotismo, e così facendo priva il consesso umano di qualsiasi senso (se non, forse, quello di essere uno strumento di accumulazione e consumo insensati).
Gli uomini e le donne del passato erano guidati da convinzioni e speranze certe, da valori che li definivano in quanto esseri umani e davano così significato alla vita associata. Usiamo parlare del Medio Evo come di un’epoca «di fede» e dell’Illuminismo come di un’epoca «di ragione». Anche il periodo precedente alla seconda guerra mondiale e gli anni immediatamente successivi ci appaiono come un’affascinante epoca di innocenza e speranza, nonostante la Grande Depressione e i terribili conflitti che l’hanno segnata. In un recente (e piuttosto sofisticato) film di spionaggio c’è un vecchio che dice di sentire la mancanza della «chiarezza» propria della seconda guerra mondiale, alludendo evidentemente alla presenza di uno scopo, di un’idea che guidava i comportamenti. Oggi, questa «chiarezza» non c’è più. Il suo posto è stato preso dall’ambiguità. La certezza che la tecnologia e la scienza avrebbero migliorato la condizione umana è stata vanificata dalla proliferazione degli armamenti nucleari, dalla fame diffusa in tutto il Terzo Mondo, e dalla povertà ancora presente nel mondo industrialmente avanzato. La fiducia che la libertà avrebbe trionfato sulla tirannia è stata smentita dalla crescente centralizzazione degli Stati e dall’esautoramento del popolo a opera delle burocrazie, delle forze di polizia, di sofisticate tecniche di controllo, e ciò nelle nostre «democrazie» non meno che nei paesi apertamente autoritari. La speranza di costruire «un unico mondo», una vasta comunità di gruppi etnici diversi che collaborano per migliorare la vita in ogni luogo, è stata distrutta dal montare di una marea di nazionalismo, razzismo, miope individualismo e indifferenza per le disgrazie che affliggono milioni di altri.
I nostri valori ci appaiono meno validi di quelli condivisi dalle generazioni precedenti fino a poco tempo fa. La generazione attuale sembra essere più egocentrica, chiusa nel privato e mediocre rispetto alle generazioni del passato. Manca il supporto offerto dalla famiglia estesa, dalla comunità, dal mutuo appoggio. A quanto pare, l’incontro dell’individuo con la società avviene più attraverso fredde agenzie burocratiche che non attraverso persone attente e sensibili.
Questa mancanza di identità e di senso sociale è l’aspetto saliente dei problemi che ci stanno di fronte. La guerra è una condizione cronica della nostra epoca. L’incertezza economica è una presenza costante. La solidarietà umana è invece un mito sfuggente.
E, non ultimo dei nostri problemi, ci sta davanti l’apocalisse ecologica, la distruzione catastrofica del sistema che garantisce la stabilità del pianeta. Viviamo sotto la minaccia costante che il mondo vivente possa irrevocabilmente essere compromesso da una società votata a uno sviluppo folle, una società che sostituisce sempre più l’organico con l’inorganico, il suolo con il cemento, le foreste con il deserto, la ricca diversità delle forme di vita con ecosistemi semplificati, in breve una società che sta «mettendo indietro» l’orologio dell’evoluzione, riportandola a un passato più inorganico, minerale, incapace di offrire sostentamento a forme di vita complesse, esseri umani inclusi.
Questa ambiguità del nostro destino, del nostro significato, del nostro scopo, genera così una domanda angosciante: è forse una maledizione, la società, un cancro che aggredisce tutte le forme di vita? Non c’è rimedio a questo nuovo fenomeno chiamato «civiltà» che pare sul punto di distruggere il mondo naturale prodotto in milioni di anni di evoluzione organica?
In effetti, esiste oggi tutta una letteratura, che attira l’attenzione di milioni di lettori, centrata su questo pessimismo nei confronti della civiltà in sé e per sé. Tale letteratura presenta la tecnologia come contrapposta a una presunta natura organica «vergine», la città come contrapposta alla campagna e la campagna come contrapposta alla natura «selvaggia», la scienza come contrapposta al «rispetto» per la vita, la ragione come contrapposta all’«innocenza» dell’intuizione, insomma l’umanità come contrapposta a tutta la biosfera.
Stiamo cioè perdendo la fiducia nelle nostre caratteristiche tipicamente umane, nella nostra attitudine al pensiero concettuale e sistematico, nella nostra capacità di vivere in pace con gli altri, di prenderci cura dei nostri simili e delle altre forme di vita. Questo pessimismo è alimentato, un giorno dopo l’altro, da sociologi che attribuiscono i nostri difetti ai cromosomi, da antiumanisti che deplorano la nostra sensibilità «antinaturale» e da biocentristi che disprezzano le nostre qualità razionali pretendendoci non diversi nella nostra unicità dalle formiche. In breve, assistiamo a un attacco diffuso contro la ragione, la scienza, la tecnologia, contro la loro capacità di migliorare il mondo, per noi stessi e per la vita in generale. Storicamente, questa concezione che vede la civiltà come inevitabilmente contrapposta alla natura, come una corruzione della natura umana, risale ai tempi di Jean-Jacques Rousseau e ci viene riproposta oggi, quando è più che mai necessaria una civiltà umana ed ecologica se vogliamo davvero salvare il pianeta e noi stessi. La civiltà, con il suo maschilismo razionalista e tecnicista, è vista sempre più come una nuova peste.
Anzi, è la società in se stessa a essere messa in discussione, al punto di considerare come pericolosamente «innaturale» e intrinsecamente distruttivo il ruolo che essa svolge nella formazione dell’umanità. L’umanità viene diffamata dagli stessi esseri umani, ed è paradossalmente accusata di essere una forma di vita perversa che non fa che distruggere le altre forme di vita, minacciando l’integrità costituita dal loro insieme. Cosicché, oltre alla confusione per l’incertezza della nostra epoca e della nostra identità, ci troviamo ad affrontare anche la confusione circa la condizione umana, vista come un elemento di caos frutto delle nostre tendenze assassine e della nostra abilità a esercitarle con terribile efficienza, essendo dotati di ragione, scienza e tecnologia.
Bisogna riconoscere che solo un manipolo degli antiumanisti, dei biocentristi e dei misantropi che si dedicano a indagare sulla condizione umana è poi disposto a seguire la logica delle loro premesse fino a certe assurdità. Quello che va rilevato in questo guazzabuglio di intuizioni e di idee più definite è che le varie forme, istituzioni, relazioni che costituiscono ciò che chiamiamo «società» vengono in larga misura ignorate. Infatti si preferisce ricorrere a termini come «umanità» e a vocaboli zoologici come Homo sapiens, che celano le grandi differenze, e spesso gli aspri conflitti, che esistono tra i bianchi privilegiati e la gente di colore, tra gli oppressori e gli oppressi. E lo stesso vale per parole vaghe come «società» o «civiltà», che celano l’esistenza di grandi differenze tra le società libere, non gerarchiche, senza classi e senza Stato, e quelle più o meno gerarchizzate, classiste, statuali e autoritarie. Qui la zoologia rimpiazza un’ecologia a orientamento sociale e le cosiddette «leggi naturali», basate sulle oscillazioni nella popolazione animale, rimpiazzano i conflitti di interesse economici e sociali.
La semplicistica contrapposizione tra «società» e «natura», tra «umanità» e «biosfera», tra «ragione», «tecnologia», «scienza» e le forme di relazione umana con il mondo naturale meno sviluppate o addirittura primitive, ci impedisce di prendere in considerazione le complesse differenze e divisioni che sono presenti in seno alla società, il che è invece indispensabile per definire i nostri problemi e la loro soluzione.
L’antico Egitto, ad esempio, aveva verso la natura un atteggiamento significativamente diverso da quello babilonese. Gli Egizi nutrivano una forte «reverenza» nei confronti di un gruppo di divinità della natura essenzialmente animistiche, molte delle quali erano anche fisicamente in parte umane e in parte animali. I Babilonesi, invece, avevano un pantheon di dèi di tipo politico, e dunque molto più umanizzati. Eppure l’Egitto non è stato meno gerarchico di Babilonia nel configurare la sua popolazione e forse era ancora più oppressivo di quest’ultima nei confronti degli individui in quanto tali. Certe società di cacciatori, a dispetto delle loro profonde concezioni animistiche, hanno distrutto la flora e la fauna naturali tanto quanto le culture urbane che fanno esclusivo riferimento alla ragione. Il termine «società» non fa dunque che inghiottire tutte queste differenze, insieme alla gran varietà di modelli sociali, e questo equivale a far violenza al pensiero e anche all’intelligenza pura e semplice.
Accade così che la società in sé diventi qualcosa di «innaturale». La ragione, la tecnologia, la scienza diventano elementi «distruttivi», senza che vengano tenuti in alcun conto i fattori sociali che ne condizionano l’uso. Qualunque tentativo di modificare l’ambiente è visto come una minaccia, come se la nostra «specie» potesse fare ben poco, o niente del tutto, per migliorare la vita del pianeta in senso generale.
Non siamo meno animali degli altri mammiferi, è vero, eppure siamo qualcosa di più che mandrie di erbivori brucanti sulle praterie africane, ed è questo qualcosa di più (vale a dire, il tipo di società che costituiamo e il modo in cui ci dividiamo in gerarchie e classi) che condiziona profondamente il nostro comportamento e i suoi effetti sul mondo naturale.
Infine, separando così radicalmente l’umanità e la società umana dalla natura e riducendole a mere entità zoologiche, non riusciamo più ad accorgerci di come la natura umana derivi dalla natura non umana e l’evoluzione sociale dall’evoluzione naturale. In questa «epoca di alienazione», non solo l’umanità si aliena, si separa da se stessa, ma si separa anche dal mondo naturale, del quale un tempo faceva parte in quanto forma di vita complessa e pensante.
In sintonia con simili concezioni, gli ambientalisti progressisti e misantropi ci ammanniscono una dieta costante di rimbrotti circa il modo in cui «noi», in quanto specie, siamo responsabili del degrado ambientale. Non c’è bisogno di andare in California per imbattersi in un’accozzaglia di mistici e guru che hanno del problema ecologico e dei suoi fondamenti questa visione asociale e centrata sulla specie. New York, ad esempio, va altrettanto bene. Non dimenticherò tanto facilmente la mostra «ambientalista» organizzata negli anni Settanta dall’American Museum of Natural History di quella città, con una lunga serie di scenografie che mostravano al pubblico esempi di inquinamento e distruzione ecologica. L’ultima di esse, quella che concludeva la mostra, aveva l’incredibile titolo L’animale più pericoloso della terra, e consisteva in un grande specchio che rifletteva l’immagine del visitatore che si fosse trovato a sostare di fronte a esso. Ho ancora in mente l’immagine di un bambinetto nero che guardava lo specchio, mentre il suo maestro bianco cercava di spiegargli il messaggio che l’arrogante scenografia tentava di comunicare.
Non c’erano invece scenografie che rappresentassero i vertici manageriali delle grandi industrie nel momento in cui decidono di disboscare montagne intere, né i funzionari governativi che agiscono in collusione con i primi. Il messaggio della rappresentazione era uno solo, fondamentalmente antiumano: sono gli individui in quanto tali, non la società rapace e coloro che ne beneficiano, a essere responsabili degli squilibri ecologici, i ceti poveri non meno di quelli ricchi, la gente di colore non meno dei bianchi privilegiati, le donne non meno degli uomini, gli oppressi non meno degli oppressori.
Una «specie umana» astratta rimpiazza così le classi, gli individui rimpiazzano le gerarchie, i gusti personali (molti dei quali modellati dai media) rimpiazzano i rapporti sociali, e i diseredati che vivono stentate e isolate esistenze rimpiazzano le multinazionali aggressive, le burocrazie conniventi e le reazioni violente dello Stato.