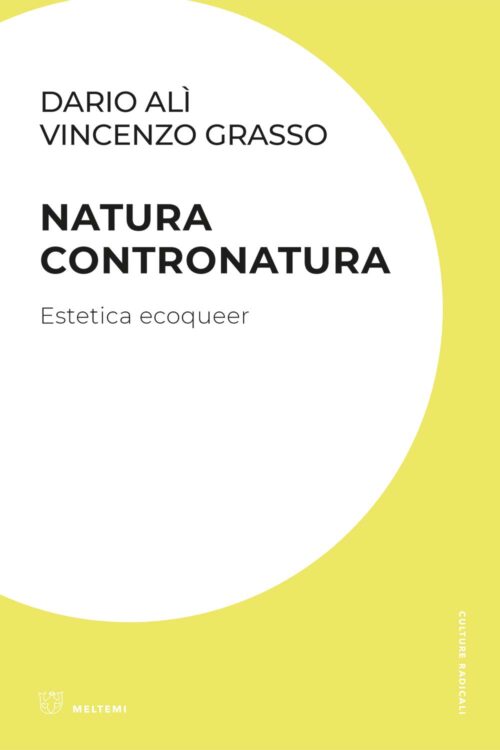Nella tradizione occidentale, la natura è spesso ritratta in modo ambivalente: da un lato come entità pura, armoniosa e benevola; dall’altro come forza selvaggia, caotica e minacciosa. Queste rappresentazioni riflettono una tensione profonda tra il desiderio umano di dominare l’ambiente e il riconoscimento di ciò che sfugge a ogni forma di controllo.
Questa ambivalenza ha storicamente reso la natura un dispositivo ideologico potente, utilizzato per stabilire confini tra ciò che viene considerato “normale” e ciò che, al contrario, è escluso, stigmatizzato, rimosso: il “contro natura”. Figure come mostri, prodigi e corpi indisciplinati abitano i margini di una visione della natura intesa come sana, binaria e ordinata.
Ma proprio dove affiora il contronatura si apre uno spazio di resistenza. In esso si dischiude una prospettiva privilegiata sulla complessità del vivente, sia nel mondo animale che in quello vegetale.
Natura contronatura. Estetica ecoqueer di Dario Alì e Vincenzo Grasso, edito da Meltemi, intreccia studi di genere, ecocritica e filosofia politica per mostrare come la retorica della “naturalità” sia stata storicamente impiegata per marginalizzare corpi, desideri e identità considerate “contro natura”. Il testo non si limita alla critica: propone una visione alternativa, in cui la marginalità diventa spazio creativo. Ringraziamo l’editore per averci concesso il permesso per la pubblicazione del presente estratto.
È il 1982, ci troviamo a Manhattan. Una donna in jeans e camicia passeggia in un campo di grano reggendo in mano un bastone. Dietro di lei, a fare da sfondo un’architettura di vetro e cemento. È Agnes Denes, artista nata a Budapest nel 1931 e trasferitasi a New York all’età di ventitré anni. Le immagini che immortalano questo momento testimoniano uno dei più affascinanti interventi artistici ambientali del XX secolo: Wheatfield – A Confrontation. L’opera, realizzata con il supporto del Public Art Fund, consiste nella piantumazione e coltivazione di un ettaro di grano, proveniente dal North Dakota, su un terreno desolato di Battery Park, un’ex discarica situata a pochi passi dal cuore finanziario di New York e dal World Trade Center [1].
L’atto di piantare il grano in questo luogo simbolico assume i connotati di un gesto politico: un campo di grano, emblema della vita rurale, si erge in netto contrasto con lo spietato verticalismo dell’architettura finanziaria. A differenza di molti interventi di Land Art – movimento artistico nato tra il 1967 e il 1968 negli Stati Uniti –, l’opera di Denes non si limita a condividere il netto rifiuto dell’istituzione museale come unico spazio deputato alla fruizione dell’arte, né si riduce al solo impiego di materiali non convenzionali e organici destinati al deperimento. L’opera, piuttosto, diversamente da altri ben più noti esempi di earthworks [2], evita anche il ricorso alla monumentalità e alla trasformazione invasiva del paesaggio, prediligendo un approccio che invita a riflettere sulla cura e la rigenerazione dell’ambiente. Anziché, dunque, attuare un’azione di dominio e controllo sulla natura, per esempio costruendo gigantesche spirali nei laghi con i bulldozer [3], impacchettando intere isole con tessuti in polipropilene [4], scavando canyon artificiali [5] o edificando cattedrali di cemento in mezzo al deserto [6], Denes innesca un’azione di cura rivolta a un territorio fortemente deturpato dall’azione umana [7]. Attraverso la coltivazione del grano, siamo invitati a riflettere su una forma di interazione con l’ambiente che non impone ma guarisce, che non trasforma in modo violento, ma ripristina e riattiva un terreno degradato e reso sterile.
Nello stesso anno, dalla parte opposta del mondo, a Kassel, in occasione della settima edizione di Documenta, un altro grande pioniere dell’arte ecologica radicale, Joseph Beuys, presenta 7.000 oaks, una monumentale opera di piantumazione di querce nella città di Kassel, concepita come azione di denuncia contro la deforestazione e proseguita fino al 1987, anno successivo alla sua morte. Pur distanti geograficamente, Denes e Beuys condividono una visione affine: la necessità di ripensare il nostro rapporto con la terra, riconoscendo l’interdipendenza tra esseri umani e natura. Sono infatti anni in cui, rispetto al passato, comincia a emergere, nell’arte contemporanea, una diversa sensibilità nei confronti della questione ecologica, una concezione che vede esseri umani e natura sempre più inseparabili. Tra questi precursori della futura arte ecologica, Denes si distingue per un approccio più consapevolmente ecofemminista: il suo lavoro si pone infatti come una potente metafora della contraddizione tra natura e urbanizzazione, tra crescita economica e sostenibilità ambientale, e rappresenta una sfida al sistema capitalistico e alla sua logica di sfruttamento delle risorse naturali.
Piantando e curando il grano per diversi mesi, in uno spazio urbano dominato dal capitalismo e dal potere maschile, l’opera di Denes rappresenta simbolicamente il recupero del controllo femminile sulla terra e sulla fertilità, facendo scaturire una riflessione profonda su come il dominio della natura e l’oppressione delle donne siano due facce della stessa medaglia.
Questa stessa riflessione costituisce il fondamento dell’intera filosofia di Françoise d’Eaubonne, figura di spicco del femminismo francese, intellettuale libertaria e inesauribile grafomane, con oltre cento opere prodotte tra saggi, romanzi, biografie e poesie. Militante del Mouvement de libération des femmes (MLF) sin dai primi anni della sua fondazione, d’Eaubonne ha avuto la lungimiranza di estendere il dibattito femminista alle questioni ambientali, elaborando una visione in cui ecologia e femminismo sono considerati e trattati come variabili inscindibili [8]. Questa prospettiva, decisamente innovativa per l’epoca, si concentra sull’analisi della matrice comune che lega l’oppressione delle donne con lo sfruttamento sistematico della natura, ponendo le basi per quella che lei stessa definirà, nel suo celebre saggio del 1974, Il femminismo o la morte, come una “nuova forma di umanesimo” (d’Eaubonne 1974, tr. it. 2022): l’“ecofemminismo” [9].
Alla base di questa duplice oppressione perpetuata nei confronti della natura e del corpo femminile, si colloca il fenomeno storico e culturale che d’Eaubonne definisce fallocratismo (termine che oggi potremmo assimilare, più ragionevolmente, al concetto di “patriarcato”). Il fallocratismo, massima espressione dell’eterosessismo, funge da struttura attraverso cui le società umane regolano le istituzioni, le politiche e i rapporti di potere, garantendo così la subordinazione e il controllo delle donne e delle minoranze, così come delle risorse naturali, a esclusivo vantaggio di un ordine gerarchico dominato dagli uomini: “[…] il fallocratismo corrisponde sia a una struttura mentale, sia a un fatto politico e sociale storicamente datato, dipendente con molta probabilità dalla presa di possesso dell’agricoltura, fino a quel momento dominio della donna, da parte dell’uomo” (ivi, p. 231).
Questa piena affermazione dell’egemonia maschile, ai danni della controparte femminile, si sarebbe compiuta, per d’Eaubonne, durante l’ultima fase del Neolitico, grazie allo sviluppo delle prime civiltà urbane e al consolidamento di un’economia prevalentemente agricola, ovvero in quel momento, intorno al 3000 a.C., in cui si sarebbe verificato un “grande rovesciamento”: la scoperta da parte degli uomini di poter controllare sia la fecondità della terra, attraverso le pratiche agricole, sia quella delle donne, tramite l’atto riproduttivo. Questo passaggio segnò una profonda trasformazione nei rapporti di potere tra i generi e nel modo in cui la società cominciava a organizzare il lavoro e la proprietà.
Nelle società pre-agricole, basate su caccia e raccolta, le donne rivestivano un ruolo centrale quali raccoglitrici, attività che potrebbe aver contribuito alla domesticazione delle piante e alla scoperta delle prime tecniche agricole. Tuttavia, con l’intensificazione dell’agricoltura e l’introduzione di strumenti e tecnologie più avanzate, il ruolo sociale delle donne fu progressivamente marginalizzato e confinato alla sfera domestica e riproduttiva, mentre la gestione del lavoro agricolo e della terra divenne prerogativa maschile.
In questo contesto, la fertilità femminile assunse nuova centralità: non solo per garantire la continuità della forza-lavoro necessaria per sostenere le nascenti società agricole, ma anche per preservare e tramandare la proprietà terriera all’interno della discendenza familiare. È in questo quadro che si radica l’istituzione del matrimonio, non tanto come semplice unione romantico-affettiva, quanto piuttosto come contratto s ciale attraverso cui sancire diritti di proprietà, eredità e alleanze politiche. Il matrimonio divenne pertanto uno strumento attraverso il quale gli uomini consolidarono il loro controllo sulla terra e sui corpi femminili. Ecco perché, nell’opera di Denes, piantare e prendersi cura della terra diviene un atto di riappropriazione simbolica della fertilità delle donne, in opposizione a millenni di dominio maschile. Laddove infatti l’agricoltura neolitica aveva sancito la subordinazione delle donne a un sistema patriarcale, Denes ripristina un rapporto basato sulla cura e sulla rigenerazione, proponendo un’alternativa ecologica e femminista che rompe con le logiche di sfruttamento e dominio maschile.
Tornando a d’Eaubonne, la scoperta da parte degli uomini della possibilità di amministrare la fertilità, sia della terra che delle donne, avrebbe causato due delle più gravi minacce per la sopravvivenza dell’umanità e delle altre specie su questo pianeta: la crescita demografica incontrollata e la distruzione ambientale. La filosofa esprime una correlazione simultanea tra questi due fenomeni quando afferma: “Una delle due più serie minacce che gravano sulla nostra umanità è l’attuale tasso demografico mondiale. L’altra, che gli è parallela, è la distruzione dell’ambiente” (ivi, p. 195). Queste due problematiche costituirebbero dunque la diretta conseguenza del doppio controllo esercitato dal patriarcato verso la terra e verso la donna, rese entrambe oggetto di sfruttamento:
Sequestrati il suolo, quindi la fertilità (più tardi l’industria), e il ventre della donna (cioè la fecondità), era logico che il sovrasfruttamento dell’una e dell’altra avrebbe portato a questo duplice pericolo minaccioso e parallelo: la sovrappopolazione, l’eccesso di nascite, e la distruzione dell’ambiente, l’eccesso di prodotti (ivi, pp. 375-376).
In questo senso, la società patriarcale emergerebbe come responsabile diretta dei due fenomeni che minacciano gravemente la sostenibilità del pianeta. Il controllo demografico si presenta infatti come uno dei principali strumenti del potere maschile, attraverso il quale gli uomini hanno storicamente esercitato il proprio dominio sulla riproduzione e sui corpi delle donne, negando loro il diritto alla libertà sessuale e imponendo restrizioni sulla gestione della fecondità, come il controllo delle nascite e la negazione dell’aborto [11]. D’Eaubonne evidenzia come questo sistema di controllo non abbia soltanto oppresso le donne, ma abbia avuto di fatto ripercussioni devastanti sull’intero ecosistema:
L’uomo del sistema patriarcale è quindi, in primo luogo, responsabile dell’assurda crescita demografica così come lo è della distruzione dell’ambiente e dell’inquinamento accelerato, che vanno di pari passo con questa follia di lasciare in eredità un pianeta invivibile a chi lo prolungherà (ivi, p.121).
Il sovrappopolamento e l’eccessiva pressione sulle risorse naturali sono dunque, nella visione della filosofa, non fenomeni isolati, ma interconnessi e alimentati da una struttura patriarcale, governata da un soggetto egemone, quello maschile, che privilegia il controllo e l’accumulo, a scapito della sostenibilità e della conservazione del pianeta.
Nella storia dell’arte contemporanea sono numerosi gli esempi di opere che indagano il legame tra lo sfruttamento della natura e l’oppressione esercitata sui corpi femminili.
Un esempio emblematico è Untitled (We Won’t Play Nature to Your Culture) dell’artista statunitense Barbara Kruger, realizzata nel 1983. In questa immagine in bianco e nero, che ammicca esplicitamente al linguaggio pubblicitario e dei mass media, Kruger esplora la relazione tra genere, natura e cultura, mettendo in discussione le costruzioni sociali che definiscono ciò che è “naturale” come qualcosa di essenzialmente femminile e passivo, contrapposto invece alla “cultura”, tradizionalmente associata al soggetto maschile che domina la società. Lo slogan che sovrasta l’immagine, “We won’t play nature to your culture” (“Non interpreteremo la natura per la vostra cultura”), è un’affermazione provocatoria di resistenza contro le aspettative patriarcali che vedono le donne come figure naturali, quindi inferiori, contrapposte invece alla ragione e al progresso, incarnati dagli uomini.
In modo ancora più esplicito, l’artista cubana Ana Mendieta, con la sua serie Silueta (1973-1980), utilizza il corpo per esprimere simbolicamente l’intima connessione che unisce le donne e la terra, rappresentando entrambe come oggetto di violenza e sfruttamento. Costretta a emigrare negli Stati Uniti all’età di dodici anni durante l’Operazione Peter Pan [10], Mendieta utilizza il proprio corpo come mezzo espressivo per esplorare questioni legate all’identità personale e culturale, evidenziando un forte legame con la terra e le proprie radici cubane. In questi lavori performativi e fotografici, l’artista imprime la propria sagoma in vari paesaggi naturali, come terra, sabbia, rocce e acqua, spesso combinandola con materiali come fiori, foglie, terra e sangue.
Queste impronte corporee incarnano la ricerca di un senso di appartenenza e il desiderio di riconnettersi con la terra perduta, evocata come una presenza materna e primordiale.
Mendieta utilizza il corpo femminile come strumento di ribellione contro le convenzioni patriarcali, che storicamente lo hanno relegato al ruolo di oggetto passivo del desiderio maschile. Nelle sue opere, il corpo assume piuttosto una funzione attiva e vitale, integrandosi profondamente con il paesaggio. Questo processo di fusione tra corpo e natura non solo sfida le tradizionali rappresentazioni estetiche del femminile, ma ne ridefinisce il significato, trasformandolo in simbolo di forza e resistenza.
Proseguendo in questo itinerario iconografico, uno dei lavori in cui la connessione tra corpo femminile e natura emerge forse in modo più dirompente è la serie fotografica Isis della statunitense Tee A. Corinne, realizzata nel 1986. In queste immagini, vulve giganti si fondono in armonia con paesaggi suggestivi dell’Oregon, come boschi, coste marine e cieli nuvolosi. Le vulve, integrate nella texture del paesaggio, conferiscono alla natura una dimensione erotica e simbolica, che richiama inevitabilmente la celebre opera di Gustave Courbet, L’origine del mondo (1866), una rappresentazione, scandalosa per l’epoca, della sessualità femminile come emblema di vitalità e forza primordiale e generatrice. Tuttavia, mentre Courbet esplorava l’erotismo femminile in un contesto che rifletteva lo sguardo maschile dominante, Corinne ribalta questa prospettiva, sottraendo il corpo femminile al male gaze [12] e riconnettendolo in modo attivo alla natura.
Nella sua opera, infatti, i genitali femminili non rappresentano più oggetti passivi da osservare voyeuristicamente, ma soggetti erotici attivamente integrati nel paesaggio. Questa fusione si inserisce all’interno di una tradizione femminista e lesbica, che Corinne fa propria negli anni ’70 per tentare di decostruire e scardinare le rappresentazioni tradizionali della sessualità femminile nella storia dell’arte, proponendo immaginari che celebrano la sessualità femminile e queer al di fuori delle logiche del desiderio maschile.
Un ultimo esempio, affine a quelli finora presentati, di opere che esplorano l’intima connessione tra corpi femminili e natura è la serie fotografica Chipko Tree Huggers of the Himalayas dell’artista indiana Pamela Singh. Questa serie si colloca perfettamente all’interno della tradizione ecofemminista, indagando le affinità tra lo sfruttamento della natura e l’oppressione delle donne. Singh ci porta all’interno del movimento Chipko, un’organizzazione per la salvaguardia delle foreste nata in India negli anni ’70 attraverso una serie di azioni non violente. La caratteristica distintiva di questo movimento è la forte presenza femminile, legata al ruolo centrale che le donne svolgono nell’approvvigionamento di risorse come legna e foraggio, vitali per la sussistenza delle comunità locali. La preservazione delle foreste rappresenta pertanto una questione cruciale per la sopravvivenza. L’origine di questo movimento, secondo un’antica leggenda, risalirebbe a un episodio avvenuto alcuni secoli prima, nel 1730, quando una donna indiana di nome Amrita Devi sacrificò la propria vita per difendere gli alberi del suo villaggio, stringendoli in un abbraccio per impedire che venissero abbattuti per la costruzione di un nuovo palazzo voluta dal Maharaja. Questa leggenda fu di ispirazione per molte donne, in prevalenza contadine, che negli anni ’70 del XX secolo avviarono una serie di proteste non violente per proteggere gli alberi delle proprie terre dai taglialegna autorizzati dallo Stato e dalla grande industria. La nascita di questo movimento rappresentò quindi un momento di presa di coscienza ecologica collettiva da parte delle donne delle comunità locali, divenendo per il movimento ecofemminista un esempio emblematico per mostrare gli elementi di affinità tra la subordinazione delle donne e quella della natura da parte delle multinazionali globali, totalmente disinteressate alle condizioni di sopravvivenza delle popolazioni locali e alla preservazione di un territorio ritenuto sacro. Le donne himalayane documentate in bianco e nero da Singh nel ’94 e ritratte con le braccia posizionate intorno agli alberi come scudi umani rappresentano le testimoni dirette non soltanto delle proteste contro la deforestazione in atto nelle regioni himalayane, ma anche di una serie di iniziative di cooperazione e mutuo soccorso finalizzate a ricucire la coesione sociale delle comunità locali che i tagliatori di legna, sostenuti da multinazionali e autorità governative, tentano quotidianamente di sgretolare attraverso violenza, corruzione e devastazione ambientale.
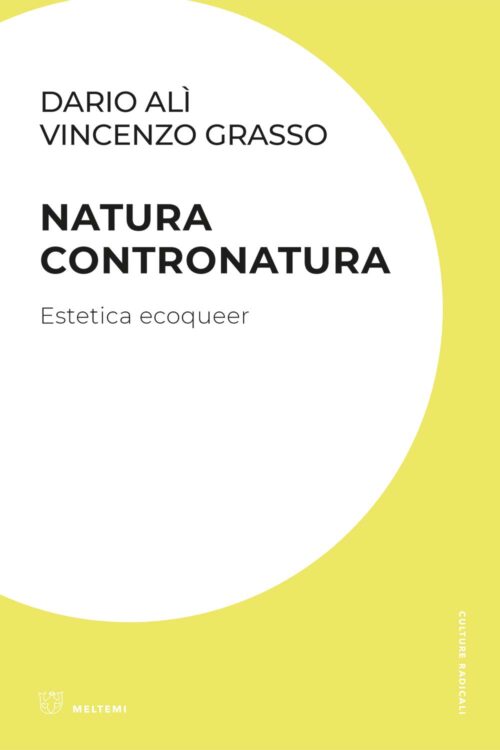
1 L’opera è stata replicata anche in altre città, tra cui Londra (2009), Milano (2015), Basilea (2024), Bozeman (2024).
2 Così vengono definite, sin dalla nascita del movimento, le opere di Land Art. Earthworks è infatti il titolo della prima mostra di Land Art che si tennenel 1968 presso la Dwan Gallery di New York. In quell’occasione furono esposte le opere di Robert Morris, Robert Smithson, Carl Andre, Walter De Maria, Michael Heizer, Claes Oldenburg, Dennis Oppenheim e Sol LeWitt.
3 Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970.
4 Christo e Jeanne-Claude, Surrounded Islands, 1980-’83.
5 Michael Heizer, Double Negative, 1969.
6 Michael Heizer, City, 1970-2022.
7 Sulla stessa scia, qualche anno prima, tra il 1965 e il 1978, l’artista statunitense Alan Sonfist realizzava, sempre a Manhattan, l’opera Time Landscape, reintroducendo la flora indigena di epoca precoloniale, risalente quindi a circa 300 anni prima, in un’area urbana ormai considerata sterile. Questo “monumento vivente” non era lasciato al caso, ma frutto di un’accurata ricerca sulle caratteristiche botaniche e geologiche dell’area e sulla storia di New York, una vera e propria ricerca di “archeologia ecologica”.
8 Françoise d’Eaubonne contribuisce anche alla fondazione del Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR). A lei si deve inoltre la fondazione del gruppo francese Écologie-Féminisme, nato allo scopo di collegare i temi ecologici e femministi contro il potere maschile e lo spreco delle risorse naturali.
9 Il termine “ecofemminismo” è stato coniato da Françoise d’Eaubonne e presentato per la prima volta all’interno del suo libro del 1974, Il femminismo o la morte.
10 Una ricostruzione approfondita del ruolo della pillola contraccettiva è fornita da Tripaldi (2023), dove l’autrice analizza il doppio volto della contraccezione ormonale, evidenziandone da un lato il contributo all’autodeterminazione riproduttiva delle donne, mentre dall’altro le implicazioni di controllo politico e sorveglianza che hanno intensificato il disciplinamento esercitato sui corpi femminili.
11 Questa espressione fa riferimento all’operazione clandestina che portò più di 14.000 bambini cubani, di età compresa tra 6 e 18 anni, a essere trasferiti negli Stati Uniti tra il 1960 e il 1962. I genitori, spinti dalla paura di voci non confermate secondo cui Fidel Castro e il Partito Comunista avrebbero sottratto loro i diritti genitoriali e portato i figli in presunti centri di indottrinamento comunista, decisero di mandarli via dal proprio Paese per metterli al sicuro.
12 Per una discussione più approfondita sul concetto di male gaze si rimanda al capitolo successivo.