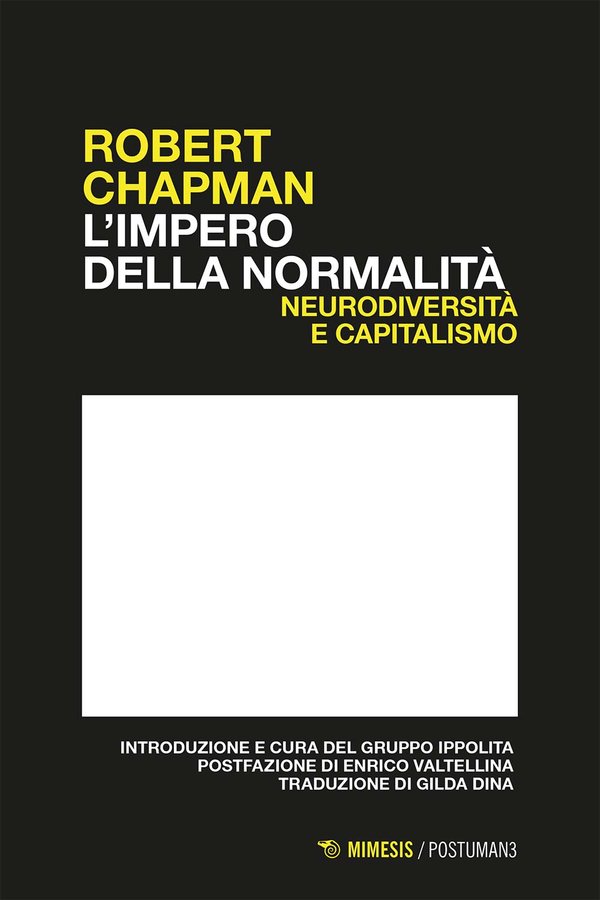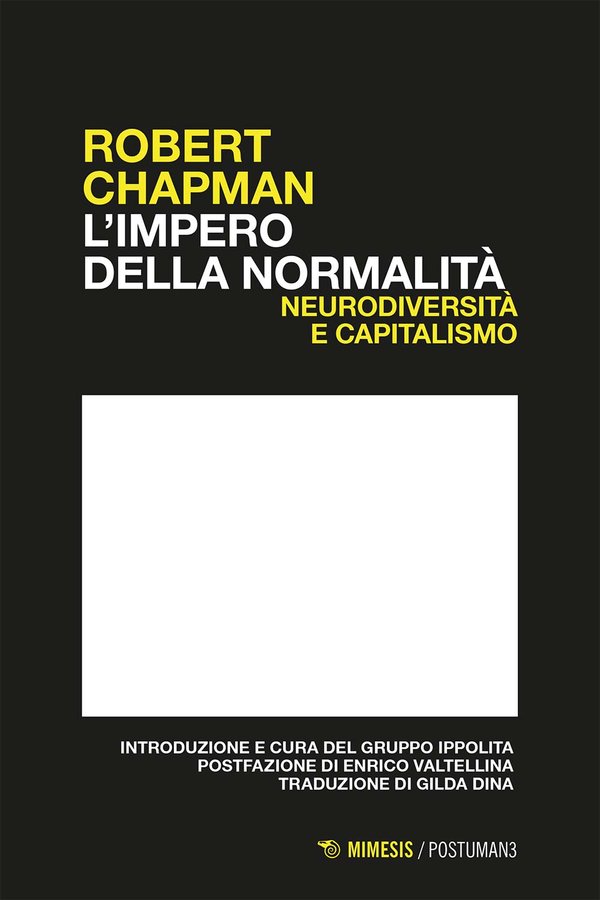Robert Chapman è unx filosofx neurodivergente che si occupa di teoria della neurodiversità, di follia e di disabilità. Ha insegnato al King’s College di Londra, all’Università di Bristol, a Sheffield Hallam e all’Università di Durham, dove attualmente è Assistant Professor in Critical Neurodiversity Studies. Scrive su “Psychology Today” e su “Critical Neurodiversity”. È noto per il suo lavoro pionieristico negli studi sulla neurodiversità e sulla filosofia della disabilità.
Nel 2023 ha pubblicato il suo primo libro, L’Impero della normalità. Neurodiversità e capitalismo, Recentemente tradotto in italiano per Mimesis Edizioni da Gilda Dini, a cura del gruppo Ippolita e con la postfazione di Enrico Valtellina.
Il libro critica il modo in cui il potere patologizza le differenze neurologiche, imponendo una norma di produttività e conformità. Chapman propone la neurodiversità come movimento di giustizia sociale, non solo come concetto medico. Sostiene che le strutture attuali non sono naturali né immutabili, ma storicamente costruite e trasformabili. Il testo intreccia filosofia, storia della psichiatria e testimonianze personali per ridefinire cosa significa vivere fuori dalla norma. L’Impero della normalità descrive un apparato di relazioni materiali, pratiche sociali e procedure amministrative che emergono dal sistema capitalista. Insieme, questi fattori costruiscono una misura della normalità fisica, cognitiva ed emotiva.
Robert Chapman adotta un approccio intersezionale che considera classe, razza, genere, sessualità e disabilità fisica e in questo quadro la neurodiversità diventa una potenza critica che aiuta a costruire una liberazione collettiva.
Il testo di Chapman descrive un assetto economico e sociale che nel tempo ha creato uno standard cognitivo via via più restrittivo, parallelamente all’affermarsi di disuguaglianze economiche sempre maggiori. Sottolinea inoltre la connessione tra oppressione neurodivergente, colonialismo e imperialismo. Ringraziamo l’editore per la possibilità concessa.
Il movimento per la neurodiversità emerse inizialmente tra gruppi di attivisti autistici negli anni Novanta, ai tempi in cui a scuola avevo ancora difficoltà di elaborazione.
All’epoca, l’autismo era comunemente considerato una tragedia medica personale, incompatibile con una vita umana serena. L’unica speranza per le persone autistiche e i loro familiari, si pensava, era che un giorno sarebbero guarite grazie al condizionamento comportamentale o all’intervento biomedico.
Tuttavia, attorno al 1993 la maggiore diffusione dei computer e di Internet fece sì che le persone autistiche potessero iniziare a connettersi in rete per la prima volta. L’incontro di menti autistiche diede vita a un intenso periodo di presa di coscienza che mise in discussione la comprensione dominante dell’autismo. Una volta riuniti, questi pionieri dell’attivismo autistico cominciarono a rendersi conto che avevano avuto tutti gli stessi problemi, compresi quello che ho appena descritto rispetto alla mia vita. Pertanto, cominciarono a sostenere che i problemi che avevano vissuto forse non avevano tanto a che fare con un malfunzionamento dei loro cervelli, quanto con l’incapacità della società di accogliere le loro differenze neurologiche, affermando così ciò che nel 1997 un’inchiesta del “New York Times” descrisse come una forma di “pluralismo neurologico”. Questo approccio sottolineava l’esigenza di accettare e sostenere i comportamenti e gli stili di elaborazione delle persone atipiche, invece di inquadrarli come patologie mediche da controllare, trattare e curare.
Da qui nacque l’idea della “neurodiversità”, menzionata per la prima volta dall’allora studentessa di sociologia Judy Singer. Il punto fondamentale era che dovremmo rifiutare l’idea stessa di cervello “normale” e l’ideale “neurotipico”, e vedere invece il funzionamento della mente in modo più simile a come vediamo la biodiversità. In questa prospettiva, tutti i tipi di mente sono necessari al funzionamento della società, quindi non si dovrebbe presumere che la normalità sia superiore alla divergenza; anzi, esistono più tipi di mente, ognuna delle quali è abile o disabile in diversi ambienti, e nessuna di queste è naturalmente superiore alle altre. Per esempio, potremmo pensare che il tipo di problemi sensoriali che io stessx ho vissuto siano il risultato di una progettazione di scuole, luoghi di lavoro e spazi pubblici basata su un bias neurotipico. Da questo punto di vista, in senso più ampio, potremmo comprendere buona parte della sofferenza vissuta dalle persone autistiche – come il bullismo che ho incontrato a scuola – soprattutto nel contesto dell’emarginazione e della discriminazione sociale.
Per porvi rimedio, Singer e altri attivisti invocarono una nuova “politica della diversità neurologica”, che dal loro punto di vista consisteva in un nuovo movimento ispirato ai precedenti movimenti per i diritti civili che avevano cercato di porre fine ovunque alla segregazione e all’oppressione razziale, sessuale e di genere. Questo nuovo movimento per la neurodiversità – speravano – avrebbe affiancato le battaglie esistenti lottando per i diritti delle persone neurologicamente strane e disabili. La speranza era di porre fine ovunque all’oppressione neurodivergente, ridisegnando il mondo affinché coltivi la crescita sana delle persone neurodivergenti. L’appello a una politica della neurodiversità ebbe un forte impatto e molti nuovi promotori si unirono alla causa.
Anche se queste prime iniziative erano concentrate sull’autismo, il quadro teorico e i vocabolari che emersero dagli spazi autistici furono velocemente adottati da moltissime altre persone: anzitutto, da chi aveva altri generi di disabilità dello sviluppo, come il disturbo da deficit d’attenzione (ADHD) o la disprassia, e successivamente anche da chi aveva diagnosi di tipo diverso, come il disturbo bipolare e il disturbo borderline di personalità, senza contare chi non aveva alcuna diagnosi ufficiale.
L’ampiezza di tale espansione è catturata dal termine “neurodivergente”, coniato da Kassiane Asasumasu nei primi anni del nuovo millennio per indicare qualsiasi tipo di funzionamento neurologico considerato “divergente da quello tipico”, che si tratti di semplici differenze disabilizzate da una società non accogliente o da problemi medici come l’epilessia. Asasumasu scrisse che il concetto era “specificatamente uno strumento d’inclusione”, a disposizione di chiunque fosse neurologicamente atipico e lo ritenesse utile. Se da un lato tale espansione sollevò domande sull’ampiezza e sui limiti del quadro della neurodiversità, dall’altro fu importante perché aiutò molte più persone a riunirsi sotto la sua bandiera.
Allo stesso tempo, come rilevò Steve Graby, mentre i sostenitori dell’antipsichiatria avevano sottolineato di non essere come le persone con disabilità fisiche – e che le persone psichiatrizzate non erano veramente disabili – la prospettiva della neurodiversità abbracciava l’identità disabile. Sottolineare le similitudini tra la disabilitazione mentale e quella fisica consentì una politica più ampia e inclusiva, dove i promotori della neurodiversità erano a cavallo del divario tra corpi medicalizzati e menti medicalizzate.
Con la crescita del movimento, la teoria della neurodiversità venne ulteriormente sviluppata per fornire risposte adeguate. Significativamente, secondo me, nel 2011 una giovane ricercatrice autistica, Nick Walker, suggerì che la liberazione neurodivergente non avesse solo bisogno di diritti, ma anche di un cambiamento su vasta scala del paradigma scientifico e culturale. Questo cambiamento avrebbe comportato l’allontanamento dal “paradigma della patologia” dominante, che per Walker era definito da standard di normalità mentale molto ristretti, e dalla patologizzazione e stigmatizzazione automatica della divergenza. La giovane ricercatrice richiamò l’attenzione su questo aspetto, ritenendolo alla base della ricerca e della pratica psichiatrica e psicologica, nonché delle risposte sociali più generali alla neurodivergenza.
Al suo posto, secondo Walker, i promotori della neurodiversità dovevano costruire un “paradigma della neurodiversità” che abbracciasse e sostenesse una gamma molto più ampia di variazioni cognitive ed emotive. Tale prospettiva non offriva solo speranza a innumerevoli persone neurodivergenti, ma anche un ideale a cui mirare collettivamente. Un ideale al quale, in quanto filosofx, avrei presto dedicato i miei sforzi, poiché sapevo che il cambiamento di paradigma avrebbe richiesto un lavoro teorico fondamentale, oltre al cambiamento delle pratiche scientifiche, cliniche e culturali.
Entrai in contatto con tale prospettiva per la prima volta nel 2012, un anno dopo la pubblicazione fondamentale di Walker. Leggere Singer, Walker e altri promotori del movimento mi offrì un percorso diverso rispetto a quello inquadrato dal paradigma della patologia o a quello del negazionismo antipsichiatrico, consentendomi di riconoscere appieno la realtà delle mie disabilità, ma in un modo che mi aiutò a sviluppare coscienza della natura politica dei generi di avversità che avevano strutturato la mia intera esistenza.
Attraverso le lenti della neurodiversità cominciai a chiedermi, per esempio, se fin dall’inizio della mia vita la società neuronormativa non mi avesse reso una persona disabile.
Arrivai a capire che il mio apprendimento, il mio sviluppo e le mie prospettive erano stati ostacolati fin da subito, e cominciai anche a comprendere che il mio trauma e la mia malattia mentale non derivavano solo dalla povertà relativa e dall’abbandono familiare, ma anche da un mondo strutturalmente abilista. Per me, come per molte altre persone, questa concezione più articolata fu liberatoria, e mi fece dare nuovo senso alla mia vita.
Altrettanto importante è che questa prospettiva mi aiutò a maturare solidarietà nei confronti di altre persone disabili e malate croniche, e persino un sentimento di orgoglio disabile. Tutto ciò mi aiutò a combattere l’isolamento, l’inerzia politica e la vergogna, e aiutò me e tante altre persone a iniziare a vedere una via d’uscita. Finalmente, all’improvviso, sembrava che le persone neurodivergenti potessero cambiare il mondo collettivamente, rendendolo più inclusivo per le persone neurologicamente strane e disabili. Questo diede un tipo di speranza impensabile sino ad allora, ragione per cui mi lanciai nel movimento proprio mentre stava iniziando a crescere rapidamente, in una misura e in un modo che nessuno ai tempi avrebbe potuto prevedere.
Con il crescere del movimento dal 2012, buona parte dell’attivismo per la neurodiversità ha proseguito all’interno di un quadro liberale basato sui diritti, concentrandosi su riforme graduali nel sistema attuale; contemporaneamente, al suo interno sono stati compiuti sforzi collettivi enormi focalizzati sul superamento del paradigma della patologia: un duplice approccio a cui ho contribuito dedicando molto tempo ed energia con la mia partecipazione al movimento. Iniziai con il blogging e le campagne di sensbilizzazione, proseguendo poi con la ricerca di dottorato e, da allora, promuovendo, insegnando e facendo ricerca all’interno dell’accademia. Tuttavia, sebbene trovi molto utile la prospettiva della neurodiversità, e sebbene abbia direttamente contribuito agli sforzi per svilupparla, ho anche cominciato a trovare insoddisfacente l’approccio dominante all’analisi, all’attivismo e alla promozione della neurodiversità.
Sicuramente ho potuto constatare in prima persona che l’approccio liberale ha raggiunto importanti traguardi in breve tempo. Sotto la continua pressione degli attivisti neurodivergenti, la ricerca ha sempre più attinto alla teoria della neurodiversità, le rappresentazioni culturali della neurodivergenza sono diventate meno stigmatizzanti, e anche il modo in cui progettiamo il nostro mondo sociale ha iniziato a cambiare […].
Nondimeno, con il tempo mi resi sempre più conto che, nonostante i suoi reali successi, l’attivismo per la neurodiversità di approccio liberale e basato sui diritti aveva anche limiti significativi. Consideriamo alcuni dei seguenti fatti.
Malgrado i nostri sforzi congiunti per molti anni, la maggior parte della ricerca, della politica e delle pratiche continuava a basarsi sul paradigma della patologia. Persino nel caso dell’autismo, in cui i progressi sono stati più rapidi, la “terapia” più diffusa era ancora l’analisi comportamentale applicata: un’analisi concepita sull’uso di un sistema di punizioni e premi per cercare di rendere i bambini autistici più “normali”. Nonostante le innumerevoli critiche mosse dai promotori della neurodiversità, che consideravano tale analisi un metodo abusivo e una forma di terapia di conversione, questa industria internazionale multimiliardaria continuava a crescere, facendo solo piccole concessioni ai suoi critici.
Allo stesso tempo, molti esperti inseriti nel vecchio paradigma medicalizzato cominciarono a ribattezzarsi come esperti di “neurodiversità”, senza cambiare significativamente approccio. Psichiatri, psicologi e politici adottavano i vocabolari del movimento per la neurodiversità – anche se spesso erroneamente – e apportavano modifiche superficiali alla pratica, lasciando invariato il paradigma della patologia […].
Più in generale, a prescindere dai traguardi in termini di diritti e riconoscimento, l’apparato di forze sociali che disabilita e discrimina le persone neurodivergenti è rimasto invariato. […]
Per questo, nonostante le conquiste concrete in termini di diritti e rappresentazione, era chiaro che il movimento fosse distante dal raggiungimento del suo obiettivo a lungo termine: la liberazione delle persone neurodivergenti attraverso un cambio di paradigma più ampio. Semmai, qualora il riformismo liberale abbia aiutato concretamente delle persone neurodivergenti, si è trattato soprattutto di persone già relativamente privilegiate sotto altri aspetti – bianche, borghesi e così via –, lasciando che si moltiplicassero le persone neurodivergenti emarginate, imprigionate in una serie di strutture carcerarie, senzatetto o in altre situazioni insostenibili. Per quanto mi riguarda, tutto ciò mi ha portato a chiedermi che cosa serve esattamente per ottenere l’emancipazione e per quale motivo i traguardi in termini di diritti e riconoscimento non l’abbiano ottenuta. Ho riflettuto sull’origine esatta del paradigma della patologia, sul perché fosse riuscito a diventare così dominante, e su come si collegasse ai fattori economici e sistemici più ampi ai quali lo vedevo sempre più profondamente intrecciato.
Attraverso la ricerca storica che ho condotto sulle origini del paradigma della patologia, ho maturato la convinzione che il problema risiedesse a un livello più profondo, legato in particolare a fattori sociali, tecnologici ed economici sottesi.