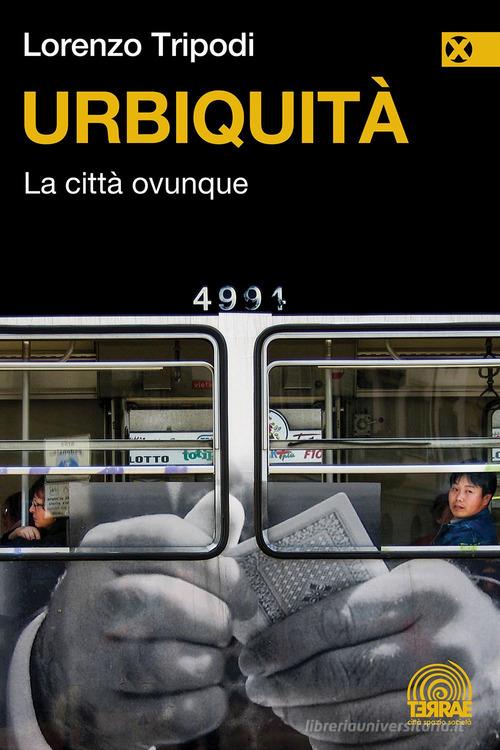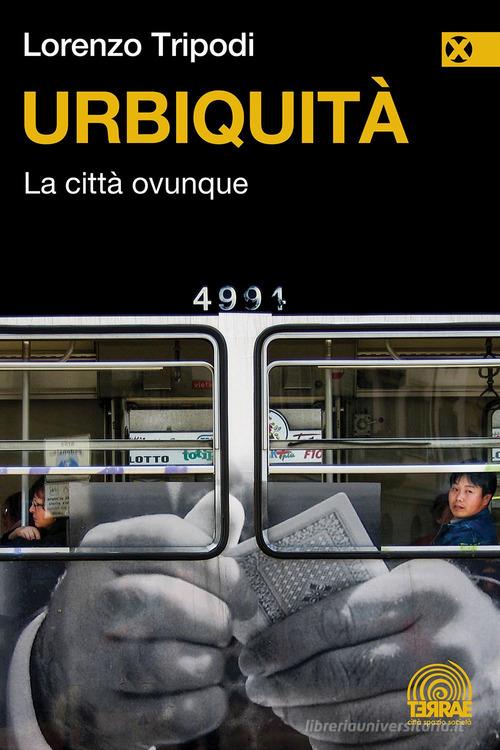Urbiquità. La città ovunque, di Lorenzo Tripodi – urbanista, film maker, attivista, cofondatore del collettivo ogino:knauss a Firenze negli anni novanta e di Tesserae Urban Social Research a Berlino nel 2011 – è una riflessione sul paesaggio urbano in trasformazione che mescola teoria, azione e deriva psicogeografica. Ed è anche il tentativo di reinterpretare il concetto di città in relazione al crescente intreccio tra produzione di spazi e immagini.
Mentre fabbrica e conflitto diventano sempre più invisibili, le città si sono trasformate in dispositivi di produzione, distribuzione e consumo di immagini.
Finanzializzazione, gentrification, festivalizzazione e turistificazione dei centri urbani corrispondono ad altrettante forme di controllo su flussi visuali che richiedono nuovi strumenti di analisi.
Eppure la città è viva e vegeta: diluita nell’urbanizzazione planetaria, ha cambiato ruolo, consistenza e disposizione, ma continua a essere elemento fondamentale del paesaggio umano.
Il libro è edito da Agenzia X che ringraziamo per averci concesso il permesso di pubblicare questo estratto.
Questo viaggio nella città contemporanea prende avvio da un concetto ineffabile, quello di spazio pubblico. Di spazio pubblico si è fatto un gran parlare negli ultimi decenni, e con particolare intensità a partire dal tramonto della modernità alla chiusa dello scorso millennio.
La successiva breve e incerta aurora della postmodernità è stata intrisa in un discorso che rivendicava l’importanza e il valore dello spazio pubblico da numerose prospettive: dalla dimensione sistemica (spazio pubblico come infrastruttura essenziale al buon funzionamento della città) a quella sociale (spazio pubblico come agorà, come luogo di incontro, ribalta della partecipazione politica); dalla dimensione ambientale (spazio pubblico come polmone verde, sistema linfatico, tessuto organico al benessere dei cittadini) a quella economica (spazio pubblico come incubatore di impresa e commercio, come attrattore di investimento nella città); da quella culturale (spazio pubblico come memoria collettiva, conservatorio del patrimonio tangibile e intangibile, ma anche come luogo di formazione e capitalizzazione dell’identità urbana) a una più radicale dimensione conflittuale (spazio pubblico come luogo di emersione dell’istanza politica, della rivendicazione, del dissenso).
È un discorso che si nutre sostanzialmente di una nostalgia, l’assenza di un luogo che fu e non è più: nostalgia di uno spazio idealizzato, che probabilmente non è mai esistito ma che evoca e nutre il seme della rigenerazione urbana a venire.
È un discorso che si sviluppa sulla dissoluzione della metropoli industriale, si nutre della crisi sistemica degli anni settanta, germoglia sulle macerie della città operaia e borghese, e fiorisce sulla nozione di degrado. Il discorso nostalgico dello spazio pubblico si radica in una presunta e discutibile condizione ideale della città – supposta esistere in precedenza – vissuta come identità collettiva, luogo di condivisione e coesione sociale. E non v’è dubbio che tale senso di perdita affondi le sue radici in cambiamenti oggettivi drastici, tangibili.
Il boom economico del dopoguerra, oltre a erogare l’illusione di crescita illimitata e diritti sociali per tutti, stravolge a una velocità mai esperita in precedenza gli equilibri territoriali, espande la dimensione urbana a estensioni inaudite, aggiorna la grammatica dello sviluppo con nuovi concetti quali quelli di area metropolitana e di megalopoli; infine, collassa di fronte all’insostenibilità dello sviluppo incontrollato e alle astuzie della globalizzazione.
La promessa di crescita economica infinita prima gonfia le aspettative delle città radiose e poi le tradisce con beffarda rapidità. È la crisi urbana, una nozione che indica un generale cambio di sentimento rispetto alla città moderna ma anche una vera e propria crisi epistemica, con l’incapacità di riconoscere coerentemente l’oggetto stesso del discorso, i suoi limiti e le sue pertinenze.
Nella seconda metà del ventesimo secolo i centri storici, le city, le downtown avevano da tempo cominciato a perdere la loro distinzione nell’affermarsi dei processi di suburbanizzazione, sprawl, nell’esplosione delle periferie, a favore di un processo di urbanizzazione indistinta, contraddittoria, stratificata, sostanzialmente irriducibile alla nozione tradizionale di città vs campagna o urbano vs non urbano. Le concentrazioni urbane, circoscritte da mura di pietra o da confini amministrativi e circondate da territori extraurbani o rurali, hanno ormai perso ogni coerenza e autonomia, dissolvendosi in dinamiche territoriali complesse.
La città perde progressivamente significato di fronte all’avanzare dell’urbano. Molteplici sono i modi in cui l’originale archetipico modello dell’urbs tradizionale va in frantumi, c’è solo l’imbarazzo della scelta: la cementificazione abusiva del meridione d’Italia a favore di industrializzazioni maldestre e malsane, parallela all’ugualmente dissennata turistificazione delle coste e il conseguente abbandono di borghi e aree interne laboriosamente edificati nei secoli a immagine di società tradizionali spazzate via in pochi decenni; la sub-urbanizzazione della città americana con l’abbandono selvaggio dei centri alla lotta per la sopravvivenza tra poveri e alla violenza armata, parallela all’emersione delle gated community per benestanti; la massiccia pianificazione segregante ed etnicizzata delle banlieue francesi, allo stesso tempo risultato e catalizzatore di conflitto sociale; la non dissimile applicazione massiccia dei principi e delle forme dell’urbanizzazione modernista industrializzata nello sviluppo della città socialista nell’Unione Sovietica e in tutti i suoi stati satellite, dove il modello ha funzionato piuttosto come fattore inibitore, di assopimento o rallentamento del conflitto sociale; l’emergere della favela come antitesi della città e relativa sintesi nella cristallizzazione della diseguaglianza sociale prodotta dal modello capitalista postcoloniale nella città Sudamericana e nel sud del mondo; e così via.
In tutti questi esempi, pur nella diversità delle forme politiche, morfologiche e sociali messe in campo e dei relativi modelli economici, una costante ritorna, delineando i prodromi della globalizzazione a venire: insieme alla riconoscibilità della forma urbana come ambiente distinto e definito, che si disintegra in un nugolo incoerente di distretti, nodi, cluster interconnessi (spesso, mal connessi), zone funzionali, territori marginali ed emarginati, vanno egualmente in frantumi le promesse illuminate della città moderna di provvedere universale diritto ad alloggio, istruzione, welfare e occupazione.
Se finora la città accentratrice aveva rappresentato ingenuamente la spazializzazione del concetto di progresso sociale, riproducendo nella morfologia funzionale ordinata e gerarchica della città moderna l’aspirazione a integrarsi in una società protettiva organizzata secondo una riconoscibile nozione di classe, dove l’equazione tra trovare posto nella società e trovare casa in un quartiere manteneva una parvenza di plausibilità, improvvisamente il senso comune della città come risposta pratica e come promessa di benessere collettivo va in crisi. La crisi urbana esplode in un breve lasso di tempo, scuotendo la fiducia lineare nel progresso che si era sviluppata nei primi decenni dell’era postbellica e della dissuasione nucleare.
Alla fine degli anni sessanta dello scorso secolo, mentre il paradigma di produzione fordista vacilla, si apre una stagione di lotte che uniscono insieme diritto al lavoro, all’istruzione, alla casa, al corpo, alla gioia. Il movimento studentesco, che rivendica l’istruzione universale come base per una società più giusta, ma anche la liberazione dei corpi dal patriarcato, si allea con il movimento operaio, che si trova a fronteggiare le prime avvisaglie dello smantellamento delle strutture produttive in una comune opposizione all’imperialismo. E mentre con i carri armati a Praga si vedono le prime crepe nel blocco sovietico, nel 1968 a Parigi il filosofo marxista Henri Lefebvre dà alle stampe Le droit à la ville, che sarà per i cinquant’anni a venire cri et demande, manifesto della lotta per la città come spazio sociale.
Quello che intuisce prescientemente Lefebvre, prima in forma di manifesto e successivamente come una teoria argomentata (La révolution urbaine), è che la città sta diventando non solo il territorio privilegiato della rivendicazione, ma il corpo stesso, l’oggetto della rivoluzione a venire. Lefebvre, che pure viene dalla sociologia rurale, passando per Hegel, il marxismo eterodosso, la frequentazione del gruppo Socialisme ou barbarie di Cornelius Castoriadis, oltre che dell’Internazionale Situazionista di Guy Debord, è il primo a postulare la centralità dell’urbano nel ridefinire le battaglie a venire, a teorizzare il processo di urbanizzazione come ambito centrale per comprendere e ripensare la trasformazione in atto, tracciando le basi per un rinnovamento dell’intero impianto teorico necessario a ripensare una società alle prese con la crisi della modernità.
[…] L’influenza di Henri Lefebvre sulle discipline urbane si estende in maniera sempre più profonda con il passare degli anni e nutre oggi un’ondata imponente di riletture e interpretazioni. La sua opera è monumentale: oltre sessanta libri e trecento articoli, che attraversano le distinzioni disciplinari e gli steccati ideologici. Inizialmente quasi ignorato, Lefebvre è stato in un secondo momento soprattutto criticato, spesso in maniera parziale e travisata, fino a farsi lentamente strada attraverso la rilettura impegnativa e sistematica di un’accolita di lefebvriani provenienti da ambiti differenti e convergenti verso un progetto complessivo di valorizzazione dell’impianto concettuale dell’autore.
Ambizioso e labirintico, Lefebvre è stato rimproverato di incoerenza, o persino contraddittorietà; le sue formulazioni accusate di essere ampollose e amatoriali. I suoi adepti invece (tra cui mi annovero senza esitazione) trovano che tali difetti, per quanto in qualche misura riscontrabili nella sua personalità, costituiscano altrettanti punti di forza, contribuendo alla realizzazione di un apparato di pensiero duttile e aperto, dalla capacità profondamente generativa. L’opera di Lefebvre affonda le radici nella filosofia moderna – i pilastri della sua formazione sono infatti Hegel, Marx e Nietzsche – eppure, egli rifiuta scientemente ogni tentazione ontologica, ogni ricorso all’a-priori; al contrario, intende la propria pratica come una metafilosofia orientata a produrre cambiamento sociale, dove l’analisi è al tempo stesso critica dell’esistente e progetto di cambiamento.
Il ruolo della filosofia non è per lui quello di stabilire assunti e principi ma di confrontarsi con la pratica e l’azione. Non a caso, i primi a recepire la potenza del discorso lefebvriano sono stati attivisti, artisti, compagni di lotte e di percorso di un uomo che si è sempre situato all’interno degli eventi e delle situazioni, prestando la sua teoria all’azione prima che all’accademia. Lefebvre fu coinvolto personalmente nella pratica dei movimenti: dalla giovanile partecipazione alla resistenza all’adesione al partito comunista (di breve durata, data la sua refrattarietà all’ortodossia ideologica), dalla frequentazione di dadaisti, surrealisti e situazionisti fino all’influenza esercitata sui movimenti urbani su scala globale.
Ciò spiega perché il suo pensiero e le sue opere sono divenuti strumenti efficaci nelle mani di attivisti e change maker prima ancora che oggetto di dibattito e critica accademica. Il suo linguaggio, erudito e circonvoluto, ha sempre un respiro poetico, rivendica una dimensione poetica che scientemente destabilizza il rigore analitico, eppure risulta rigoroso nella sua ambizione di integrare la dimensione poetica e quella epistemologica.