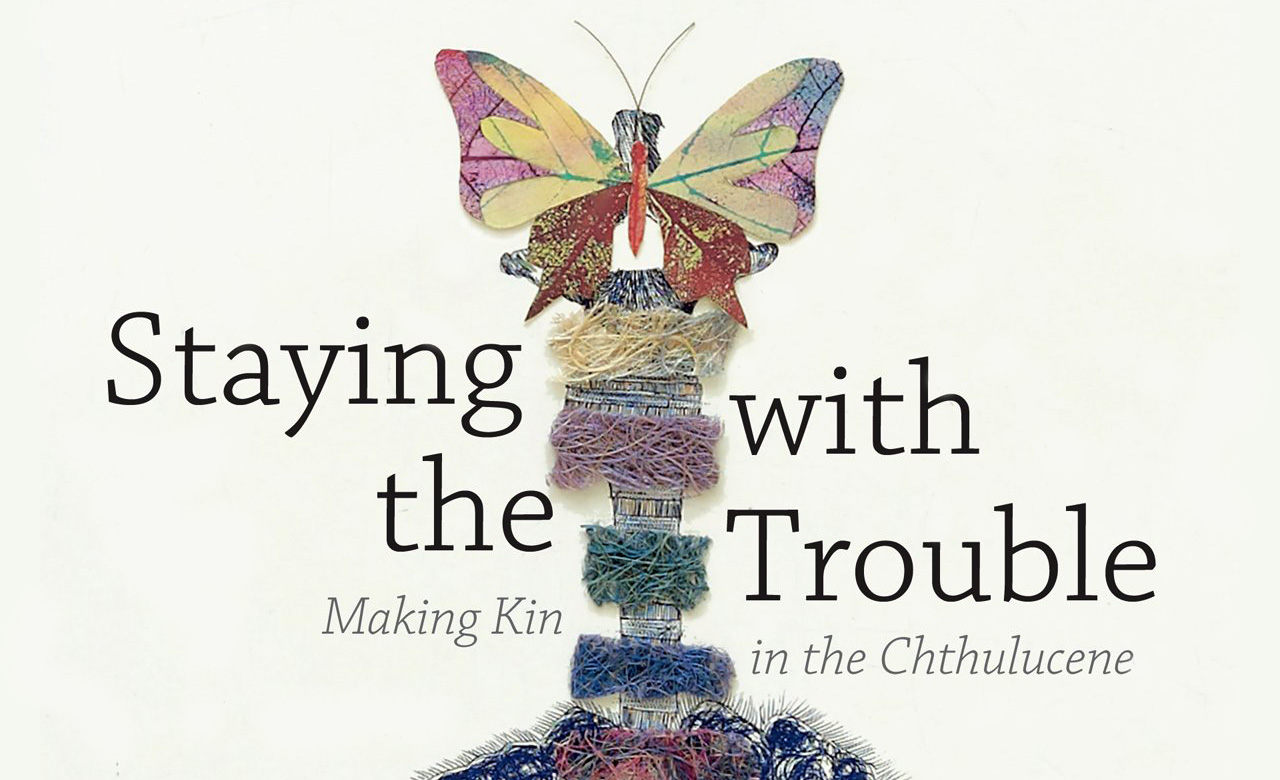Pubblichiamo un estratto dal libro Chthulucene, di Donna Haraway, edito da Nero Edition nella collana Not. Ringraziamo l’editore per la possibilità concessa.
Problema è una parola interessante. Una delle sue varianti inglesi – trouble – rivela dei legami particolari: deriva da troubler, un verbo francese del tredicesimo secolo che significa «rimescolare», «rendere opaco», «disturbare». Ci ritroviamo a vivere sulla Terra in tempi confusi, torbidi e inquieti. L’obiettivo è diventare capaci di articolare una risposta accanto a chi, della nostra specie, è troppo sicuro di sé e del mondo.
Questi tempi confusi e inquieti traboccano di dolore e di gioia, hanno degli schemi ricorrenti e assai ingiusti di dolore e di gioia, in cui assistiamo non solo alla morte cruenta e superflua dell’esistere e del progredire, ma anche a una necessaria rinascita. L’obiettivo è generare parentele – fare kin – attraverso delle connessioni inventive: pratica necessaria per imparare a vivere e a morire bene, l’uno con l’altro, in un presente così denso.
Il nostro compito deve essere fare disordine e creare problemi, scatenare una risposta potente dinanzi a eventi devastanti, ma anche placare le acque tormentate e ricostruire luoghi di quiete. In tempi così critici, molti di noi hanno la tentazione di credere che il problema coincida con la costruzione di un avvenire sicuro, con l’idea di evitare che accada qualche evento che incombe minacciosamente sul domani, con la necessità di sgomberare il passato e il presente in modo da creare futuri per le generazioni a venire.
Per restare a contatto con il problema non è necessario avere un rapporto di questo tipo con quel tempo che di solito chiamiamo «futuro». A dire il vero, restare a contatto con il problema richiede la capacità di essere veramente nel presente, ma non come un evanescente anello di congiunzione tra passati terribili o idilliaci da un lato e futuri salvifici o apocalittici dall’altro: bisogna essere presenti nel mondo in quanto creature mortali interconnesse in una miriade di configurazioni aperte fatte di luoghi, epoche, questioni e significati.
Chthulucene invece è una parola semplice. È composta da due radici greche (khthôn e kainos) che insieme definiscono una tipologia di tempo-spazio utile per imparare a restare a contatto con il vivere e il morire in forma responso-abile su una Terra danneggiata e ferita. Kainos significa ora; è il tempo degli inizi, il tempo per l’esistere e il progredire, per la novità. Niente in kainos ha a che fare con un passato, un presente o un futuro convenzionali.
Non c’è nulla in queste fasi di inizio che pretenda di far piazza pulita di quello che è venuto prima o di quello che viene dopo. Il kainos può essere ricco di eredità, di ricordi, e pieno di arrivi, un modo di nutrire ciò che potrebbe ancora succedere. La parola kainos mi giunge all’orecchio come una presenza densa e perenne, con delle ife che infondono ogni genere di temporalità e materialità.
Le creature ctonie sono esseri della Terra, al contempo antichi e appena nati. Immagino queste creature piene di tentacoli, antenne, dita, cavi, code a frusta, zampe da ragno e chiome arruffate. Le creature ctonie sguazzano nell’humus multispecie, ma non vogliono avere nulla a che fare con l’Homo che se ne sta lì a scrutare il cielo.
Le creature ctonie sono mostri nel senso migliore del termine: dimostrano e performano l’importanza materiale dei processi terrestri e di tutte le creature. E poi dimostrano e performano conseguenze. Le creature ctonie non sono estranee al rischio, non vogliono avere niente a che fare con gli ideologi, non appartengono a nessuno, avvizziscono e prosperano in svariate forme e sotto svariati nomi in tutti i cieli, le acque e i luoghi della Terra. Fanno e disfanno, vengono fatte e disfatte. Sono quelle che sono.
Non è un caso che i più grandi monoteismi al mondo – che siano religiosi o laici – abbiano sempre cercato di sterminare le creature ctonie. Questi tempi osceni che vanno sotto il nome di Antropocene e di Capitalocene sono la configurazione più recente e pericolosa di tali forze distruttrici. Con-vivere e con-morire insieme all’altro nello Chthulucene può essere una risposta impetuosa ai dettami dell’Antropos e del Capitale.
Il kin, la parentela, è una categoria selvaggia che in tanti provano a addomesticare. Generare parentele in maniera imprevedibile e imprevista, invece che imparentarsi con una divinità o una famiglia biogenetica o genealogica (o quantomeno generare altre parentele oltre queste), pone dei problemi importanti, per esempio il problema di verso chi si è davvero responsabili.
Chi vive e chi muore, e come lo fa, in questa parentela o in quest’altra? Che forma ha questa parentela? Dove e a chi si connettono e disconnettono le sue linee, e cosa cambia? Cosa deve essere reciso e cosa deve essere legato affinché la multispecie che abbonda sulla Terra – inclusi gli esseri umani e gli esseri altro-dagli-umani, stretti in legami di parentela – possano avere una possibilità?
L’acronimo FS è una figura onnipresente in questo libro, e sta per fantascienza, fabula speculativa, femminismo speculativo e fatto scientifico. Questa lista serpeggia e torna ripetutamente nelle prossime pagine sotto forma di parole o di immagini, intrecciando me e i miei lettori per trasformarci negli esseri e nei modelli in gioco.
I fatti scientifici e la fabula speculativa hanno bisogno gli uni dell’altra, ed entrambi hanno bisogno del femminismo speculativo. Penso alla categoria FS e alle figure di filo come tre modi di figurare.
Il primo consiste nel tirare i fili che si trovano dentro a pratiche ed eventi raggrumati e densi. Quando tiro fuori questi fili lo faccio per vedere dove mi portano, in modo da ricostruirne il percorso e rintracciarne i nodi e gli schemi cruciali per restare a contatto con il problema in tempi e luoghi reali e particolari. In questo senso, la categoria di FS rappresenta un metodo per tracciare e seguire una trama nel buio, all’interno di un racconto d’avventura pericoloso e reale, in cui diventa più facile capire chi vive e chi muore e come muore, e questo ci aiuta a coltivare la giustizia multispecie.
Nel secondo, la figura di filo che emerge nel gioco della matassa non coincide con il tracciamento, quanto piuttosto con la cosa in sé, il modello e l’assemblaggio che sollecita una risposta, la cosa che non è finita e che bisogna portare avanti.
Nel terzo, creare delle figure di filo all’interno del gioco significa passare e ricevere, fare e disfare, scegliere dei fili oppure lasciarli perdere. La categoria FS rappresenta una pratica e un processo, è il con-divenire l’uno insieme all’altro in una staffetta sorprendente; è una figura che definisce l’esistere e il progredire nello Chthulucene.
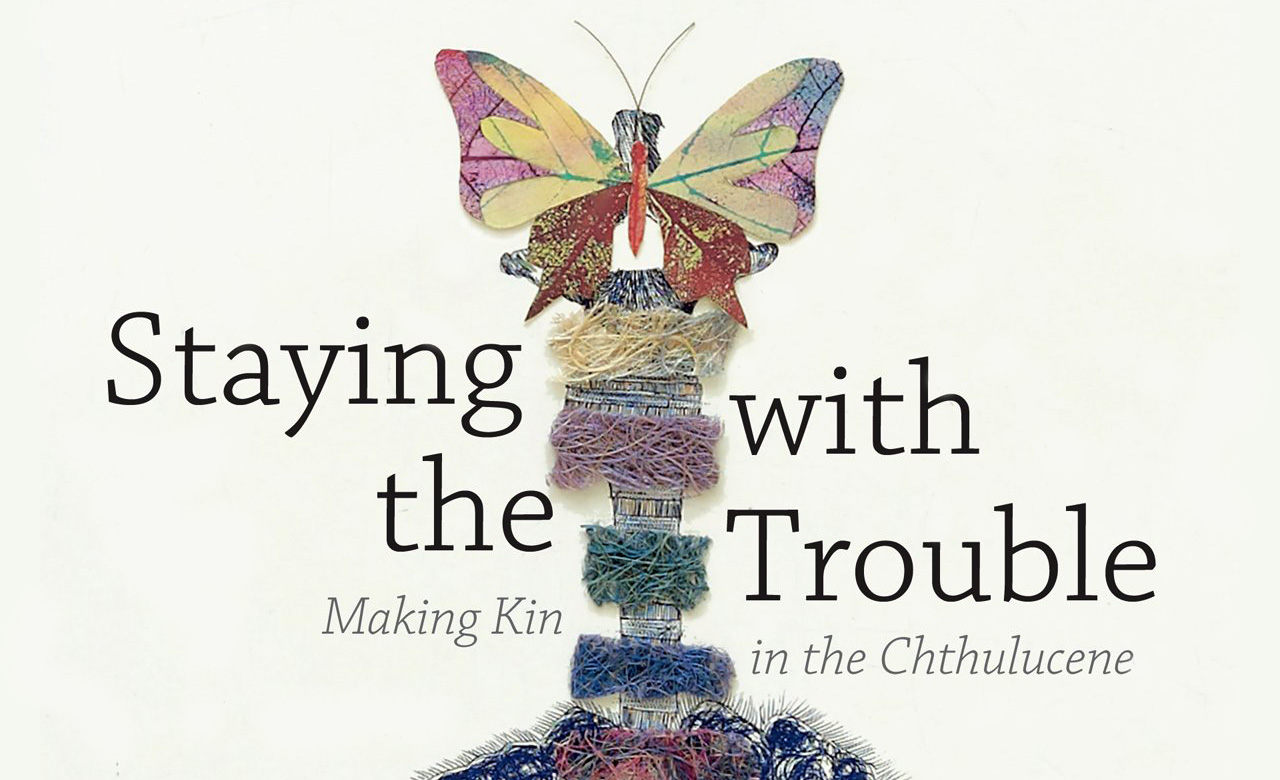
Questo libro e l’idea di «restare a contatto con il problema» sono particolarmente insofferenti verso due tipi di risposta che sento evocare troppo spesso dinanzi agli orrori dell’Antropocene e del Capitalocene.
La prima è semplice da descrivere e anche da liquidare. Per farla breve, è la fede comica nella tecnologia riparatrice, che sia laica o religiosa: la tecnologia in qualche modo trarrà in salvo i suoi figli disobbedienti ma molto intelligenti. Oppure Dio trarrà in salvo i suoi figli disobbedienti ma sempre pieni di speranza.
Dinanzi a un’ingenuità così commovente verso le riparazioni offerte dalla tecnologia (o verso le tecno-apocalissi), a volte diventa difficile ricordare che è importante sostenere dei progetti tecnici specifici e le persone che li seguono. Non sono il nostro nemico: queste persone e questi progetti possono essere molto utili per restare a contatto con il problema e generare parentele in maniera imprevista.
La seconda risposta, più difficile da accantonare, forse è ancora più distruttiva: sto parlando di quella posizione secondo la quale i giochi sono già fatti, è troppo tardi, non ha alcun senso cercare di migliorare le cose adesso, o quantomeno non ha senso avere una fiducia attiva l’uno nell’altro, soprattutto nella nostra capacità di lavorare e giocare in favore di un mondo che rinasce.
Alcuni scienziati che conosco hanno la tendenza a esprimere questo amaro cinismo, anche se lavorano sodo per fare la differenza e migliorare le condizioni di vita delle persone e delle altre creature. Persone che si descrivono come teorici e critici culturali o politici progressisti condividono la stessa idea.
Penso che questa strana commistione tra il tenace impegno di energie e capacità finalizzato al prosperare multispecie da un lato e un esplicito atteggiamento disfattista da fine dei giochi che scoraggia tutti, compresi gli studenti, sia favorita da diversi tipi di approccio al futuro. Uno di questi sembra basarsi sull’idea che solo le cose che funzionano sono importanti; o peggio, sull’idea che solo ciò che io e i miei colleghi esperti facciamo per aggiustare le cose se funziona è importante.
Volendo essere più generosi, a volte gli scienziati e gli altri pensatori che si dedicano a leggere e a studiare, gli studiosi che rimestano le acque del pensiero e sono devoti ai problemi che trattano, sanno troppo, e questa conoscenza è ingombrante. O almeno pensiamo di saperne abbastanza da giungere alla conclusione che una vita sulla Terra capace di includere gli esseri umani in maniera sostenibile non sia più possibile, che l’apocalisse sia davvero vicina.
Questo atteggiamento è comprensibilissimo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa sperimentata dal pianeta Terra, mentre le guerre ci divorano, l’estrazione delle risorse procede in maniera sconsiderata e miliardi di persone e altre creature soccombono alla povertà a causa di una cosa chiamata «profitto», «potere» o «Dio». Un disfattismo da fine dei giochi si impone nella burrasca suscitata dal sentimento profondo, e non soltanto dalla consapevolezza, che quasi sicuramente gli esseri umani diventeranno undici miliardi entro il 2100.
Questo numero equivale a una crescita di nove miliardi di persone in 150 anni – dagli anni Cinquanta al 2100 – con delle conseguenze fortemente inique per i ricchi e i poveri – per non parlare dell’enorme disparità di fardelli imposti alla Terra dai ricchi rispetto ai poveri – e delle conseguenze ancora peggiori per tutti gli esseri non-umani in ogni luogo. Ci sono molti altri esempi di realtà disperate e urgenti; le Grandi Accelerazioni a partire dal secondo dopoguerra hanno lasciato il segno sulle rocce, nelle acque, nei cieli e su tutte le creature.
C’è una sottile differenza tra riconoscere la portata e la serietà di questi problemi e soccombere a una futuribilità astratta, con la sua inclinazione alla disperazione suprema e le sue politiche di estrema indifferenza.
[…] quando si respinge questo tipo di atteggiamento rispetto al futuro, si resta a contatto con il problema in maniera più seria e vitale. Restare a contatto con il problema richiede la capacità di generare parentele di natura imprevista. Questo significa aprirsi a collaborazioni e combinazioni inaspettate, essere pronti a far parte di caldi cumuli di compost.
Con-diveniamo insieme, gli uni con gli altri, oppure non diveniamo affatto. Questa semiotica materiale è sempre situata, in qualche luogo e in nessun luogo, è interconnessa e terrena. Quando siamo da soli, con le nostre esperienze e le nostre diverse e distinte capacità, rischiamo di sapere al contempo troppo e troppo poco, e per questo soccombiamo alla disperazione o alla speranza, e nessuna delle due genera un atteggiamento di buon senso.